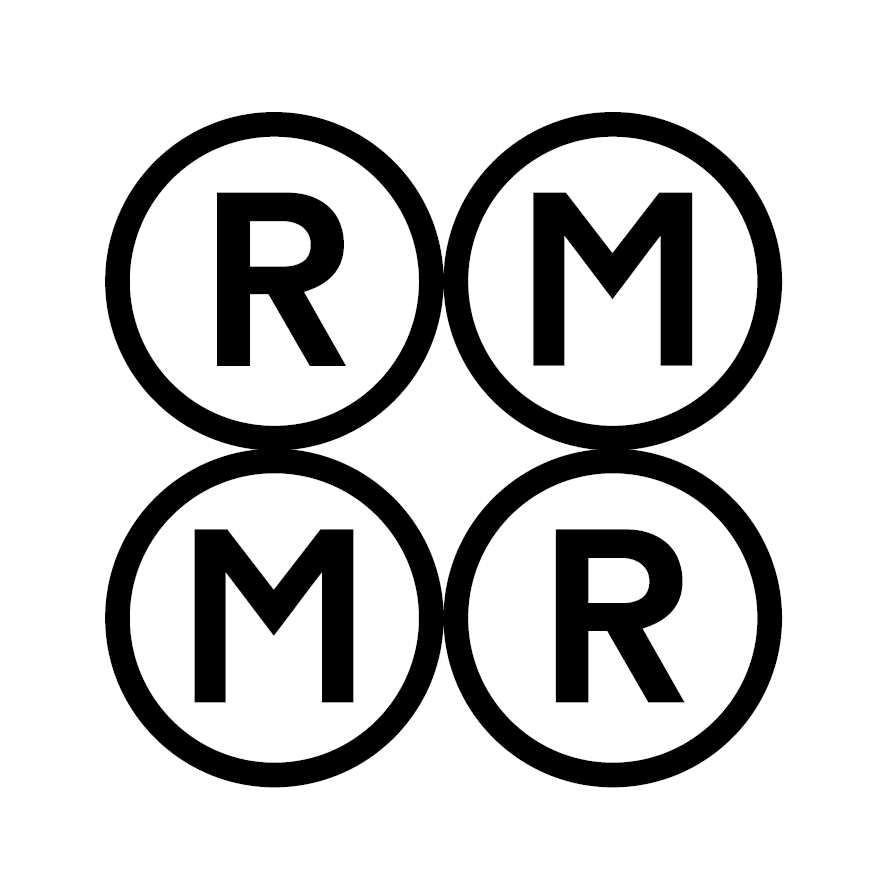Questo articolo è disponibile anche in inglese / This article is also available in English
Negli ultimi anni il dibattito europeo sul ruolo della finanza si è intensificato, complice la necessità di conciliare stabilità economica, transizione ecologica e inclusione sociale. In questo contesto, il 7° Rapporto sulla finanza etica e sostenibile in Europa, pubblicato da Fondazione Finanza Etica, Fundación Finanzas Éticas e FEBEA, offre un quadro preciso: le banche etiche e sostenibili non solo crescono, ma mostrano performance di lungo periodo spesso migliori rispetto agli istituti sistemici sottoposti alla vigilanza diretta della BCE.
Solidità patrimoniale e centralità del credito
Il rapporto, che applica la metodologia CAMEL per valutare i profili di capitale, qualità degli attivi, redditività e liquidità, mette in evidenza come le banche etiche abbiano registrato nel 2022 un Tier 1 ratio (un indicatore di solidità delle banche) medio del 23,32%, contro il 17,23% delle grandi banche sistemiche europee. Un valore che supera di oltre il doppio il requisito minimo di Basilea III (11%) e che testimonia una maggiore capacità di assorbire shock finanziari.
La differenza di modello emerge con forza nella composizione degli attivi: i prestiti rappresentano il 68,84% delle attività totali delle banche etiche, mentre nelle banche sistemiche la quota scende al 51,64%. Al contrario, i grandi istituti privilegiano titoli di stato e strumenti finanziari, più redditizi nel breve periodo ma meno legati all’economia reale. Questa scelta comporta anche un’esposizione più elevata agli attivi ponderati per il rischio: 43,76% per le banche etiche contro il 35,85% delle sistemiche. È tuttavia il segnale di una maggiore aderenza al mandato originario del credito: finanziare famiglie, PMI e imprese sociali.
Crediti deteriorati e gestione responsabile
Sul fronte dei crediti deteriorati, le banche etiche hanno riportato nel 2022 un Non Performing Loan ratio medio del 5,78%, contro il 3,53% delle sistemiche. Tuttavia, depurando i dati dai casi particolari delle cooperative greche ancora segnate dalla crisi del debito sovrano, il tasso medio scende al 3,24%, in linea con la media europea.
La differenza sostanziale non risiede tanto nelle percentuali, quanto nelle strategie adottate. Le banche etiche tendono a evitare la cartolarizzazione e la cessione massiva di NPL a fondi speculativi, preferendo soluzioni di ristrutturazione condivise con i debitori. L’esperienza della Banca Cooperativa di Karditsa in Grecia è emblematica: ha ridotto il proprio tasso di crediti deteriorati sotto il 10% grazie a misure di sospensione dei pagamenti in occasione di eventi straordinari come la tempesta Daniel nel 2023, e ha scelto di assorbire l’aumento dei tassi Euribor senza trasferire integralmente i costi ai clienti.
Al contrario, le banche sistemiche ricorrono frequentemente a operazioni di cartolarizzazione di portafogli miliardari, come il progetto Galaxy di Alpha Bank che nel 2021 ha trasferito 10,8 miliardi di NPL a un veicolo esterno. Se da un lato queste operazioni alleggeriscono i bilanci, dall’altro riducono le possibilità di rinegoziazione per famiglie e imprese, con conseguenze sociali più pesanti.
Redditività e indicatori di gestione
Per quanto riguarda la redditività, nel 2022 le banche sistemiche hanno registrato un Return on Equity medio del 9,18%, a fronte del 5,93% delle banche etiche. Tuttavia, l’analisi storica 2013–2022 mostra che gli istituti etici hanno mantenuto valori positivi e stabili anche in fasi di crisi, con un ROE medio intorno al 5%, mentre le sistemiche hanno alternato picchi e crolli più marcati. Nel 2013, ad esempio, le banche etiche superarono le sistemiche di 5,85 punti percentuali in termini di redditività del capitale.
Il Return on Assets riflette un quadro di maggiore equilibrio: 0,50% per le banche etiche nel 2022, contro 0,65% delle sistemiche, con prestazioni spesso superiori degli istituti etici negli anni precedenti.
Più complesso il dato sul Cost to Income Ratio: 65,74% per le banche etiche, superiore al 52,60% delle sistemiche. Questa apparente inefficienza è in realtà legata al modello operativo. Le banche etiche, infatti, dedicano più risorse a valutazioni qualitative e ambientali sui progetti finanziati, mentre i grandi istituti con una forte esposizione ai mercati finanziari possono generare margini più elevati a fronte di costi relativamente contenuti.
La solidità delle banche etiche emerge anche dagli indicatori di liquidità. Nel 2022 il Loan-to-Deposit Ratio si attestava all’81%, contro il 78% delle sistemiche, posizionandosi esattamente nella fascia ottimale individuata dalla vigilanza europea (80–90%). Nel periodo 2013-2022 le banche etiche hanno mantenuto costantemente un equilibrio tra raccolta e impieghi, evitando gli eccessi osservati in alcuni istituti sistemici che hanno raggiunto valori oltre il 109%, con rischi significativi di liquidità.
In altre parole, gli istituti etici sono riusciti a garantire un flusso stabile di credito all’economia reale senza compromettere la sicurezza dei depositi.
Impatto sociale e ambientale
Accanto agli indicatori economici, il rapporto sottolinea la missione sociale e ambientale delle banche etiche. Con un attivo aggregato di 79,2 miliardi di euro, depositi pari a 61,1 miliardi e impieghi per 58,2 miliardi, i 26 istituti analizzati possono sembrare marginali rispetto alla dimensione del sistema bancario europeo. Eppure, la loro incidenza nei settori finanziati è significativa: energie rinnovabili, edilizia sociale, agricoltura biologica, imprese cooperative e iniziative culturali.
A differenza delle banche sistemiche, che spesso mantengono una quota rilevante di investimenti in settori ad alto impatto climatico, le banche etiche escludono deliberatamente armi e combustibili fossili dai propri portafogli. Inoltre, molte pubblicano la lista completa dei beneficiari dei prestiti e offrono ai risparmiatori la possibilità di orientare le scelte di credito, garantendo un livello di trasparenza unico nel panorama finanziario.
Un modello da integrare
Il messaggio che emerge dal 7° Rapporto sulla finanza etica e sostenibile in Europa è chiaro: le banche etiche hanno dimostrato di coniugare stabilità patrimoniale e impatto sociale, superando in diversi casi i grandi istituti per capacità di resilienza. Il loro modello, basato su trasparenza, partecipazione e radicamento nei territori, rappresenta un laboratorio avanzato di finanza sostenibile.
Tuttavia, permane un ostacolo di natura regolamentare. Le norme europee sono calibrate sui grandi gruppi bancari e rischiano di penalizzare gli istituti etici, che operano con dimensioni ridotte ma perseguono obiettivi strategici in linea con il Green Deal e la neutralità climatica al 2050. Un adeguamento normativo appare indispensabile per consentire a queste realtà di crescere senza snaturarsi.
In definitiva, il futuro della finanza europea non può prescindere dalle lezioni offerte da queste esperienze. Non si tratta più di chiedersi se la finanza etica sia sostenibile, ma se il sistema tradizionale possa continuare a esserlo senza adottarne almeno in parte i principi. La sfida dei prossimi anni sarà tradurre queste buone pratiche in un nuovo standard per l’intero settore bancario, capace di andare davvero “oltre il profitto”.
Leggi anche: Qual è l’impatto della crisi climatica sulle banche? Intervista a Rong Ding
In copertina: immagine Envato