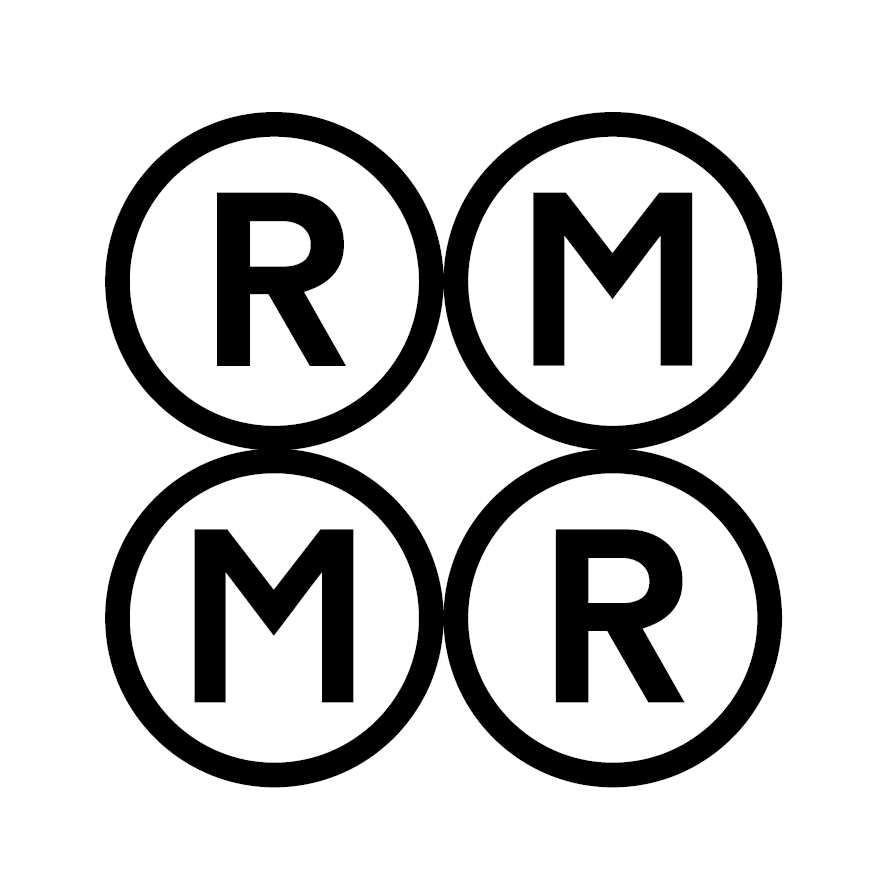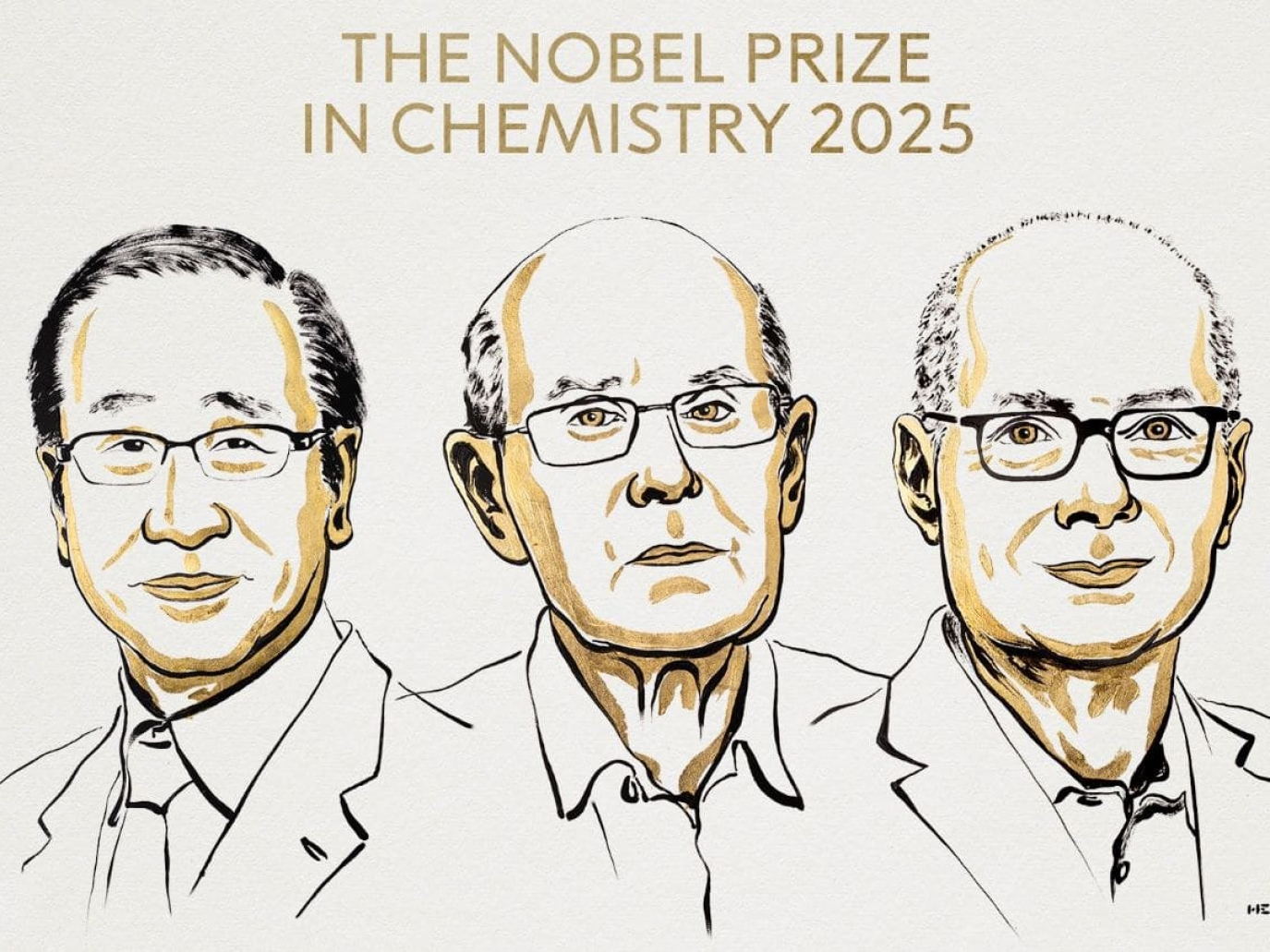Il Premio Nobel per la chimica 2025 riconosce una scoperta che promette di rivoluzionare il modo in cui l’umanità gestisce risorse e inquinamento. Per questo, Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento per aver sviluppato i metal-organic frameworks (MOF), una nuova forma di architettura molecolare basata su cristalli porosi composti da ioni metallici e molecole organiche. Queste strutture, organizzate come reticoli tridimensionali, creano spazi interni attraverso cui possono fluire gas e altre sostanze chimiche, permettendone l’immagazzinamento, la separazione o la trasformazione.
Si tratta di una delle scoperte più promettenti per l’economia circolare e la chimica verde: i MOF possono essere utilizzati per catturare anidride carbonica, stoccare gas tossici, separare contaminanti come i PFAS dall’acqua o catalizzare reazioni chimiche a basso impatto ambientale. “I metal-organic frameworkshanno un potenziale enorme, offrendo opportunità prima impensabili per materiali personalizzati con nuove funzioni”, ha dichiarato Heiner Linke, presidente del Comitato Nobel per la chimica.
Dalle prime intuizioni ai materiali intelligenti
La storia dei MOF comincia nel 1989, quando Richard Robson decise di sperimentare una nuova modalità di utilizzo delle proprietà intrinseche degli atomi. Combinando ioni di rame positivi con una molecola a quattro bracci dotata di gruppi chimici attratti dal rame, ottenne un cristallo spazioso e ordinato, “come un diamante pieno di innumerevoli cavità”. Nonostante l’intuizione fosse rivoluzionaria, la struttura risultava instabile e tendeva a collassare.
Negli anni successivi, tra il 1992 e il 2003, Susumu Kitagawa e Omar Yaghi diedero solidità teorica e pratica a quell’idea. Kitagawa dimostrò che i gas potevano fluire dentro e fuori dalle strutture e predisse la possibilità di realizzare MOF flessibili, capaci di adattarsi a diverse condizioni ambientali. Yaghi, invece, riuscì a creare un MOF estremamente stabile e modificabile attraverso il rational design, una metodologia che consente di controllare la composizione e le proprietà dei materiali in modo predeterminato. Grazie a questi progressi, la chimica dei materiali entrò in una nuova era, in cui la progettazione molecolare diventava strumento di ingegneria ambientale.
Oggi esistono decine di migliaia di MOF diversi, ognuno con caratteristiche specifiche: alcuni vantano superfici interne superiori a 7.000 metri quadrati per grammo di materiale. Questa enorme area di contatto consente un’efficienza senza precedenti nell’assorbimento di gas o impurità, rendendoli strumenti chiave per le tecnologie di cattura e stoccaggio della CO₂ e per la purificazione dell’aria e dell’acqua.
Applicazioni dei MOF per la sostenibilità globale
Le potenzialità dei MOF si estendono a numerosi settori strategici. In campo ambientale, questi materiali sono già sperimentati per la cattura dell’anidride carbonica prodotta da centrali e industrie, con efficienze di assorbimento fino a cinque volte superiori rispetto agli attuali sistemi di filtrazione. Alcuni MOF vengono utilizzati per la rimozione dei forever chemicals (PFAS) dall’acqua potabile, un problema di salute pubblica che interessa milioni di persone. Altri ancora possono catalizzare reazioni chimiche con un consumo energetico ridotto fino al 40%, contribuendo alla decarbonizzazione del comparto industriale.
Tra le applicazioni più visionarie vi è la capacità di “estrarre” acqua dall’aria in ambienti desertici: grazie alla loro struttura iperporosa, alcuni MOF assorbono l’umidità notturna e rilasciano acqua dolce durante il giorno, semplicemente con il calore del sole. Questa tecnologia, in fase di sviluppo, potrebbe fornire una risposta concreta alla scarsità idrica in regioni aride del pianeta.
Oltre al settore ambientale, i MOF stanno trovando applicazione anche nell’elettronica e nell’energia. La loro capacità di condurre elettricità li rende candidati ideali per l’immagazzinamento di idrogeno o per lo sviluppo di batterie di nuova generazione, più leggere e sostenibili.
Dalla ricerca alla transizione ecologica
Il Nobel 2025 a Kitagawa, Robson e Yaghi non premia solo un traguardo scientifico, ma una visione: quella di una chimica capace di rispondere concretamente alle sfide climatiche e industriali del Ventunesimo secolo. I metal-organic frameworks rappresentano oggi una piattaforma tecnologica su cui si fondano nuove strategie per la neutralità carbonica e la gestione sostenibile delle risorse.
Dalle prime prove di laboratorio degli anni Ottanta alle attuali applicazioni industriali, i MOF hanno percorso una traiettoria di sviluppo che unisce ricerca pura, innovazione tecnologica e impatto ambientale. Il Nobel per la chimica 2025 segna dunque non solo un riconoscimento accademico, ma anche una prospettiva di futuro: quella in cui la scienza dei materiali diventa alleata della sostenibilità, trasformando l’invisibile architettura delle molecole in un pilastro della transizione ecologica.
In copertina: illustrazione di Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach