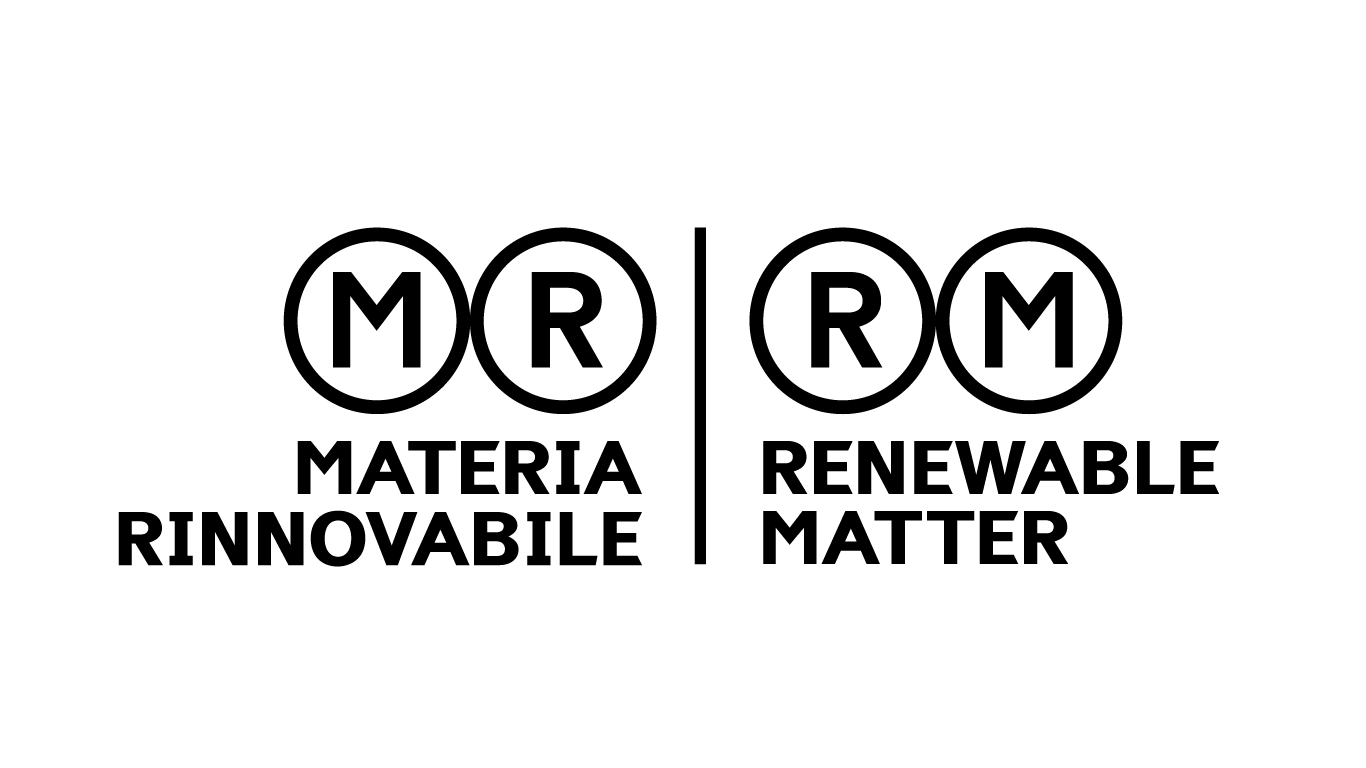Questo articolo fa parte del canale tematico The Carbon Observer. Iscriviti alla newsletter o aggiorna le tue preferenze.
Di fronte alle crisi ambientale, sociale ed economica che stiamo vivendo in questa fase storica, la sostenibilità tradizionale, intesa come mitigazione degli impatti in conformità a determinati standard, non è più sufficiente. Non basta compensare i danni, continuando a produrre come prima, ma bisogna cambiare il modo in cui produciamo valore attraverso soluzioni trasformative. Per questo si parla sempre più spesso di imprese rigenerative, capaci di contribuire attivamente al rinnovamento degli ecosistemi, rafforzando al tempo stesso le comunità e le economie.
In tale direzione si inserisce anche il carbon insetting, una strategia di riduzione, prevenzione o assorbimento delle emissioni di gas serra legate alla value chain di un’impresa, in grado di generare benefici ambientali e anche sociali.
Come funziona il carbon insetting
Anziché intervenire sulle emissioni dirette generate dall’azienda (Scope 1) e su quelle legate all’energia acquistata (Scope 2), quindi, il carbon insetting agisce sulle emissioni indirette lungo la catena del valore (Scope 3), dall’approvvigionamento delle materie prime alla gestione del fine vita dei prodotti. Queste sono in genere le più difficili da ridurre e allo stesso tempo le più importanti, dato che spesso rappresentano la quota più rilevante dell’impronta climatica complessiva di un’impresa. Due sono le azioni possibili: carbon avoidance, ovvero la prevenzione delle future emissioni, e carbon removal, che consiste nella rimozione e nel sequestro della CO₂ dall’atmosfera tramite Nature-Based Solutions nell’ambito dei territori che rientrano nella filiera.
“Va precisato che il carbon insetting comprende due diverse tipologie di interventi”, spiega a Materia Rinnovabile Michele Rumiz, senior regional manager presso Carbonsink. “Oltre alle attività legate specificamente alle emissioni Scope 3, che fanno aumentare in modo diretto la resilienza della filiera, ci sono anche le attività che rafforzano la filiera in modo indiretto, attraverso la tutela e la valorizzazione del cosiddetto production landscape, ovvero un’area più ampia, legata ad attività economiche come agricoltura, allevamento, silvicoltura e pesca.”
Per esempio, fare carbon insetting nel settore agroalimentare significa investire in agricoltura rigenerativa presso i propri fornitori, aumentando la capacità del terreno di sequestrare carbonio, attraverso pratiche come rotazione delle colture, riduzione dei fertilizzanti chimici, aumento della sostanza organica nei suoli, contribuendo anche al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche degli agricoltori da cui ci si rifornisce. “In questo caso si agisce direttamente sulle Scope 3”, spiega Rumiz. “Se invece si interviene in modo più generale sul contesto naturale in cui le coltivazioni si inseriscono, migliorando la biodiversità locale oppure la resilienza idrica del territorio, allora il carbon insetting riguarda il production landscape.”
Nell’industria manifatturiera il carbon insetting può tradursi invece nel supporto ai fornitori per il passaggio a energie rinnovabili, nell’adozione di materiali a minore intensità carbonica o nell’efficientamento dei processi produttivi.
Guardando a casi concreti, LVMH promuove pratiche di agricoltura rigenerativa nelle sue catene di approvvigionamento strategiche, mentre Burberry ha avviato un progetto simile con alcuni produttori di lana in Australia. Nespresso, in collaborazione con il partner Pur Projet, realizza progetti nature-based sia all'interno sia nei dintorni delle piantagioni di caffè in vari paesi.
L’offsetting compensa, l’insetting trasforma
Le pratiche di carbon insetting sono oggi al centro dell’attenzione, anche in contrapposizione alle critiche sempre più frequenti mosse al carbon offsetting, finora molto più diffuso. La differenza è sostanziale: se nel primo caso l’impresa investe in azioni che modificano processi produttivi, filiere di approvvigionamento e modelli organizzativi, nel secondo finanzia invece progetti esterni, che non incidono sulle proprie emissioni strutturali. Anzi, sono spesso scollegati dal core business aziendale, seguendo quella logica semplicemente riparativa che oggi non basta più.
L’esempio classico è l’acquisto di crediti di carbonio che supportano la riforestazione in altri continenti oppure il sostegno allo sviluppo di energie rinnovabili in paesi emergenti. Di conseguenza molte pratiche vengono criticate per scarsa tracciabilità, rischio di greenwashing e addizionalità incerta, cioè difficoltà nel dimostrare con certezza che la riduzione di emissioni ottenuta sia effettivamente legata all’investimento aziendale.
Le direttive: CRCF e carbon farming
Oltre a questo, l’interesse verso il carbon insetting sta aumentando per altri motivi. Innanzitutto le nuove direttive europee, come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che chiedono alle imprese di rendicontare in modo sempre più dettagliato le emissioni lungo tutta la value chain, incluse le Scope 3. È vero che il 2025 si è chiuso con un ridimensionamento delle normative in questo campo − vedi l’approvazione definitiva del pacchetto Omnibus I da parte del Parlamento europeo − ma l’importanza della rendicontazione non finanziaria resta.
“A livello legislativo c’è molto fermento, con un dibattito in costante evoluzione, soprattutto attorno alle attività di carbon removal: bisogna stabilire come verificarle e in che misura possono tornare utili le metodologie di calcolo esistenti per certificare i crediti di carbonio”, prosegue Rumiz.
Su questi aspetti sta lavorando l’UE, che, con la Carbon Removals and Carbon Farming Regulation (CRCF), si sta orientando verso il riconoscimento delle carbon farming units a fini di scopo 3, dunque al loro utilizzo per affrontare le emissioni value-chain, a condizione che siano generate da progetti coerenti con la propria filiera.
“Un nodo centrale nel dibattito globale riguarda il legame tra rimozioni e filiera”, aggiunge Rumiz. “Finora molti approcci all’insetting richiedevano una corrispondenza diretta e dimostrabile, con una logica rigorosa, ma difficile da applicare su larga scala. Oggi si sta affermando invece il concetto di supply shed, ovvero l’area geografica di approvvigionamento di un’impresa. In questa prospettiva, sostenere iniziative di carbon farming all’interno delle regioni da cui provengono le materie prime potrebbe diventare sufficiente per rivendicare un miglioramento dell’impronta climatica, anche senza un legame uno-a-uno tra singolo fornitore e singola rimozione.”
Per esempio, Boortmalt, società globale nel settore del malto, in collaborazione con il colosso mondiale della chimica BASF, sta realizzando un progetto di agricoltura rigenerativa con un gruppo di produttori di orzo in Irlanda, il cui impatto (removals e avoidance) è stato certificato, ed è stato possibile tradurlo in una riduzione delle emissioni legate alla produzione di orzo della propria filiera di quasi il 90%. “Questa maggiore flessibilità non è un allentamento dei criteri ambientali, ma una condizione necessaria per rendere il carbon farming economicamente scalabile”, sottolinea ancora Rumiz.
Proprio in tale direzione sembra muoversi il GHG protocol, che qualche giorno fa ha pubblicato la nuova (e a lungo attesa) Land Sector Removal Guidance, che introduce una nuova metodologia coerente per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti per quanto riguarda l'agricoltura e l'uso del suolo.
Generare valore oltre il carbonio
Al di là degli obblighi di legge, comunque, sta aumentando la pressione generale di investitori e stakeholder per strategie climatiche credibili, basate su riduzioni reali e verificabili. Come conferma l’ESG Outlook 2025 di CRIF, osservatorio annuale della Centrale rischi di intermediazione finanziaria, il sistema bancario premia con maggior credito chi investe in pratiche e modelli di business sostenibili: nel 2024 il 76% dei finanziamenti verso le grandi imprese ha riguardato aziende con un’elevata adeguatezza ESG, con un aumento di oltre 20 punti percentuali rispetto al 2023, una tendenza che si emerge anche tra le PMI.
Il carbon insetting viene associato a una visione di sostenibilità forte, perché non separa ambiente, economia e società, ma integra la decarbonizzazione nel modello di business. Fare carbon insetting non è però semplice: richiede investimenti iniziali più elevati, implica una stretta collaborazione con i fornitori e, come anticipato, è complesso da misurare e non sempre facilmente standardizzabile. Nell’odierno mercato del carbonio è una pratica meno normata a livello tecnico rispetto a quanto non sia il carbon offsetting, che è invece stato da tempo oggetto di numerosi standard tecnici, metodologie, registri.
Inoltre, le soluzioni nature-based producono risultati intrinsecamente variabili, aumentando il delivery risk dei progetti. Per le imprese, però, è fondamentale occuparsi anche di natura: oltre il 50% del PIL globale è esposto a rischi legati al degrado degli ecosistemi, e rigenerarli significa rigenerare anche l'economia, come è emerso durante la tavola rotonda Business Roundtable for Climate & Nature, organizzata da SDA Bocconi School of Management.
In uno scenario in rapida evoluzione, la soluzione verso cui molte realtà si stanno muovendo attualmente è quella di elaborare strategie ibride: l’insetting sta diventando sempre più la priorità, in direzione di una reale riduzione delle emissioni, mentre l’offsetting è destinato a diventare uno strumento residuale, utilizzato per le emissioni che non possono essere eliminate nel breve periodo oppure per le quote hard-to-abate, per le quali rimane sensato acquistare crediti di carbonio e programmare attività di compensazione, che siano comunque il più possibile trasparenti, tracciabili e verificabili.
In copertina: immagine Envato