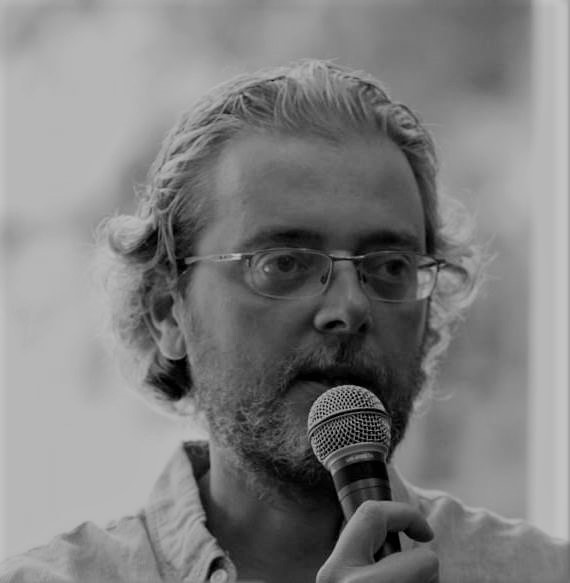Dalle grandi metropoli alle località di mare, dai villaggi di montagna ai borghi storici, la scritta Tourists go home sta diventando uno dei graffiti più diffusi sulle facciate degli edifici europei. L’insofferenza verso l’overtourism che si era già manifestata a livello locale nelle ultime due estati, sta diventando una galassia di attivismo che presenta molte affinità con i movimenti ecologisti e no global del passato più o meno recente.
Il paese nel quale le proteste sono state più accese è la Spagna che, con 84 milioni di visitatori internazionali, nel 2024 è stata la seconda meta su scala globale dopo la vicina Francia che lo scorso anno ha accolto 89 milioni di persone. A Barcellona, nelle isole Canarie e Baleari, a Granada e a San Sebastián, i manifestanti si sono riversati nelle strade per rivendicare il diritto a un’abitazione a prezzi accessibili per i residenti, per criticare i sussidi al settore turistico e per richiedere migliori condizioni di lavoro per chi opera nel settore.
Proteste analoghe sono andate in scena a Venezia, Genova, Palermo, Milano e Napoli, nelle isole greche e a Lisbona, uno dei luoghi simbolo della gentrificazione nelle aree metropolitane. La contestazione ha assunto le forme più svariate, dai getti delle pistole ad acqua alle sostituzioni delle keybox con cappelli alla Robin Hood.
Overtourism a Barcellona, la politica della Spagna contro gli affitti brevi
Barcellona, metropoli che ha visto scendere in piazza contro l’overtourism oltre 600 persone, è un interessante caso di studio. Sono passati oltre tre decenni dai Giochi Olimpici che hanno rinnovato il tessuto urbano e l’immagine del capoluogo catalano, accendendo i riflettori sulle sue attrazioni turistiche.
Dopo lo stop del biennio 2020-2021 dovuto al Covid-19 e la lenta e graduale ricostruzione delle stagioni successive, nel 2024 Barcellona ha accolto 15,5 milioni di persone, una cifra non molto distante dai 16,1 milioni dell’ultimo anno pre-pandemico, il 2019. Fra i dati di un recente report dell’Osservatorio del turismo a Barcellona si scopre come il costo medio giornaliero per persona sia aumentato del 262,5% dal 2020 al 2024, passando da 35,13 euro a 92,22 euro.
L’aumento dei prezzi per la collettività, la scomparsa degli affitti brevi e la sostituzione dei servizi per i residenti con quelli per gli ospiti sono soltanto la punta dell’iceberg di un fenomeno che ha un impatto devastante su chi vive in una località turistica. A Barcellona risiedono 1,6 milioni di persone. Il conto è presto fatto: lo scorso anno la ratio residenti/visitatori è stata di 1 a 10. Un tale squilibrio non può che compromettere la capacità di carico, ovvero quella soglia di attività turistica oltre la quale le strutture sono sature, l’ambiente inizia a degradarsi e il godimento del visitatore è pregiudicato.
Ma perché le proteste si concentrano nei paesi dell’Europa Meridionale? “Lungi da me difendere le piattaforme, ma non è tutta colpa di Airbnb”, spiega Cristina Nadotti, autrice del saggio Il turismo che non paga. “Se nel Nord Europa non ci sono proteste è perché sono state fatte delle politiche abitative. In Italia e Spagna per anni sono state trascurate le esigenze di chi non poteva permettersi l’acquisto di una casa. Sono passati quasi cinquant’anni dalla legge sull’equo canone.”
A Barcellona, il sindaco Jaume Collboni ha proposto l’aumento della tassa di soggiorno da 3,25 a 4 euro a notte (in attesa dell’approvazione della Generalitat de Catalunya) e ha previsto di revocare entro il 2028 le licenze di oltre 10.000 abitazioni utilizzate per gli affitti a breve termine. Fra il 2014 e il 2024, Barcellona ha assistito a un aumento degli affitti del 70%, questo a fronte di un aumento dei salari del 16,4% nello stesso periodo.
A Madrid, lo scorso mese di marzo, il Ministero per diritti sociali, consumo e agenda 2030 ha identificato ben 15.200 appartamenti turistici illegali a fronte di 1.131 licenze rilasciate per affitti brevi legali, attivando le autorità per sanzionare i trasgressori. Lo stesso ministero ha poi ordinato ad Airbnb di bloccare 65.000 annunci ritenuti illegali. Recentemente un tribunale della capitale spagnola ha ordinato la chiusura di dieci appartamenti turistici all’interno di un singolo palazzo dopo il reclamo di una delle poche famiglie residenti rimaste nell’edificio, perché il chiasso e i comportamenti molesti dei turisti ledevano i suoi diritti fondamentali.
Anche Lisbona sta correndo ai ripari dopo un boom turistico che negli ultimi quindici anni ha cambiato il volto della città. Si stima che nella capitale portoghese vi siano circa 20.000 appartamenti dedicati agli affitti brevi. Il boom turistico ha avuto conseguenze importanti sulla vita dei residenti: se nel giugno 2015 l’affitto medio a Lisbona era di 6,7 euro al mq, nel giugno 2025 è stato di 20,3 euro al mq, con un incremento del 203% in un decennio. Lo scorso dicembre l’Assemblea municipale lisbonese ha approvato lo svolgimento di un referendum che – qualora dovesse superare tutti i passaggi legali e di costituzionalità – potrebbe portare all’abolizione degli affitti turistici negli appartamenti residenziali.
Leggi anche: Grosseto: la Green Pioneer che ha incantato l’Europa
Le iniziative italiane per limitare l’overtourism
E in Italia? A livello nazionale, la norma più rilevante per regolamentare gli affitti brevi e le strutture turistico-ricettive è il Codice identificativo nazionale (CIN), un codice alfanumerico univoco studiato per contrastare l’abusivismo, per garantire la sicurezza della ricettività e per consentire un monitoraggio e una raccolta dati utili per le politiche turistiche.
Le iniziative più concrete sono nate a livello locale. “Molto spesso le leggi regionali e le iniziative comunali tese a limitare gli affitti brevi vengono poi impugnate a livello nazionale”, continua Nadotti. “Questo perché uno dei cardini del Piano strategico del turismo 2023-2027 è l’uniformazione. In realtà i sindaci avrebbero bisogno di più autonomia poiché se è vero che esistono problemi comuni, è altrettanto evidente che ciascuna località ha le proprie peculiarità.”
Nel 2023 Firenze ha attirato 5,3 milioni di visitatori, con una percentuale del 76,7% di stranieri. Le strutture alberghiere hanno intercettato il 41,1% dei visitatori, mentre il 58,9% ha optato per le strutture extralberghiere. Lo scorso 31 maggio è entrato in vigore il regolamento per le locazioni turistiche brevi che definisce come gli affitti brevi siano consentiti “esclusivamente in immobili aventi le caratteristiche della civile abitazione” e subordinati “al rilascio al proprietario dell’immobile di un’autorizzazione di durata quinquennale, per ciascuna unità immobiliare che si intende locare”.
Il comune di Venezia ha approvato un regolamento per la locazione turistica articolato in due opzioni: la Base (limitata a 120 giorni, con comunicazione preventiva dei giorni di locazione) e la Premium (valida 365 giorni l’anno con obblighi specifici come l'iscrizione a un registro comunale, reperibilità H24, check-in in presenza, fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata).
Per bilanciare le esigenze dell’anno giubilare con la tutela della residenzialità, nel 2025 il comune di Roma ha stabilito alcune restrizioni: un limite di 120 giorni all'anno per gli affitti brevi senza vincoli aggiuntivi, il divieto di key box su beni pubblici e storici, la proibizione del cambio di destinazione d'uso per trasformare uffici, magazzini o garage in case vacanza, forti limitazioni alla ricettività nel centro storico.
Matteo Sarzana, Country Manager per l'Italia e l’Europa Sud-Orientale di Airbnb, invita a prendere in considerazione la crescita di tutti i comparti del settore e sottolinea come la piattaforma giochi un ruolo chiave nella ridistribuzione dei flussi turistici, portando l'ospitalità anche nelle aree rurali e in località al di fuori dei circuiti tradizionali: “Quando si parla di overtourism, è fondamentale adottare una visione complessiva del fenomeno. Ryanair ha superato i 200 milioni di passeggeri nel 2024. In Europa nel 2023 e nel 2024 gli hotel hanno rappresentato quasi l’80% dei pernottamenti. Airbnb sta invece contribuendo a distribuire il turismo verso le aree rurali: metà dei nostri soggiorni avviene lontano dai grandi centri. Chiaramente, riconosciamo le sfide legate al sovraffollamento turistico nei centri storici di città come Firenze, Roma o Venezia, e sosteniamo la richiesta di un quadro normativo nazionale per gli affitti brevi basato su dati, differenziando la piccola proprietà privata dai professionisti”.
Smarcarsi dalla monosettorialità
Come un luogo turistico può trovare il punto d’equilibrio fra l’occupazione della propria forza lavoro e le condizioni di vita dei suoi residenti? “La programmazione deve coinvolgere la comunità, ma soprattutto non deve pensare al turismo come l’unico settore economico per generare posti di lavoro”, conclude Nadotti. “Dal punto di vista sociale, questa pianificazione non può piovere dall’alto, con forze imprenditoriali che edificano hotel e resort, ma deve nascere da chi in quel luogo ci abita. Bisogna smettere di pensare che più gente arriva meglio è. Non funziona così. Bisogna darsi dei limiti, perché quando questi vengono superati i servizi essenziali vanno in crisi: dal diritto alla casa alle infrastrutture viarie, dai pronto soccorso agli equilibri ambientali. Perché è questo che fa il turismo: evidenziare tutte quelle che sono le criticità del nostro socioeconomico: sanità, trasporti, politiche abitative e ambientali.”
Leggi anche: Overtourism, una lezione dal Canada
In copertina: foto di Levi Van Leeuwen, Unsplash