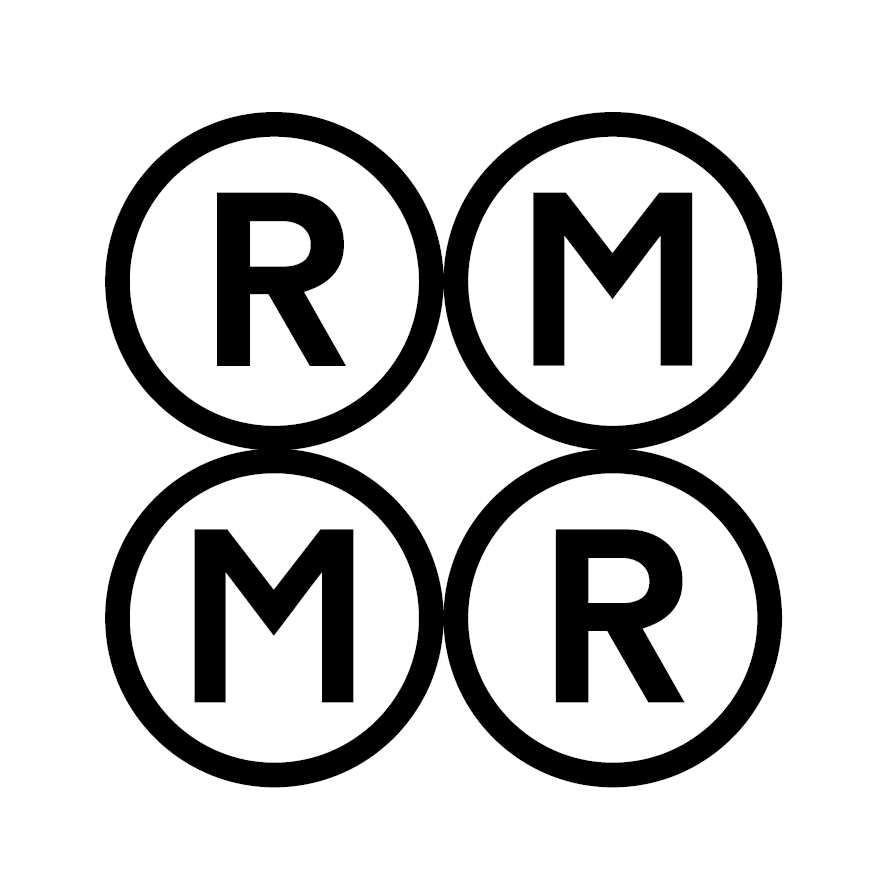Nel 2024 in Italia è stato infranto un muro simbolico e inquietante: 40.590 reati contro l’ambiente, in aumento del 14,4% rispetto al 2023. Significa 111,2 illeciti al giorno, 4,6 ogni ora. Crescono anche le persone denunciate, 37.186 (+7,8%), mentre il giro d’affari delle ecomafie raggiunge 9,3 miliardi di euro, mezzo miliardo in più in dodici mesi. Undici i clan criminali aggiuntivi censiti rispetto al precedente rapporto.
È il quadro tracciato da Legambiente nel nuovo rapporto Ecomafia 2025. I numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, presentato a Roma e dedicato al trentennale della scomparsa del Capitano di Fregata Natale De Grazia, figura simbolo delle indagini sui traffici di rifiuti via mare.
Corruzione ambientale in crescita
La pressione criminale non riguarda solo reati diretti, ma anche la cattura dei processi decisionali pubblici. Dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025 Legambiente ha censito 88 inchieste per tangenti “green”, il 17,3% in più dell’anno precedente. Le persone denunciate sono 862, in aumento del 72,4%.
Le indagini spaziano dalla realizzazione di opere pubbliche alla gestione dei servizi ambientali – rifiuti urbani, depurazione – fino al rilascio di autorizzazioni alle imprese. Il 46,6% delle inchieste si concentra nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, ma il fenomeno è ormai nazionale: Campania prima con 17 procedimenti, seguita da Lombardia (16), Puglia (10), poi Sicilia, Lazio (8) e Calabria (6). In termini di arresti prima è la Puglia (96), poi Campania (77) e Lombardia (61). Per numero di denunciati primeggia il Lazio (154). Dal 2010 si contano 1.560 inchieste cumulative, 9.133 arresti, 12.374 denunciati e 2.532 sequestri.
Dove colpiscono le ecomafie: cemento, rifiuti, fauna, patrimonio culturale
Un terzo di tutti i reati ambientali italiani è legato alla filiera del cemento: abusivismo edilizio, cave illegali, appalti truccati. Nel 2024 gli illeciti accertati in questo comparto sono 13.621 (+4,7%), pari al 33,6% del totale. Segue il ciclo illegale dei rifiuti, la componente in più rapida crescita con 11.166 reati (+19,9%). I crimini contro gli animali raggiungono quota 7.222 (+9,7%). In forte balzo anche i reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico: 2.956 episodi, +23,4%, tra scavi clandestini, ricettazione di reperti e danneggiamenti al paesaggio.
Nel settore agroalimentare, nonostante un lieve calo dei controlli (-2,7%), aumentano reati e illeciti amministrativi (+2,9%) e crescono gli arresti (+11,3%). A corredo, gli illeciti amministrativi ambientali totali toccano 69.949 (+9,4%), pari a 191,6 al giorno.
La geografia dei reati ambientali in Italia
Il 42,6% dei reati ambientali italiani si concentra nelle quattro regioni a storica presenza mafiosa: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. La Campania guida con 6.104 illeciti penali (15% del totale nazionale), 5.580 persone denunciate, 1.431 sequestri e 50 arresti. La Puglia sorpassa la Sicilia e risale al secondo posto con 4.146 reati (10,2%) e il primato degli arresti (69). Terza la Sicilia (9,4%), quarta la Calabria, che cresce nei reati (3.215) e più che raddoppia gli arresti (41). Il Lazio sale al quinto posto con 2.654 reati (+20,6%), davanti alla Toscana, anch’essa in aumento (+11,6%). Sardegna settima (2.364, +13,9%). La prima regione del Nord è la Lombardia, ottava con 2.324 reati (+17,7%), seguita dal Veneto (1.823, +3,5%).
A livello provinciale Napoli resta in testa con 2.313 reati. Bari sale al secondo posto (1.526), seguita da Salerno (1.321). Roma è quarta (1.021) e terza per illeciti amministrativi (1.316). Cosenza risale quinta (963), Avellino scende sesta (906). Entrano in top ten Genova (ottava, 723) e Ancona (decima, 704). Tra le prime venti salgono anche Cagliari, Perugia, Crotone, Catanzaro e Brescia.
L’analisi territoriale conferma che la pressione resta altissima nel Mezzogiorno ma l’illegalità ambientale è ormai capillare. “I dati di Ecomafia e gli straordinari contributi di analisi elaborati da tutte le forze dell’ordine, dalla Direzione investigativa antimafia, dalle Capitanerie di porto, dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli e dall’ISPRA testimoniano, insieme alla forte pressione sulle regioni del Mezzogiorno, una distribuzione capillare dell’illegalità ambientale lungo tutto lo Stivale”, commenta Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambient.
“A ciò bisogna aggiungere la crescente pervasività delle mafie e quella della corruzione negli appalti pubblici, che rappresentano sempre più una minaccia significativa non solo per l’economia, ma anche per il tessuto sociale e democratico del paese, oltre a minare l’integrità e l’efficienza della spesa pubblica. Per contrastare gli ecocriminali e la loro vera e propria arroganza, servono interventi decisi: ai risultati positivi prodotti fino a ora dalla legge 68 n. 2015 sugli ecoreati, bisogna far seguire nuovi strumenti per contrastare anche le agromafie, a cominciare dal mercato in crescita dei pesticidi illegali, e l’abusivismo edilizio, altra piaga del paese, rafforzando il sistema dei controlli ambientali, in modo omogeno su tutto il territorio nazionale.”
Legambiente: la legge sugli ecoreati funziona, ma va completata
I delitti più gravi previsti dal Titolo VI-bis del Codice penale mostrano l’impatto della Legge sugli ecoreati 68/2015. Nel 2024 sono stati contestati 971 illeciti complessivi (+61,3% sul 2023), con 1.707 persone denunciate (+18,9%) e un aumento dei controlli del 28,7% (1.812). In cima l’inquinamento ambientale con 299 contestazioni.
Dal giugno 2015 a dicembre 2024, grazie alla riforma, sono stati accertati 6.979 illeciti, con 12.510 denunciati, 556 arresti e 1.996 sequestri. Numeri che indicano come il rafforzamento degli strumenti penali produca risultati, ma anche quanto resti da fare per rendere il sistema impermeabile alle infiltrazioni criminali.
Nel presentare il rapporto, Legambiente lancia un messaggio netto: “Nonostante i passi avanti legislativi, bisogna alzare la soglia di prevenzione e approvare quelle riforme ancora mancanti. 12 le proposte che presentiamo a partire dal recepimento della direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, dall'approvazione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare, dal rafforzamento dei controlli ambientali e da un piano nazionale contro l’abusivismo”.
La roadmap comprende anche la stretta al subappalto “a cascata”, l’inasprimento delle sanzioni per gestione illecita dei rifiuti, l’estensione delle responsabilità amministrative ex 231 a nuovi delitti ambientali, il rafforzamento della lotta agli incendi e l’accesso gratuito alla giustizia per le associazioni del terzo settore impegnate nei contenziosi ambientali.
La richiesta di accelerare arriva forte dalla voce del presidente nazionale di Legambiente: “Nella lotta alla criminalità ambientale l’Italia deve accelerare il passo e può farlo con l’approvazione di una riforma fondamentale molto attesa, ossia il recepimento della direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente entro il 21 maggio 2026”, spiega Stefano Ciafani.
“In questa legislatura si parla tanto di semplificazioni, poco di contrappesi in grado di fermare i furbi o i criminali che fanno concorrenza sleale alle imprese serie. Non a caso abbiamo inserito la presentazione di questo Rapporto nella nostra nuova campagna nazionale per costruire dal basso un ‘Clean Industrial Deal Made in Italy’ che garantisca decarbonizzazione, competitività e lotta all’illegalità. Solo con il completamento di quella riforma di civiltà che abbiamo inaugurato nel 2015 con l’approvazione della legge sugli ecoreati si otterrà quel livello di sicurezza nazionale che invochiamo da più di 30 anni. Nessuna legge e nessun decreto ha fino a oggi voluto raggiungere in modo concreto questo obiettivo.”
Perché il contrasto alle ecomafie è anche una questione economica
La criminalità ambientale drena risorse pubbliche, distorce la concorrenza e scarica costi sociali enormi, spiega Legambiente. Appalti truccati e corruzione frenano gli investimenti in infrastrutture verdi, depurazione, gestione sostenibile dei rifiuti. Il ciclo illegale del cemento altera il mercato immobiliare, sottrae suolo e aumenta il rischio idrogeologico. Il traffico di rifiuti e l’inquinamento richiedono bonifiche costose. Ogni mancata demolizione di un abuso edilizio perpetua una passività sul territorio. Affrontare il fenomeno significa liberare risorse per la transizione ecologica, stimolare filiere industriali pulite e proteggere gli operatori onesti che investono in tecnologie di riciclo, energie rinnovabili e rigenerazione urbana.
I numeri di Ecomafia 2025 raccontano una spirale che si alimenta dove il controllo è debole, le norme restano inapplicate e il territorio è vulnerabile. Prevenzione, trasparenza negli appalti, rafforzamento delle procure ambientali, tracciabilità digitale delle filiere del cemento e dei rifiuti, uso intelligente dei fondi europei e partecipazione civica sono gli assi su cui costruire un argine duraturo.
Le proposte di Legambiente offrono una base di lavoro, ma la sfida ora è trasformarle in atti legislativi, prima che i costi economici, sociali e climatici dell’illegalità ambientale diventino insostenibili. In gioco non c’è solo la tutela del paesaggio, ma la credibilità stessa della transizione ecologica italiana.
In copertina: foto di CollabMedia, Unsplash