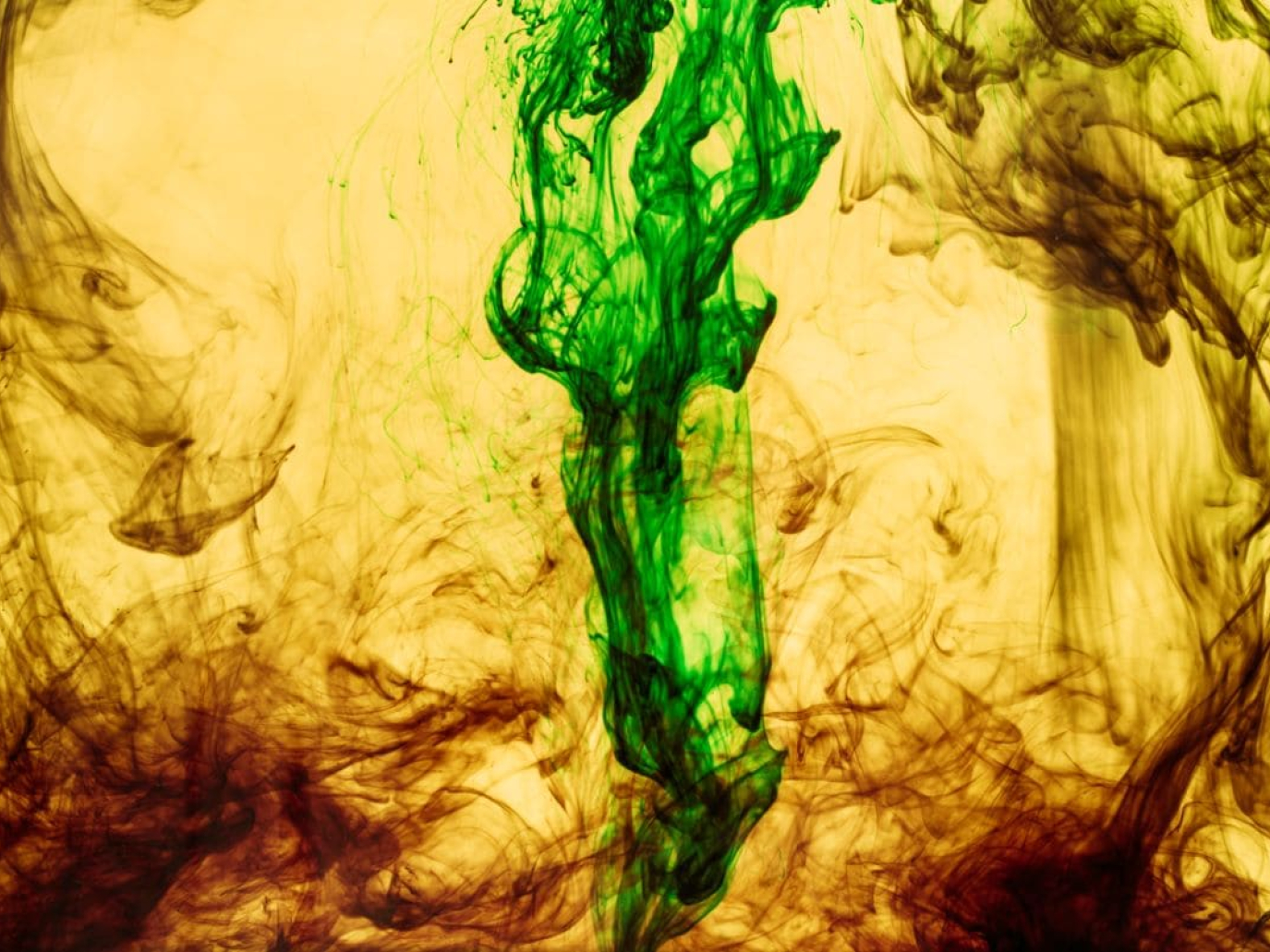L’Unione Europea ha recentemente compiuto un grave passo indietro, bloccando l’approvazione della Direttiva sui Green Claim, uno strumento importante per contrastare la diffusione di dichiarazioni ambientali ingannevoli. Una decisione che indebolisce il Green Deal europeo e manda un segnale inquietante: si conferma la tendenza che vuole far tornare la sostenibilità una scelta volontaria e non una responsabilità regolata e vigilata.
Si tratta di un arretramento che si inserisce in una generale situazione di riflusso sulle tematiche di sostenibilità a livello comunitario. Ciò che però sorprende è che venga fermato uno strumento che non carica le aziende di nuovi costi significativi ma che chiede una comunicazione non ingannevole, a tutela dei consumatori europei.
Due le conseguenze principali. La prima riguarda, appunto, i consumatori, lasciati più esposti a frodi comunicative. Claim vaghi come “100% sostenibile”, “eco-friendly” o “buono e naturale” potranno continuare a comparire negli spazi commerciali, senza verifica indipendente a supporto. Questa comunicazione poggia sulla ormai matura attenzione di fette di consumatori rispetto alle tematiche di sostenibilità, ma sfrutta l’impossibilità di avere tutte le informazioni per poter compiere una scelta di acquisto sostenibile. Non solo: si alimenta in questo modo l’idea che debba essere il consumatore, nell’atto di acquisto, a scegliere il bene sostenibile, mentre sarebbe ben più efficace che la sostenibilità fosse già all’interno dei prodotti e dei processi (comunicazione compresa), piuttosto che un elemento di scelta (in un contesto, quello dell’acquisto, dove la variabile “costo” ha sempre il ruolo prevalente).
La seconda conseguenza è più sistemica: conferma la tendenza a depotenziare l’ambizione del Green Deal (ovvero il programma con cui l’UE intende raggiungere la sua parte di obiettivi connessi agli Accordi di Parigi). Laddove la transizione ecologica dovrebbe essere guidata da norme chiare e vincolanti, si torna a una logica in cui fare sostenibilità significa “fare di più del dovuto” (si pensi al dibattito sulla CSRD). E questo “di più” ricade, ancora una volta, sulla responsabilità delle aziende più virtuose, mentre i furbi si muovono indisturbati.
Naturalmente, il greenwashing è una pratica sotto esame da ben prima che si parlasse della Direttiva Green Claim, e casi di sanzioni per comunicazioni commerciali non veritiere si sono già verificati, anche in Italia (si pensi ai casi Eni, Miko e San Benedetto). Con la scelta di bloccare l’iter di approvazione, l’Unione Europea decide di venire meno a un principio importante: la corretta comunicazione per la sostenibilità è un elemento funzionale per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione, vista l’inclusione della Direttiva all’interno del Green Deal.
Bloccare questo contenuto significa rallentare il processo di decarbonizzazione, poiché le imprese europee avranno una ragione in meno per impegnarsi seriamente in un percorso di mitigazione dei propri impatti ambientali e un motivo in più per non dover curare la veridicità di quanto comunicano: è del tutto evidente che se il mercato premia chi decarbonizza solo a parole, gli obiettivi climatici diventano più difficili da raggiungere.
Fortunatamente, non tutte le istituzioni europee si stanno muovendo nella stessa direzione. In contro tendenza rispetto alla scelta politica di bloccare la direttiva, l’European Securities and Markets Authority (ESMA) ha recentemente pubblicato un documento per ricordare i criteri di una comunicazione ambientale seria e affidabile. I principi ribaditi sono semplici, ma essenziali: accuratezza, per cui i claim devono essere veri e dimostrabili (es. niente “100% green” senza basi scientifiche); accessibilità, per cui le informazioni devono essere facilmente reperibili, non nascoste; sostanzialità, per cui i dati comunicati devono poggiare su metodologie robuste e riconosciute; aggiornamento, per cui comunicare dati vecchi è fuorviante e quindi, a tutti gli effetti, greenwashing. Il contenuto del documento ESMA non introduce novità rivoluzionarie, ma è significativo che sia proprio l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari europei a ribadire questi princìpi.
Contrastare il greenwashing non è una crociata ideologica, né un aggravio insostenibile per le imprese: si tratta di garantire trasparenza, correttezza e rispetto per i consumatori. Senza strumenti di verifica e controllo, non solo si avvantaggiano i meno onesti, ma si mina anche la fiducia nei confronti delle imprese realmente impegnate nella transizione (alimentando così il fenomeno opposto al greenwashing: il greenhushing).
In definitiva, depotenziare le politiche contro il greenwashing significa togliere ai cittadini europei un diritto: quello di difendersi dalle frodi ambientali. E questo, in un’epoca in cui la sostenibilità dovrebbe essere al centro dell’azione pubblica, non può e non deve essere accettabile.
Leggi anche: Socialwashing, Rossella Sobrero: “Alle aziende si chiede ragionevole coerenza”
In copertina: immagine Envato