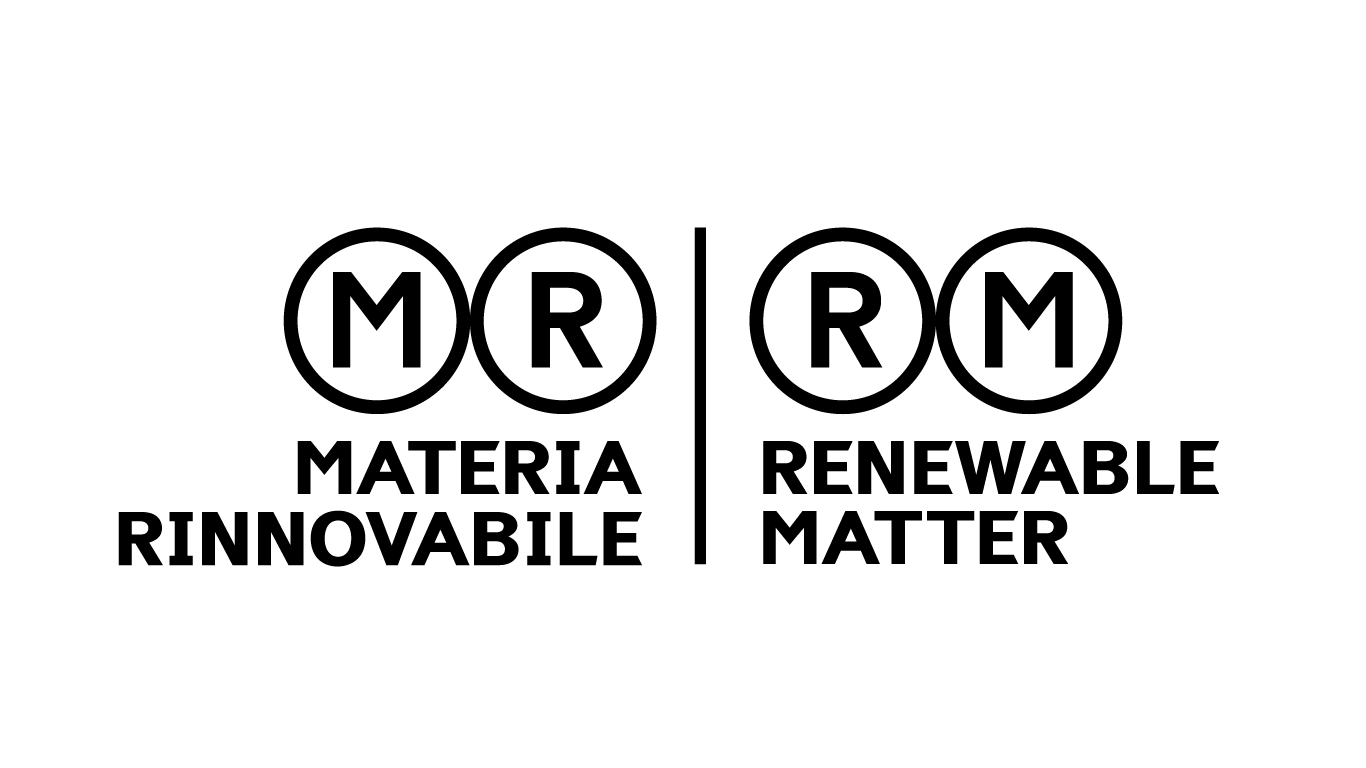Questo articolo fa parte del canale tematico The Social and Governance Observer, in collaborazione con Trentino Sviluppo. Iscriviti alla newsletter su LinkedIn
Cosa intendiamo quando parliamo di parità di genere nei luoghi di lavoro? Lo stesso numero di donne e di uomini tra i dipendenti? Metà dei ruoli apicali occupati da donne e metà da uomini? Ma siamo sicure che dividere tutto a metà o garantire quote di genere nelle assunzioni basti a superare il gender gap? La risposta è no: la discriminazione va oltre i dati quantitativi, i meri numeri, e per capire cosa veramente succede nelle aziende bisogna cercare dati qualitativi, che spesso riferiscono una storia diversa.
Ne parliamo con Donata Columbro, che abbiamo intervistato al termine di “un momento molto impegnativo”, ci spiega, quello di presentazione del suo nuovo libro, Perché contare i femminicidi è un atto politico (Feltrinelli, 2025). “Sono tematiche non facili da divulgare e spesso il lavoro intellettuale ha il problema di sembrare troppo astratto, ma questo tour mi ha aiutata a vedere la concretezza di ciò che faccio. E poi mi sembra che l'attenzione da parte delle persone sul tema sia cambiata, migliorata, e questo dà motivazioni in più per continuare il mio lavoro.”
Ecco, ci racconti il suo lavoro.
Lavoro come giornalista occupandomi prevalentemente di disuguaglianze e discriminazioni spiegabili con i dati. Ultimamente mi è stata data anche la definizione di “data humanizer”, umanizzatrice dei dati, e mi ci ritrovo, perché racconto il processo che porta alla produzione dei dati, cioè faccio divulgazione della cultura statistica. Ma sono anche un’attivista per i dati aperti, i dati pubblici, con l'associazione onData, e a volte queste due anime si uniscono. Non ultimo c'è l'approccio femminista ai dati, che è una lente con cui si può osservare tutto il mio lavoro: per esempio vedere come i dati possono alimentare le disparità all'interno della società, tra le persone, e come le dinamiche di potere si inseriscono nella produzione, analisi e divulgazione dei dati.
Cosa dobbiamo intendere per "dati"?
Spesso le persone si aspettano che i dati siano lì a nostra disposizione per essere utilizzati, interpretati, manipolati, raccontati. In realtà il processo della creazione di questo strumento di rappresentazione del mondo è molto complesso, e per me i dati sono cose che possiamo osservare, che esistono, che possiamo percepire, e che qualcuno decide a un certo punto di misurare o quantificare e poi inserire dentro a delle categorie. È importante l’atto del “decidere”, cioè l’intervento umano nel creare un legame tra quel fenomeno e tutta una serie di azioni e di relazioni anche con la comunità che magari ne è coinvolta. Pensiamo ai cambiamenti climatici: ci sono misurazioni che possono essere fatte senza incontrare esseri umani, e altre che devono comprendere il coinvolgimento di chi subisce le conseguenze di certi fenomeni.
Quindi perché i dati sono importanti?
Quantificare o misurare un fenomeno lo rende visibile, interpretabile. Ritengo i dati la base per avviare delle discussioni. Non sono esaustivi, non reputo che avere misurazioni del mondo o di un fenomeno, cioè un’interpretazione quantitativa, sia un punto di arrivo. Può però essere il punto di partenza per porci delle domande e cercarne le risposte con altri mezzi. Ma avere degli standard da valutare e che possano rendere confrontabili dei fenomeni su scala locale, nazionale o internazionale è utile per capire cosa si può fare eventualmente per migliorare la vita delle comunità, delle persone che ne fanno parte, e al tempo stesso per essere cittadine e cittadini migliori, più informati, più consapevoli.
A proposito di rendere visibili i fenomeni, a che punto siamo, secondo lei, con il gender gap nelle aziende italiane? Abbiamo abbastanza dati? Ci stiamo impegnando abbastanza per raccoglierne?
Credo che il lavoro di dare visibilità alle discriminazioni stia facendo passi avanti. Penso ai resoconti che arrivano dall'INPS sulle politiche di genere in Italia, alla creazione di strumenti come la certificazione per la parità che costringono le aziende a misurare ciò che succede al proprio interno, anche su parametri che magari prima non consideravano. Bisogna però mantenere l'attenzione sui motivi per cui lo stiamo facendo, altrimenti il dato diventa l'obiettivo, mentre invece non dovrebbe mai esserlo.
Ovvero?
Quando parlo con le persone durante i miei incontri ed eventi, mi raccontano spesso come tutta quella serie di attività che sia le istituzioni pubbliche che le aziende mettono in atto per avere parità di genere rischiano di far pesare maggior lavoro ancora una volta sulle donne. Ci sono enti che ottengono la certificazione di parità di genere ma a spese delle donne, le quali devono creare tavoli di lavoro, iniziative, avviare attività di misurazione per dimostrare di essere discriminate, togliendo però così tempo e impegno alla propria carriera. Per esempio, a chi finiscono i finanziamenti dei bandi più remunerati? Spesso agli uomini, perché possono dedicarvi il proprio tempo interamente, e non devono “distrarsi” impegnandosi in iniziative sulla parità di genere. Quindi, sì, è fondamentale misurare il gap di genere, ma magari intanto ci sfugge chi deve essere coinvolto nel colmare questo gap e che cosa sta succedendo nel frattempo.
Quali potrebbero essere le soluzioni?
Spesso le comunità e le soggettività marginalizzate e discriminate devono farsi carico del racconto, della raccolta di testimonianze, della produzione dati, altrimenti non lo fa nessun altro, quindi un primo passo necessario è migliorare la produzione di dati a livello sistemico. Ma anche indagare diversi tipi di discriminazioni, capire quali sono le conseguenze per chi rimane escluso e per chi continua ad avere privilegi, capire chi prende davvero le decisioni in azienda. Per esempio, lo racconta bene Jennifer Guerra nel suo libro Il femminismo non è un brand [Einaudi, 2024, nda], sono state create tantissime posizioni manageriali per le donne, quindi abbiamo un numero molto alto di donne manager, che però si occupano di fare micro management, cioè con un carico di lavoro enorme ma in ruoli che non sono davvero decisionali. Perciò osservare la distribuzione del potere è molto più difficile che contare quante donne sono in posizioni di potere. Un’altra testimonianza riguarda quelle aziende che sostengono molte iniziative sulla parità di genere ma poi fissano le riunioni importanti alle sei di sera, quando chi ha carichi di cura familiare, cioè spesso le donne, non può esserci. Sono meccanismi fatti per escludere o che comunque escludono determinate persone, che quindi finiscono per non potersi occupare di tematiche importanti. Sono quei dati che vengono chiamati anche thick data, dati densi, che non è facile misurare perché raccolti con testimonianze dal basso e in ambienti sicuri, eppure, se non si dà attenzione alla qualità dei dati, non c'è volontà di vero cambiamento ma solo interesse a ottenere una certificazione. Di nuovo: il dato non deve essere l'obiettivo, cioè lo scopo non deve essere quello di avere il 50% di donne in azienda, ma di garantire in azienda un'equa distribuzione sia dei diritti che dei doveri. Ribaltando la situazione, penso anche alla negazione del diritto alla cura per chi ha invece ruoli apicali e quindi deve stare in azienda fino alle otto di sera rinunciando a partecipare alla vita dei propri figli. Se si inizia a vedere questo come una negazione di un diritto, cambia tutta la prospettiva. In questo senso l’obiettivo non è più la parità di genere ma l’equità in generale. Non c’è una soluzione semplice, si tratta di mettere in discussione la corsa al KPI.
Parlando di percentuali: in Italia le donne rappresentano il 36% del management ma solo il 18% ha contratti dirigenziali. Alla luce della sua esperienza, le aziende italiane vedono questi dati solo come numeri da far crescere o ci sono un reale impegno verso l’equità e una reale comprensione della sua importanza?
Dipende. Sicuramente ci sono aziende che hanno a cuore una società diversa e che quindi mettono in atto iniziative rivolte anche agli uomini e non solo alle donne. E questo forse è anche la discriminante. Per esempio, c’è differenza tra organizzare iniziative per le mamme o per i genitori. Quello della maternità è un dato automaticamente prodotto dalla vita aziendale, perché la dipendente che rimane incinta fa domanda di indennità e il dato viene raccolto, mentre i padri non sempre chiedono il congedo parentale, e il dato si perde. Ma, se l’azienda si interessa ai genitori nel complesso, può rendersi conto di avere a che fare con una popolazione più folta, che ha dei diritti da esercitare. Oppure, ancora, si può vedere se l’azienda garantisce giorni di smartworking, che più permettono la flessibilità necessaria a chi ha compiti di cura, o quali benefit familiari vengono forniti. Ecco perché i dati sono importanti, anche come indicatori del lavoro che si svolge, ma se l’azienda pensa solo a colmare il gap di genere rischia di perdersi tutto il resto. Negli ultimi mesi ho conosciuto aziende che hanno la figura della consigliera di fiducia, una persona, che non rientra nelle risorse umane, con cui parlare di situazioni delicate e particolari. Si tratta di un altro dato che non è obbligatorio nelle certificazioni di parità di genere ma se è presente dimostra apertura al dialogo, formazione specifica e volontà di lavorare in maniera diversa.
Questo tipo di evoluzione quanto sta alle aziende e quanto invece dovrebbe stare alle istituzioni?
Sicuramente le aziende possono fare tanto perché hanno la possibilità di accelerare dei processi che nelle istituzioni sono molto più lenti. Per esempio, un'azienda può decidere che il congedo parentale dei propri dipendenti che diventano padri duri tre mesi. Dal punto di vista delle istituzioni credo che si debba anche lavorare su un cambiamento culturale. Quando abbiamo pubblicato il rapporto Sesso è potere 2025 [curato da info.nodes e onData, nda] che indaga il predominio maschile nelle circa 128.000 posizioni di potere in Italia in ambito politico, economico e dei media, mi ha stupita la quantità di commenti che abbiamo ricevuto, nonostante un lavoro trasparente e basato su dati, da parte di persone convinte del fatto che se le donne sono in queste condizioni è perché non è nella loro natura avere potere, non vogliono assumersi rischi e non possono essere costrette a farlo. Sono posizioni ideologiche smentite da anni di studi, eppure persistono. Ciò rende chiara la necessità di lavorare, dal punto di vista politico e pubblico, in un'altra direzione, quella di non tenere uomini e donne all'interno dei loro ruoli tradizionali, che non hanno niente di naturale, e capire che la società si costruisce in base ai valori che noi ci diamo. Così, se una donna vuole diventare dirigente d’azienda o andare sulla Stazione spaziale internazionale, la prima cosa da chiederle non deve essere “Come farai con i tuoi figli?”. Bisogna invece mettere in atto delle politiche per sostenere quella scelta, dagli asili nido a bonus familiari per pagare la gestione degli aiuti, per facilitare l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro.
Un ingresso necessario anche a livello economico, visto che, come spiega Confartigianato, se il tasso di occupazione femminile italiano si allineasse alla media europea, il PIL crescerebbe di 154,7 miliardi di euro, pari a 7,4 punti percentuali. Insomma, ci sono i dati, le motivazioni… manca solo il cambiamento culturale?
No, deve essere un cambiamento politico, perché la bassa percentuale di donne nel mercato del lavoro esiste da anni e nessun governo ha mai davvero inserito la questione del lavoro femminile nei propri programmi in maniera incisiva. I dati ci sono, ma purtroppo si fa molta fatica a prendere decisioni politiche basate sui dati. Eppure le conseguenze si hanno a diversi livelli. Per esempio, tra i benefici c’è la crescita del PIL ma anche la riduzione della violenza di genere, perché una donna che lavora è più emancipata, mentre ha più difficoltà ad allontanarsi da una situazione di violenza se chi esercita quella violenza è la stessa persona che la mantiene economicamente. Oppure pensiamo alle iniziative per aumentare i posti negli asili nido con il PNRR annunciate con tanti proclami e poi perse perché non si è riusciti a far avanzare i progetti, spendere soldi, rispettare scadenze. È più facile fare proclami e creare politiche una tantum, come i bonus, che però non sono strutturali e quindi non aiutano davvero le famiglie a lungo termine. Quindi, sì, serve un cambiamento culturale, ma anche un'azione politica, soldi e la volontà di affrontare il problema concretamente negli anni, come finora non è stato fatto.
In copertina: Donat Columbro © Pasqualini, Musacchio/MUSA