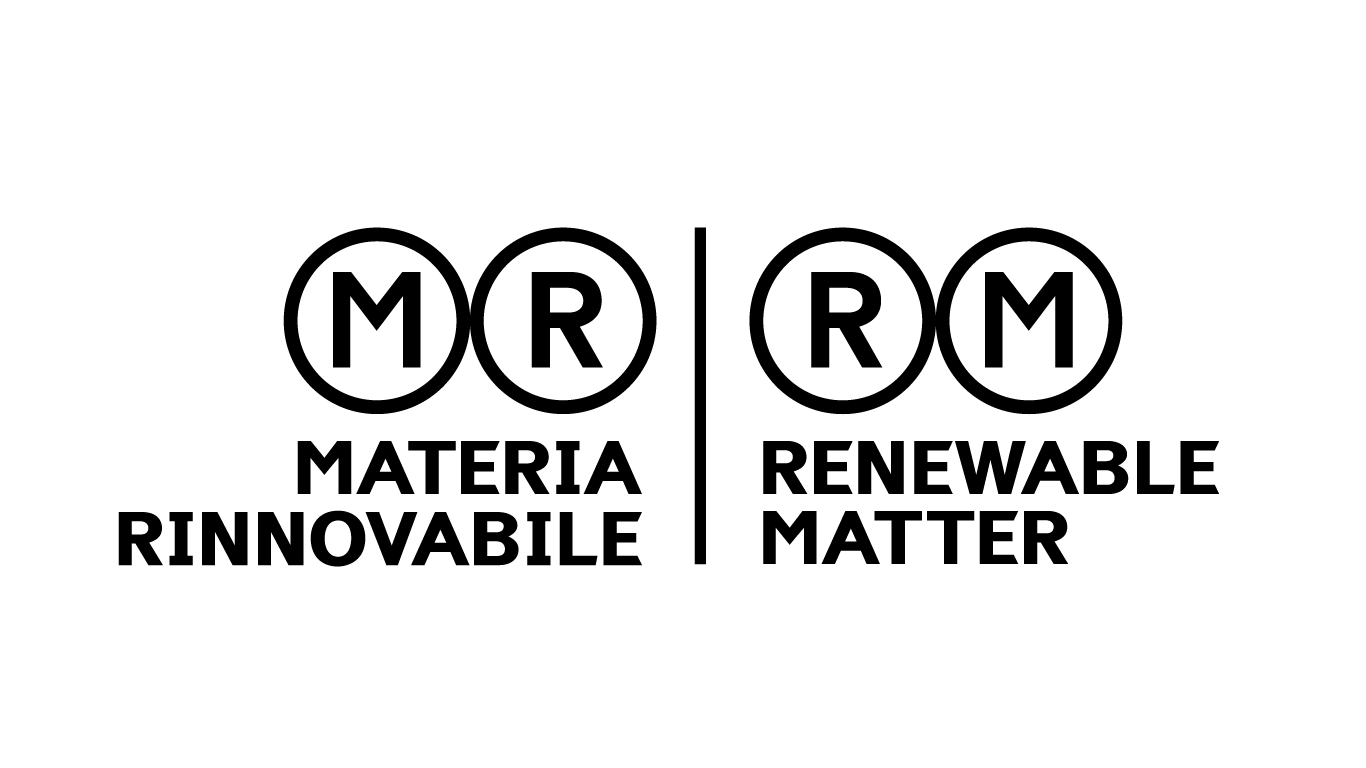Non capita spesso che la comunità antropologica scelga coralmente di occupare lo spazio pubblico per intervenire sulle emergenze sistemiche, abbandonando la confortevole distanza dell'osservatore per immergersi nella mischia del dibattito politico. La pubblicazione del Manifesto Anthrofood 2050, avvenuta il 12 gennaio a opera dello European Association of Social Anthropologists Food Network (EASAFN, 2026), segna in tal senso una discontinuità. Questa presa di posizione non nasce nel vuoto, ma è il frutto maturo di un percorso iniziato a Milano nel luglio 2025, nelle aule dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Lì, durante l'evento Anthrofood 2050, decine di studiosi internazionali hanno intessuto un dialogo serrato volendo superare la frammentazione disciplinare per rispondere a una crisi che non è solo ambientale ma profondamente culturale.
La genesi del documento riflette, dunque, una nuova consapevolezza: l’urgenza di porre l’attenzione sugli aspetti socioculturali del cibo, troppo spesso relegati ai margini di un dibattito pubblico e politico ossessionato dalle soluzioni meramente tecniche. Se analizziamo il sistema alimentare globale attraverso la lente asettica dei dati, l’immagine che ne emerge è quella di un meccanismo non solo inceppato, ma in procinto di collassare sotto il peso delle proprie contraddizioni.
Ancora di recente, le Nazioni Unite (UNEP, 2025) hanno descritto una realtà ecologicamente inequivocabile e allarmante segnata dall'inefficienza strutturale nell'uso delle risorse. Ad esempio, sebbene il bestiame occupi il 77% dei terreni agricoli mondiali (tra pascoli e colture destinate ai mangimi), fornisce all'umanità soltanto il 18% dell'apporto calorico globale e il 37% delle proteine totali. Siamo di fronte a un paradosso termodinamico ed economico che, in uno scenario di espansione agricola continua, minaccia di cancellare la biodiversità residua e di esaurire le risorse idriche del pianeta. Tuttavia, ridurre questa crisi epocale a un problema di ingegneria o di agronomia equivale a commettere un errore grave.
Il Manifesto Anthrofood 2050 si inserisce proprio in questo spazio d’ombra, proponendosi come un contributo critico per sfidare quelle che Rowan Gibson (2015) definirebbe "ortodossie": credenze radicate che vincolano il nostro modo di intendere il cibo e impediscono una reale transizione ecologica. Il documento opera una decostruzione sistematica di queste mitologie contemporanee. In primo luogo, contesta radicalmente l'idea che il cibo sia semplice carburante biologico, una visione riduzionista che eclissa le dimensioni affettive, rituali e simboliche fondamentali per la coesione sociale e la resilienza comunitaria. Ancora più incisiva è la critica rivolta alle retoriche del "locale": l'antropologia ci mette in guardia dal rischio che il chilometro zero diventi un feticcio escludente, un lusso estetico per pochi che nasconde nuove forme di elitismo e non risolve le ingiustizie nell'accesso alle risorse.
Il nodo cruciale, sostiene il manifesto, è l'ingiustizia strutturale. Il sistema alimentare attuale non è "rotto", per caso: nella sua attuale articolazione appare progettato per riprodurre disuguaglianze di classe, etnia e genere. Ignorare queste dinamiche di potere significa proporre soluzioni cosmetiche a problemi sistemici. In questo contesto, il documento porta alla luce l'importanza cruciale del lavoro di "cura": quell'infrastruttura silenziosa e spesso invisibile − dalla conservazione dei semi alla preparazione domestica − gestita prevalentemente ai margini della sfera pubblica da donne, anziani e migranti. Riconoscere il valore politico ed economico di questo lavoro è il primo passo per un'economia rigenerativa.
Infine, si invoca la necessità di valorizzare la natura intrinsecamente dinamica e ibrida delle conoscenze gastronomiche, abbandonando gli approcci museali che tentano di "congelare" la tradizione; solo accettando il meticciato e l'evoluzione possiamo superare le crescenti tensioni identitarie che attraversano le nostre società.
Nel procedere a questa necessaria decostruzione e ricostruzione della realtà alimentare, la comunità antropologica non si è limitata alla critica. Ha voluto offrire ai lettori − siano essi decisori politici, attivisti o cittadini − una "cassetta degli attrezzi" concettuale per leggere l’orizzonte quotidiano con maggiore chiarezza e un messaggio preciso su come agire. L'invito è ad abbandonare le logiche verticali e verticistiche, proprie degli approcci tecnocratici che calano soluzioni dall'alto su territori che non conoscono. La centralità viene riposta nell’azione orizzontale, fatta di rapporti paritari tra istituzioni e comunità.
Si tratta di sostituire la direttiva con l'ascolto, la competizione con la mutualità, abbandonando ogni residuo di paternalismo accademico o politico, per elaborare insieme soluzioni a partire da chi la terra lavora e la vive quotidianamente. Non siamo di fronte all’ennesima celebrazione retorica del "piccolo è bello" o a un ingenuo localismo; ma a una richiesta collettiva di impegno per un dialogo strutturale. In questo processo, l’antropologia si offre non come giudice esterno, ma come agente facilitatore, capace di costruire ponti tra saperi diversi. Perché, se è vero che la tecnologia ci fornirà gli strumenti per produrre cibo nel 2050, sarà solo la cultura a dirci come condividerlo correttamente.
In copertina: foto di Jonathan Tomas, Unsplash