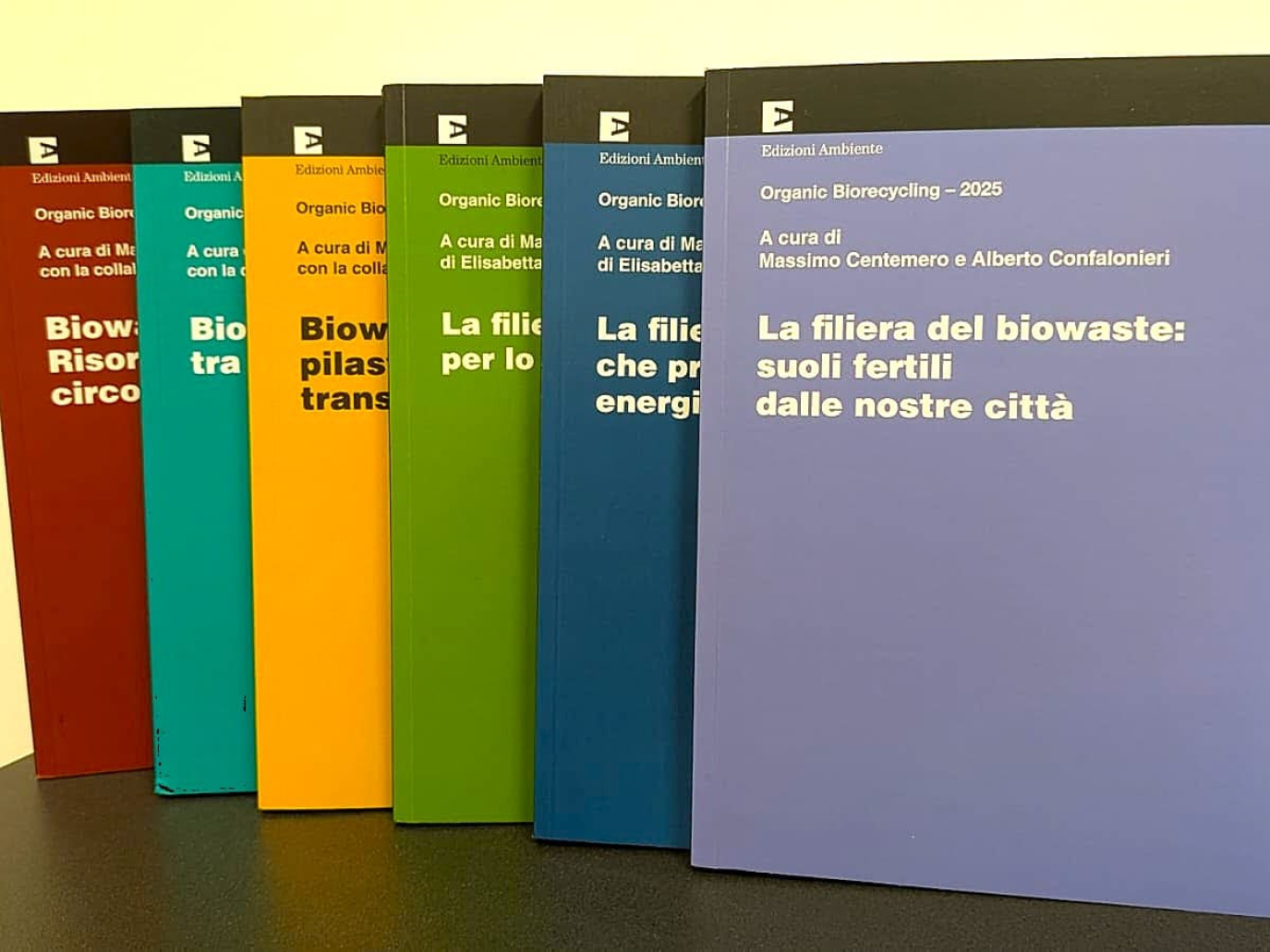Come valorizzare il compost per renderlo uno strumento di tutela del suolo, risorsa preziosa e non rinnovabile? È questo il tema al centro del nuovo rapporto del Consorzio italiano compostatori (CIC), La filiera del biowaste: Suoli fertili dalle nostre città, sesto volume della collana Organic Biorecycling a cura di Massimo Centemero e edito da Edizioni Ambiente, presentato il 2 ottobre a Roma in occasione dell’omonima tavola rotonda. Un progetto che ogni anno fotografa lo stato e l’evoluzione del settore del rifiuto organico, restituendo dati preziosi sulla filiera del riciclo degli scarti di natura organica che ogni giorno produciamo.
Quest’anno il volume pone al centro del dibattito la salute dei suoli, sfida cruciale per l’immediato futuro, e analizza come la gestione dei rifiuti organici possa assumere un ruolo strategico sia nel restituire nutrienti ai terreni agricoli e alle aree verdi urbane, sia nel ridurre le emissioni di metano dalle discariche e favorire il sequestro di carbonio nei suoli.
Il tutto approfondendo il concetto innovativo dello Urban Carbon Farming, cioè l’insieme delle pratiche agricole rigenerative applicate in ambito urbano e periurbano, con l’impiego di compost e digestato, e presentando un vero e proprio Manifesto con l’obiettivo di coinvolgere aziende e cittadini nella trasformazione delle città italiane. Ma andiamo con ordine, analizzando i dati presentati dalla nuova pubblicazione del CIC e le proposte per il raggiungimento dei target fissati dall’Unione Europea.
I numeri del settore del riciclo organico in Italia
A che punto si trova l’Italia rispetto agli obiettivi europei che, ricordiamo, puntano alla soglia del 65% di riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2035? Suoli fertili dalle nostre città presenta il quadro aggiornato del riciclo dell’organico in Italia fino al 2023, sulla base degli ultimi dati forniti da ISPRA.
Nel 2023 la produzione totale di rifiuti urbani è stata di 29,2 milioni di tonnellate, con una stima di 496 kg per abitante. Per il quarto anno consecutivo, ci troviamo al di sotto della soglia dei 30 milioni di tonnellate. La raccolta differenziata ha raggiunto 19,5 milioni di tonnellate, pari al 66,6% del totale (in crescita rispetto al 65,2% del 2022). Di queste, la frazione organica ammonta a 5,5 milioni di tonnellate, con una media di 126,6 kg per abitante, seppur con forti differenze tra le regioni. Un risultato positivo e in crescita rispetto all’anno precedente, favorito anche da cittadini più consapevoli che contribuiscono attivamente alla raccolta differenziata.
Rispetto al panorama europeo, il riciclaggio dei rifiuti organici in Italia rappresenta “un’eccellenza assoluta”, scrive Centemero. Se guardiamo alla gestione della frazione umida a livello comunitario, emergono elementi distintivi significativi dell’unicità italiana. Tra questi, il fatto che il servizio di raccolta differenziata della frazione umida copra circa il 90% della popolazione (almeno 52 milioni di abitanti) e la capillarità del servizio stesso.
L’obbligo di utilizzare sacchetti compostabili certificati ha semplificato la raccolta e innalzato la qualità delle purezze merceologiche fino al 95-98%. In questo modo, il tasso di intercettazione dell’umido domestico è tre volte superiore alla media europea, consentendo di raccoglierne annualmente oltre 5,5 milioni di tonnellate. Il sistema impiantistico nazionale conta 363 impianti operativi per il riciclo della frazione organica (sette in più rispetto all’anno precedente), che hanno trattato complessivamente 8,7 milioni di tonnellate di rifiuti, generando circa 2 milioni di tonnellate di compost.
Contemporaneamente, dagli stessi flussi di rifiuti sono stati prodotti 475 milioni di m³ di biogas, la cui valorizzazione ha portato alla produzione di 470 GWh di energia elettrica, 80 GWh di energia termica, 201 milioni di m³ di biometano (destinato principalmente ai trasporti e all’autotrazione) e oltre 160 milioni di m³ di anidride carbonica, parte della quale è stata trattata e commercializzata come gas tecnico, anche all’interno dell’industria alimentare.
Questi e altri dati presentano l’Italia come un paese virtuoso, che merita attenzione a livello europeo non solo per ragioni statistiche, ma anche perché rappresenta un esempio positivo di modello industriale applicato all’economia circolare.
La centralità del settore del riciclo organico nella transizione ecologica italiana è evidente. Ci troviamo di fronte a un comparto che assicura autosufficienza impiantistica e produce fertilizzanti rinnovabili e biometano, contribuendo concretamente alla lotta contro i cambiamenti climatici.
Per questo motivo, sottolinea il CIC, servono sempre più leve normative ed economiche che promuovano la qualità della raccolta differenziata e, soprattutto, la valorizzazione del compost e dei fertilizzanti derivanti dal riciclo organico. Una sfida che richiede non solo investimenti e innovazione, ma anche linee guida condivise, obiettivi vincolanti e un quadro economico sostenibile.
Con questo nuovo volume, il CIC riporta l’attenzione sulla necessità di introdurre obiettivi specifici e strategici per il riciclo organico, accendendo i riflettori sul valore della trasformazione dei rifiuti organici in fertilizzante naturale. Se per biogas e biometano non mancano incentivi e strumenti di sostegno, infatti, è soprattutto sulla produzione e valorizzazione del compost che occorre rafforzare le politiche di supporto. Come? Il CIC propone una strategia che valorizzi il legame tra suolo e fertilizzanti organici, estendendo questo modello anche agli spazi verdi urbani, attraverso la prospettiva innovativa dello Urban Carbon Farming.
Urban Carbon Farming: una nuova filiera possibile
Quando parliamo di Urban Carbon Farming, ci riferiamo all'applicazione delle pratiche di carbon farming nelle aree urbane, con l'obiettivo di sequestrare carbonio nel suolo e nella vegetazione cittadina e di ridurre l’emissione di protossido di azoto, migliorandone al contempo la fertilità.
Un approccio che mira a rigenerare il verde urbano attraverso l'applicazione di compost, la gestione sostenibile delle aree verdi e l’aumento della vegetazione, trasformando gli scarti quotidiani in un alleato concreto contro la crisi climatica.
Si tratta di una nuova frontiera della bioeconomia circolare, capace di collegare le politiche urbane con gli obiettivi globali di sostenibilità, dando valore ai rifiuti organici per costruire città più vivibili. Letteralmente, l’espressione “carbon farming” si traduce in “coltivazione di carbonio”, anche se in Italia è stato adottato il termine “carboniocoltura”.
Come leggiamo nel volume, alcuni esempi pratici di carbon farming sono la forestazione e riforestazione favorevole alla biodiversità e alla gestione sostenibile delle foreste; l’agroforestazione e altre forme di agricoltura mista che combinano vegetazione legnosa (come alberi o arbusti) con sistemi di produzione colturale e/o animale sullo stesso terreno; l’utilizzo di cover crop e tecniche di minimum tillage o no-tillage (minima o nessuna lavorazione) per proteggere il suolo dall’erosione e aumentare il contenuto di carbonio organico nei suoli seminativi degradati; la conversione mirata di terreni incolti in prati permanenti e il ripristino di torbiere e zone umide per ridurre la perdita dello stock di carbonio e aumentare il potenziale di sequestro.
I concetti che stanno alla base del carbon farming possono essere applicati anche al verde delle nostre città, che si trovano nel cuore di un hotspot climatico. Come sappiamo, infatti, le città affrontano sfide ambientali sempre più complesse, che incidono anche sulla qualità della vita dei cittadini. Stiamo assistendo a un persistente aumento delle isole di calore urbano, che rendono le stagioni calde difficilmente sopportabili e aumentano i rischi per la salute. La densità di superfici cementificate e la scarsa presenza di verde amplificano questo fenomeno. Il 15% della perdita di suolo in Italia avviene proprio nelle aree urbane.
Inoltre, l’intensificarsi di eventi climatici estremi mette a dura prova la capacità di adattamento delle infrastrutture. Basti pensare ai sistemi di drenaggio spesso insufficienti e alla ridotta permeabilità dei suoli cittadini, periodicamente messi sotto stress dagli ingenti volumi d’acqua piovana.
A complicare il quadro c’è una gestione molte volte inadeguata del verde urbano. Parchi, giardini e altre aree verdi (che dovrebbero fungere da elementi equilibratori del tessuto urbano e da spazi di aggregazione) si trovano spesso in condizioni non ottimali, con la conseguente perdita di benefici ambientali come la mitigazione del clima, la depurazione dell’aria e l’assorbimento dell’acqua. Il tutto alla luce del fatto che il verde dovrebbe invece rappresentare il punto di partenza per una vera e propria rivoluzione urbana nella lotta agli effetti del cambiamento climatico.
Ecco perché, in occasione della presentazione del volume, il CIC ha lanciato anche il Manifesto dello Urban Carbon Farming: un appello ad aziende e cittadini a sostenere insieme pratiche concrete per rendere le città più sostenibili e resilienti di fronte ai cambiamenti climatici.
In copertina: foto Edizioni Ambiente