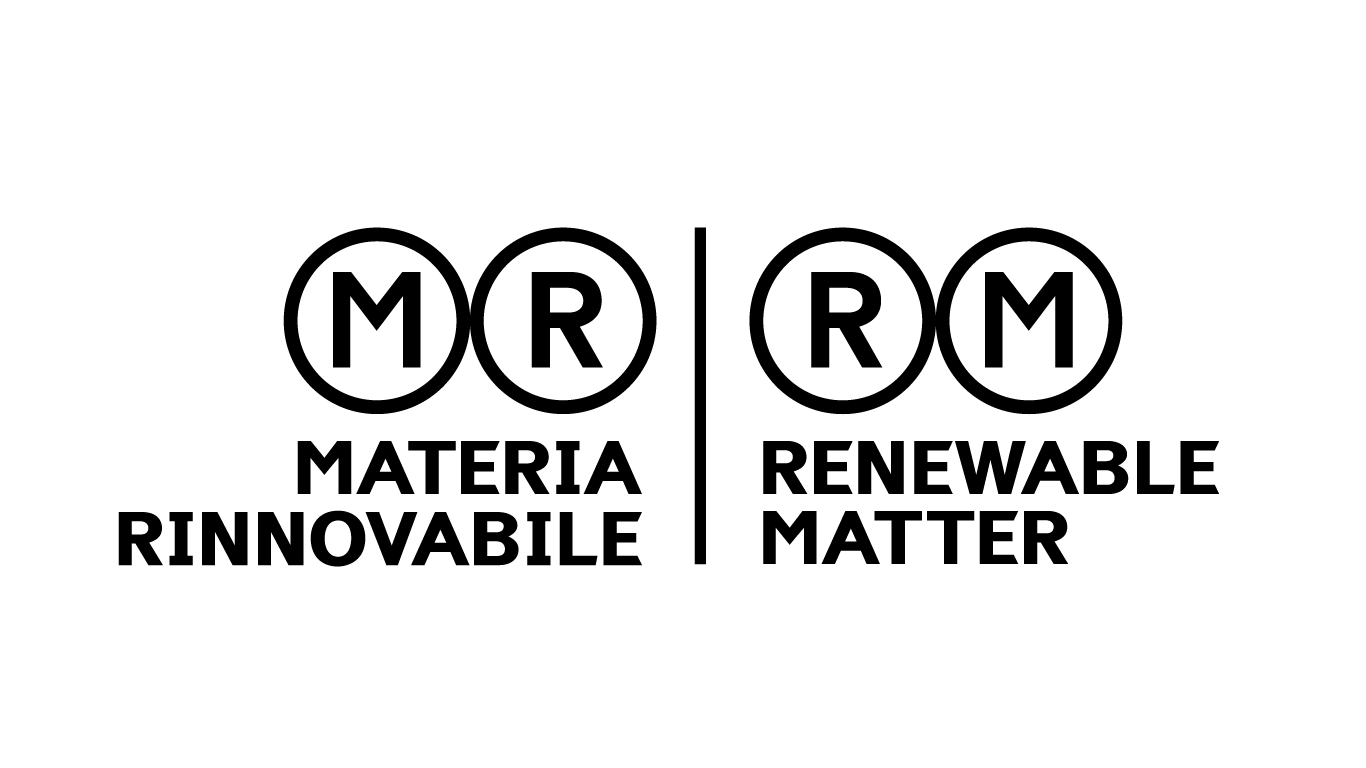Utile? Sì. Comodo? Anche troppo. Ma quanto a sostenibilità, l’e-commerce non ha mai avuto una buona reputazione. Ora però una ricerca vuole capovolgere la cattiva fama ambientale degli acquisti online, sostenendo che non solo siano meno impattanti di quanto abbiamo sempre creduto, ma che la loro impronta di carbonio sia decisamente inferiore a quella dello shopping tradizionale in negozio.
Lo studio è stato presentato il 29 febbraio da Netcomm, il Consorzio del commercio digitale italiano, che lo ha realizzato insieme al gruppo di ricerca B2c Logistics Center del Politecnico di Milano. Ed esordisce con un dato quantomeno controintuitivo: l’impatto ambientale dello shopping online sarebbe inferiore di ben il 75% rispetto a quello in negozio.
Attenzione però: prima di buttarsi a capofitto sugli store online e ordinare su Amazon persino gli stuzzicadenti pensando di salvare il pianeta, è bene contestualizzare il dato.
Abbiamo perciò letto la ricerca e parlato con gli autori per capire come siano arrivati al risultato e quanto ci sia di vero in questa apparentemente schiacciante vittoria dell’e-commerce sulla cara vecchia bottega.
E-commerce vs negozio: contestualizzare il dato
“L’impatto ambientale degli acquisti online è nettamente inferiore a quello degli acquisti nei negozi fisici.” Così esordisce il comunicato stampa arrivato in redazione il 29 febbraio, e prontamente ripreso dalle pagine economiche di diverse testate nazionali, compresa la Repubblica. Nello shopping tradizionale – continua il comunicato – si arriverebbe a generare fino a 2,59 kg di CO2 per pacco, di cui il 90% sarebbe imputabile ai viaggi di andata e ritorno dei clienti e al mantenimento del negozio. Mentre “i canali di acquisto online, che prevedono anche servizi di consegna come home delivery e punti di ritiro, risultano più sostenibili e possono ridurre fino a 10 volte le emissioni rispetto allo shopping offline”.
È un’affermazione importante, e noi di Materia Rinnovabile abbiamo voluto approfondire. La ricerca completa non è in realtà disponibile online ma, su nostra richiesta, Netcomm ci ha fornito una sintesi redatta dal team del Politecnico di Milano (ci si può registrare e richiederla a questo link). Con il documento davanti è stato quindi possibile cominciare a circoscrivere il dato e ridimensionarne la portata.
Innanzitutto, lo studio non riguarda “l’impatto ambientale dell’e-commerce” tout court, ma solo le emissioni generate dalla fase di consegna last mile, ovvero l’ultimissimo tratto della catena logistica del commercio online, che è in realtà molto più lunga, almeno per i grandi retailer internazionali come Amazon. Su questa specifica fase si è dunque focalizzato il team del B2c Logistics Center, costruendo un confronto fra la più diffusa modalità di consegna e-commerce, cioè la home delivery (a domicilio), con la consegna nei punti di ritiro tipo edicole e tabaccai da un lato (risultata la modalità più sostenibile), e dall’altro l’acquisto tradizionale in negozio. Il tutto per quattro categorie di prodotti: libri, elettronica (esclusi gli elettrodomestici), fashion e beauty.
La ricerca, inoltre, ha preso in considerazione solo retailer attivi sia con negozi fisici che virtuali e, come ha precisato Riccardo Mangiaracina, co-fondatore del B2c Logistics Center, raggiunto al telefono da Materia Rinnovabile, si è concentrata solo “su ordini allestiti su territorio italiano”.
Infine, per diversificare le casistiche, sono stati analizzati tre diversi contesti geografici: una grande città con molti negozi diffusi capillarmente (Milano), una città di provincia con meno scelte commerciali (Ferrara) e un contesto più rurale, da cui si suppone ci si debba spostare in auto per raggiungere i centri commerciali (province di Viterbo e Rieti).
Scelte di metodo
Delimitati i confini dello studio, si passa alla metodologia. “Non abbiamo usato il sistema del censimento né un modello statistico a campione – ci spiega Roberto Liscia, presidente di Netcomm – Il team di ricercatori del Politecnico ha elaborato per noi un complesso modello econometrico che fosse rappresentativo del fenomeno che volevamo esaminare.”
Qui si pone però il primo problema: il B2c Logistics Center ha preferito costruire il proprio modello piuttosto che servirsi di uno standard internazionalmente riconosciuto come, ad esempio, il Life Cycle Assessment (LCA). È chiaro che elaborare un sistema analitico ad hoc consente una maggiore aderenza al fenomeno che si vuole descrivere, ma fa perdere la possibilità di confrontare i risultati su basi comuni con altre ricerche. Ce lo conferma Fabio Iraldo, direttore del Green Economy Observatory presso l’Università Bocconi ed esperto di metriche per la sostenibilità. “Non ci sono abbastanza informazioni per poter valutare il metodo applicato – ci scrive via mail – Sicuramente, però, se non si basa su un approccio LCA i risultati non sono da considerarsi attendibili. Come è noto, infatti, qualunque metodo che non consideri tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto rischia di ignorare fasi a impatto molto significativo, in grado di incidere sulla valutazione complessiva sotto il profilo ambientale.”
In effetti, come notato da Iraldo, è piuttosto complicato capire fino in fondo le scelte metodologiche, visto che le fonti e i dati puntuali non vengono condivisi dagli autori del report (neanche su richiesta). “I dati – ci spiega Mangiaracina – derivano da nostre interviste ai principali player italiani che coprono una fetta del mercato superiore al 50%.” Nel report sono indicati come collaboratori alla ricerca gli operatori di e-commerce e consegne GEL Proximity, InPost, Mail Boxes Etc. Italia e Poste Italiane, e i servizi di ritiro PrimaEdicola.it, TYP e Fermopoint. Mancano però i dati diretti di grandi retailer internazionali come Amazon e Shein, primi due nella top-five del mercato italiano degli acquisti online. “Questo perché abbiamo considerato solo ordini che partissero da magazzini situati in Italia – precisa Mangiaracina – Includere un pacco proveniente, ad esempio, da un magazzino in Cina avrebbe complicato troppo il modello.”
Ed ecco il secondo punto critico: la semplificazione. Nell’ottica di circoscrivere il più possibile il segmento della catena logistica che si voleva analizzare, i ricercatori hanno fatto delle scelte che sollevano qualche perplessità. “Assumendo di considerare la rete di un generico retailer attivo sia nel canale online sia nel canale offline – scrivono nell’introduzione al report – è stato considerato come punto di divergenza dei tre processi [home delivery, punto di ritiro e negozio, ndr] il magazzino da cui vengono evasi sia gli ordini online sia gli ordini di rifornimento al negozio, escludendo dunque le emissioni del magazzino stesso.” Insomma, ci si concentra solo sulla fase del trasporto dei pacchi, includendo anche le emissioni degli hub dei corrieri. Fin qui tutto bene.
I dubbi cominciano a sorgere quando nel conteggio di emissioni a carico degli acquisti offline vengono inclusi tutti gli impatti del negozio: non solo il flusso di prodotti, ma anche il totale dei consumi energetici e il consumo di suolo. Ma se per assurdo tutt’a un tratto sparissero i negozi, i prodotti stipati sugli scaffali o nei retrobottega non avrebbero comunque bisogno di un posto dove stare, ovvero di un magazzino che consumerebbe comunque dell’altro suolo e dell’altra elettricità?
Insomma, in questo modo il commercio online diventa incredibilmente più “leggero” rispetto a quello tradizionale. In un acquisto offline, infatti, il mantenimento del negozio genera il 70-80% delle emissioni, tranne nei casi in cui il tragitto in auto sia particolarmente lungo (in provincia) e arrivi a produrre circa metà delle emissioni. Questo significa che se si eliminasse la “quota negozio” dagli acquisti tradizionali, la bilancia degli impatti si capovolgerebbe e l’e-commerce rimarrebbe più sostenibile solo nel caso in cui il consumatore dovesse affrontare un lungo viaggio appositamente per acquistare quel determinato prodotto.
Il problema dei resi
Nella bilancia degli impatti ambientali dello shopping ci sono ancora un paio di voci importanti: il packaging e i resi. In entrambi i casi è noto e più o meno riconosciuto universalmente che l’e-commerce ha impatti maggiori del commercio tradizionale. Su imballaggi e over-packaging la ricerca di Netcomm non fornisce tuttavia dati puntuali, pur dichiarando di includere le emissioni relative nel conteggio totale dell’impronta carbonica.
Sul problema dei resi invece si spende qualche parola in più. La percentuale stimata dei prodotti riportati in negozio o rispediti al retailer online tramite posta o corriere varia ovviamente a seconda della tipologia. Se per i libri e i cosmetici è minima (tra lo 0,5% e l’1%), cresce per l’elettronica (3% al negozio e 6% online) e soprattutto per l’abbigliamento, dove la differenza fra acquisti tradizionali ed e-commerce si fa notevole: per i primi il tasso di reso del fashion è dell’8%, mentre per l’online si arriva al 30%. E si tratta, come specificano gli autori, di percentuali italiane, più basse rispetto a quelle europee e globali, che si aggirano intorno a una media del 20-30% per tutti i prodotti e arrivano fino al 50% per i capi di abbigliamento (dati Statista).
Dei resi, lo studio di Netcomm calcola tuttavia solo le emissioni derivanti dalla logistica di ritorno, ovvero il viaggio per riportare il prodotto in magazzino. Ma è ormai appurato che quello è il meno: la vera piaga ambientale della cattiva abitudine di restituire i prodotti senza usarli è la loro distruzione. Per i retailer online risulta infatti più conveniente liberarsi dei pacchi tornati indietro, piuttosto che tenerli per mesi o anni in deposito o farsi carico della riconsegna al produttore. Quanti abiti, scarpe e accessori vengano distrutti ogni anno prova a stimarlo un nuovo report pubblicato dalla European Environment Agency il 4 marzo: secondo i ricercatori del Centro tematico europeo sull'economia circolare e l'uso delle risorse della EEA, nell’Unione europea circa un terzo (22-43%) di tutti i capi di abbigliamento acquistati in rete e restituiti finisce al macero.
La pratica è chiaramente uno spreco di risorse senza appello che genera emissioni totalmente inutili ed evitabili: un fenomeno contro cui qualche Paese, come la Francia, ha già emanato delle leggi, e l’Unione europea si sta muovendo per fare altrettanto.
Intanto però la politica del “reso gratuito” adottata da molti retailer (Amazon in testa) e fenomeni sociali come quello dei “restitutori seriali” (che ordinano capi di abbigliamento solo per provarli e rimandarli indietro) non fanno che acuire il problema, rendendo onestamente difficile definire l’e-commerce come “più sostenibile dei negozi”.
Questo articolo è disponibile anche in inglese / This article is also available in English
Immagine di copertina: Envato