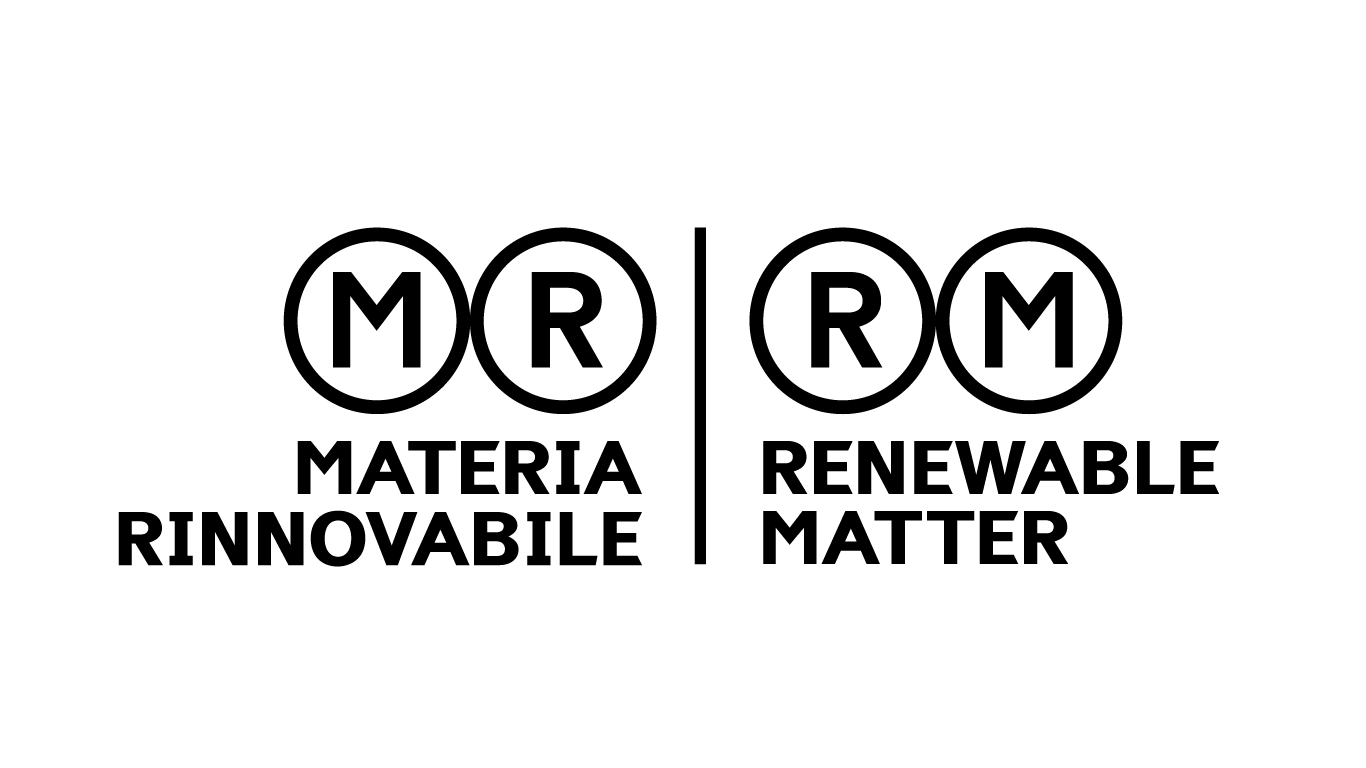“Green is the new black”, ma non nel senso glamour dello stile. Negli ultimi mesi qualsiasi fallimento industriale o problema di mercato viene immediatamente ricondotto al Green Deal europeo, assurto al ruolo di uomo nero dell’economia continentale ad alto tasso di fonti fossili. L’ultimo, eclatante, caso è quello di Stellantis, colosso dell’automotive, che ha annunciato una svalutazione contabile e finanziaria cumulata di circa 22 miliardi di euro, mandando in tilt investitori e borse e aprendo pesantissimi dubbi sulle capacità manageriali del colosso italo-francese-americano (con sede fiscale ad Amsterdam).
Stellantis dallo sbarco in borsa nel gennaio 2021 segna un pesante -49%. E dai massimi dell’intero settore automotive, toccati nella primavera 2024, il crollo pesa oltre il 76%. Una perdita che non ha paragoni con altri big come Volkswagen (-3% in 5 anni) e Renault (-5%), mentre Toyota, il primo gruppo mondiale (con 11 milioni di veicoli venduti) rimane stabile intorno ai massimi del 2024 e General Motors cresce del 128% in 5 anni.
Management, fornitori, investitori (una parte) e appassionati sembrano non aver dubbi: colpa del Green Deal e del regolamento automotive (100% emissioni zero allo scarico entro il 2035). Che il regolamento fosse eccessivo lo si è sempre saputo, e anche questa testata non è stata esente da critiche. Sarebbe stato meglio un obiettivo ambizioso (come di fatto è oggi la direttiva rivista), lasciando spazio al mercato di gestire una transizione complessa, e investendo pesantemente nel miglioramento del trasporto pubblico (basti vedere il disastro Trenord in Italia). Ciò non spiega neanche lontanamente la debacle di Stellantis. Per il nuovo CEO Antonio Filosa, in carica da giugno scorso, le cause del crack sono nella "sovrastima della transizione energetica", da parte del management che lo ha preceduto, in particolare Carlos Tavares.
Ma il problema dell’automotive italiano e del gruppo globale Stellantis non è il Green Deal, bensì quello di non essere in grado di governare una transizione complessa, quella della mobilità, che passa attraverso il cambiamento dei costumi, un contesto economico mutato (crescita rallentata dei salari), un mercato globale molto più complesso di solo quindici anni fa con l’arrivo dei colossi cinesi come BYD, Dongfeng e Geely, la necessità di tornare a fare industria e meno finanza, lavorando su materie prime e componenti.
Sui social media, migliaia di ingeneri e addetti ai lavori si strappano le vesti auspicando il ritorno del diesel e maledicendo il Green Deal, tessendo le lodi dei motori rombanti e delle cilindrate fuori scala. Una minoranza rumorosa (e in qualche caso verbalmente violenta) che in maniera sacrosanta difende il proprio feudo, ma che si sta facendo sfuggire l’opportunità di seguire il cambiamento e adattare aziende e professionalità, ostacolandolo in maniera insulsa come a suo tempo fece una parte della carta stampata di fronte all’arrivo del digitale, che oggi si sta opponendo all’AI. Sempre più consumatori e consumatrici dimostrano di apprezzare la guida di un’auto elettrica, soprattutto in provincia, dove si può ricaricare con la propria energia autoprodotta e a basso costo. Come accaduto in passato per le auto giapponesi, stanno cadendo gli stigmi delle auto cinesi, che promettono performance e stile a basso costo.
Il vero problema della penetrazione dell’elettrico nell’Europa meridionale e in particolare in Italia è l’esperienza di ricarica. Problema vero, ma stupisce come il mondo automotive e società energetiche (ENEL, ad esempio) non abbiano fatto cartello per investire in infrastrutture di ricarica capillari. Nel 2021 Stellantis, almeno in Europa, avrebbe dovuto innanzitutto puntare su quello. Brand e cavalli interessano poco alle persone comuni, che vogliono guidare e spostarsi senza problemi e difficoltà, in sicurezza, godendosi l’esperienza nel proprio abitacolo.
Questo è stato il fallimento del segmento elettrico, eredità di un altro manager disastroso per l’Italia, Sergio Marchionne, che aveva compreso perfettamente il mercato americano e aveva cercato di replicarlo in Europa, mentre gli sfuggiva il mercato italiano dalla sua casa in Michigan, ma, soprattutto, che non credette mai nell’elettrico. Un episodio famoso: nel 2014, parlando della Fiat 500e venduta in California per rispettare le regole ambientali locali, disse ai clienti di non comprarla perché ogni auto elettrica venduta faceva perdere soldi al gruppo. Era una provocazione, ma il messaggio era chiaro: non siamo in grado di far tornare i conti. Lo incontrai alla Casa Bianca nel 2009, durante l’annuncio accanto a Obama del salvataggio di Chrysler: era amatissimo e molto competente sul profilo finanziario. E soprattutto amava il petrolio e il motore a scoppio.
Questa è la cultura manageriale di Stellantis, troppo americana, troppo spostata sull’altro lato dell’Atlantico, che ha permeato un’azienda che ha il suo maggiore baricentro in Europa e che in America si è fatta schiacciare da Tesla (prima che Musk impazzisse per Trump) e dalle auto giapponesi.
Molti modelli Stellantis non sono più in linea con le tasche e il cuore di molti europei. Non si è lavorato sul taglio dei costi, su materiali e componenti, pur preservando sicurezza e stile (come hanno da sempre fatto i giapponesi e ora i cinesi), presentando macchine con prezzi medi di 30-40.000 euro. Questi prezzi, in particolare in Italia, sono spesso problematici, rendendo la mobilità uno degli elementi più rilevanti del paniere economico degli italiani (13%) molto più di quanto spendiamo in medicina e salute (incluso il wellness). Poca innovazione digitale (si veda Tesla e BYD), voglia di osare (Geely e Tesla), stile (Renault) e prezzi troppo alti rendono la grande maggioranza dei modelli Stellantis non particolarmente appetibile (con l’eccezione in Italia dell’immortale Panda, ora Pandina e i veicoli di fascia bassa di Peugeut).
A cinque anni di distanza dalla fusione FCA-PSA la performance finanziaria è praticamente nulla ora. E l’ennesimo cambio di rotta preoccupa tantissimo gli investitori. Il futuro industriale di Stellantis, infatti, sembra ancora peggiore del passato. In Italia l’azienda ha deciso di fermare la gigafactory per la produzione di batterie per le auto elettriche a Termoli, in Molise. Un impianto che avrebbe dovuto dare lavoro a oltre 1.800 persone, assorbendo dipendenti dello stabilimento di Termoli di Stellantis, che è da anni in crisi, con parecchi dipendenti in cassa integrazione. Qualcuno finirà nella fabbrica di cambi per le auto ibride, al massimo trecento persone.
Certo, sono stati pianificati 6 miliardi di investimenti in Italia, promessa fatta dallo stesso Elkann al Parlamento. Ma in cosa? In attesa di vedere la nuova strategia industriale, in arrivo il 21 maggio, Stellantis è tornata a spingere numerosi modelli diesel a livello europeo, come ad esempio la monovolume Opel Zafira. Basti ricordare i dati ACEA 2025: lo scorso anno i veicoli diesel hanno rappresentato solo il 7,7% delle vendite di auto nuove in tutto il continente, mentre le auto elettriche il 19,5%.
Dunque Stellantis scommette sul fossile e la narrativa delle destre, spingendo sul segmento degli arrabbiati ideologici, andando a rafforzare una nicchia in cui le auto cinesi e giapponesi sono meno forti. Non sembra nemmeno questa essere una strategia su cui puntare le proprie fiches. Il vento Trumpiano fossile esaurirà la sua potenza già nel 2028, e non sappiamo ancora la vera forza di penetrazione dell’Asia nel mercato Europeo. Il credo del diesel e della benzina sosterrà ancora per un decennio l’indotto delle motor valley europeo? Forse. Ma, sul lungo termine, o crollerà drasticamente il prezzo di benzina e diesel e si arresterà l’elettrificazione per mano politica, oppure per Stellantis e tante altre aziende europee sarà una Caporetto totale, con il manager italiano di Exor come epigono di Cadorna.
In copertina: John Elkann fotografato da Blondet Eliot/ABACA, Agenzia IPA