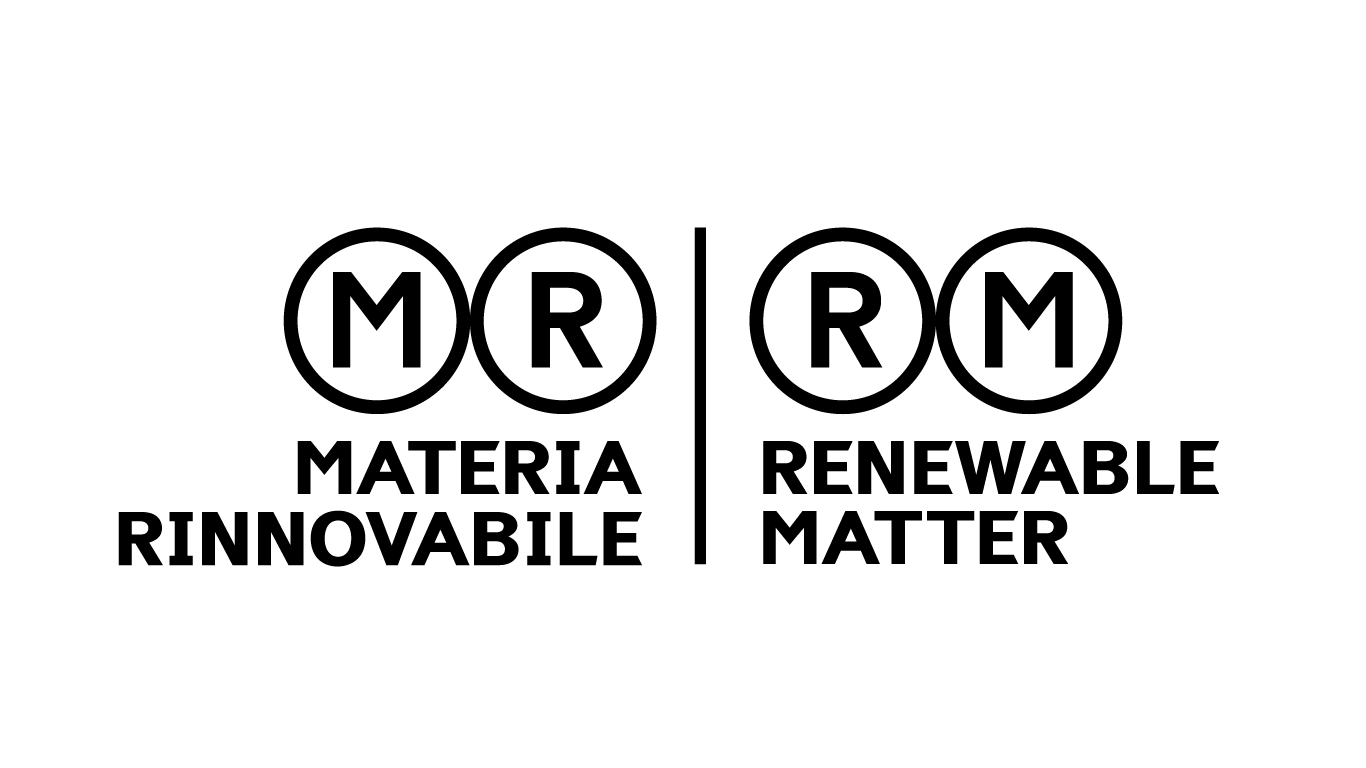Per cogliere tre frutti d’oro dal giardino delle Esperidi, Ercole aveva dovuto reggere il cielo sulle spalle al posto di Atlante. I pionieri dell’agromining sperano invece di dover fare molta meno fatica per ottenere un bel raccolto di nichel o cadmio da un campo di fiori selvatici.
Detta così, la faccenda suona un po’ alchemica. Ma in realtà l’agromining o phytomining è un filone di studi e sperimentazioni che vanta già una riconosciuta tradizione ultra-trentennale e che oggi sta vivendo un picco di interesse per via delle potenzialità sia nel recupero di risorse critiche che nella bonifica di terreni contaminati.
Tutto si basa sulla capacità delle piante di assorbire e stoccare quantità variabili di metalli dal suolo. Alcune hanno portato questa abilità ad alti livelli di specializzazione, arrivando ad accumulare elementi come nichel, cobalto, arsenico o selenio fino a cento o anche mille volte più della norma. Sono le cosiddette piante “iperaccumulatrici” e diversi scienziati in giro per il mondo stanno oggi lavorando per sfruttare questo super-potere e riuscire a ricavare elementi critici dalla terra senza scavare.
Per fare il nichel ci vuole un fiore
Una distesa di piccoli fiori gialli selvatici in un’area montuosa tra Albania e Grecia: quello che ad occhio inesperto potrebbe sembrare un comune scorcio di macchia mediterranea è in realtà una miniera, o meglio, una coltivazione di nichel. “I monti in questa zona d’Europa – spiega a Materia Rinnovabile Mirko Salinitro, ricercatore presso il dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Bologna - sono pieni di serpentino, un minerale che contiene grandi quantità di nichel. E così anche i terreni che derivano da tali rocce sono naturalmente ricchi di questo metallo, il che li rende poco fertili e praticamente inutili da un punto di vista agricolo, ma decisamente interessanti per sperimentare l’agromining”. L’area è infatti tra quelle scelte per il progetto europeo Life-Agromine, che tra il 2016 e il 2021 ha condotto sperimentazioni sul campo in 5 Paesi (oltre a Grecia e Albania, anche Austria, Francia e Spagna), ognuno con specifiche condizioni climatiche e di suolo.
“Ma le iperaccumulatrici – continua Salinitro – sono diffuse un po’ in tutto il mondo, dalle zone tropicali ed equatoriali fino al Nord Europa e Nord America. Si sono evolute in habitat molto difficili e selettivi, con poca altra vegetazione a far da cibo a erbivori e insetti. Si ritiene dunque che l’iperaccumulo di metalli sia una caratteristica sviluppata da queste specie come strategia di difesa contro gli animali”. Un esempio di questa tattica difensiva ben noto agli esperti di montagna è l’Astragalus bisulcatus, un gentile fiorellino viola a grappolo che fa impazzire i bovini che disgraziatamente lo brucano e uccide le pecore per intossicazione da selenio.
Altre iperaccumulatrici famose sono l’erba storna azzurrina (Noccaea caerulescens), che estrae zinco e cadmio dalla terra, l’Haumaniastrum robertii, ghiotto di cobalto e rame, la Biscutella montanina che ama il titanio, e due tipi di felci, la Pteris vittata che assorbe arsenico, mercurio e piombo, e la Dicranopteris linearis, amica delle terre rare. “Le specie sono comunque tantissime – precisa Salinitro - ad esempio gli iperaccumulatori di nichel conosciuti sono ben 750”. Fra tutti, il più rappresentativo e studiato è di certo l’Alisso murale o Odontarrhena chalcidica, il cui fiore giallo ha dato non poche soddisfazioni negli studi sul campo in Albania: secondo i dati dell’Università francese di Lorraine, capofila del progetto Life-Agromine, la sua coltivazione è stata infatti “ottimizzata per produrre fino a 10 tonnellate di biomassa secca per ettaro, da cui si possono estrarre fino a 150 kg di nichel”. Una resa confrontabile a quella della miniera, visto che in media il minerale estratto contiene l’1 o 2% di nichel.
Campi di alisso murale in Albania
Dai campi alle batterie
Coltivare metalli, insomma, non sembra più solo una fantasia mitologica. Ma come si arriva dal fiore al lingotto? “Va detto innanzitutto – precisa Salinitro - che il processo completo di scale-up è stato per ora messo a punto solo per il nichel, che per quanto riguarda gli affioramenti naturali è il più diffuso nel mondo: ci sono regioni, come il Borneo e Cuba, in cui addirittura il 5 o 6% del territorio è arricchito di questo metallo. Si stanno poi facendo sperimentazioni per lo zinco, il cadmio, il cobalto, il selenio, il tallio (preziosissimo per i microchip) e ci sono studi pionieri su alcune terre rare come lantanio, cerio, neodimio”.
Per quanto riguarda il nichel, si deve innanzitutto identificare un appezzamento di terreno naturalmente arricchito oppure un ex sito industriale contaminato. “Una volta scelto il campo – spiega Salinitro - si può procedere in due modi: tramite la semina diretta, come una qualsiasi coltura, oppure sfruttando le piante spontanee già presenti, favorendole con lavorazioni che eliminano le specie in competizione. Si tratta in genere di coltivazioni perenni, che vengono sfalciate una volta all’anno. Una volta raccolta, la biomassa secca viene bruciata (processo da cui eventualmente si può ricavare energia) e le ceneri, che contengono il 15-20% di metallo, vengono lavate con acido solforico, ottenendo così solfato di nichel”. Infine, attraverso un processo di calcinazione, si arriva al nichel puro, elemento critico per eccellenza nel quadro della transizione energetica, visto che è indispensabile per la fabbricazione delle batterie al litio.
Quanto è verde questa miniera?
Posto che coltivare fiori è potenzialmente un’attività più sostenibile per l’ambiente che trivellare la terra, rimane da capire quanto. “A questo proposito siamo purtroppo di fronte a un gap conoscitivo – ci dice Salinitro – Gli impatti ambientali dei processi minerari tradizionali vengono infatti stimati solo parzialmente: si valutano i consumi energetici di trasporti e lavorazione, l’impronta idrica, ma non vengono considerati il consumo irreversibile di suolo e la distruzione degli ecosistemi. Non si stimano correttamente neanche i danni dei tailings (fanghi residui della raffinazione ndr), che vengono di solito stoccati in bacini, ma che negli anni contaminano i corsi d’acqua. Insomma, non è possibile fare una comparazione di scenario completa tra il mining tradizionale e l’agromining”.
Detto questo, ci sono tuttavia dei vantaggi anche solo intuitivamente innegabili. “Il primo è sicuramente la preservazione del territorio e poi l’assenza di scarti minerari. Gli impatti sono in pratica comparabili a quelli di una coltivazione agricola, ma molto sostenibile. Non si usano infatti pesticidi, perché le piante, con tutti i metalli che assorbono, sono già tossiche e non vengono attaccate dai parassiti. L’irrigazione è minima e la lavorazione del suolo è praticamente nulla. E anche ipotizzando un rischio di agromining intensivo, un eventuale scale-up di queste coltivazioni non andrebbe comunque in competizione con le colture alimentari, come avviene invece per i biocarburanti, visto che le iperaccumulatrici crescono su terreni marginali e improduttivi dal punto di vista agricolo”.
Non va infine dimenticato il potere rigenerativo di queste piante, che vengono già in alcuni casi utilizzate per il fitorisanamento di terreni contaminati. “Ad esempio gli accumulatori di arsenico, come la Pteris vittata, sono conosciuti e sfruttati già da molto tempo”, precisa Salinitro. La criticità in questi casi è il tempo: per arrivare alla bonifica completa di un terreno attraverso il lavoro delle iperaccumulatrici servono molti anni, perché le piante estraggono quantità molto piccole di metalli pesanti all’anno, se paragonate alle quantità presenti nei siti contaminati. Del resto la Natura lavora su tempi lunghi, non conosce fretta e impazienza: forse sarebbe ora di adeguarsi.
Immagine in alto: Envato Elements