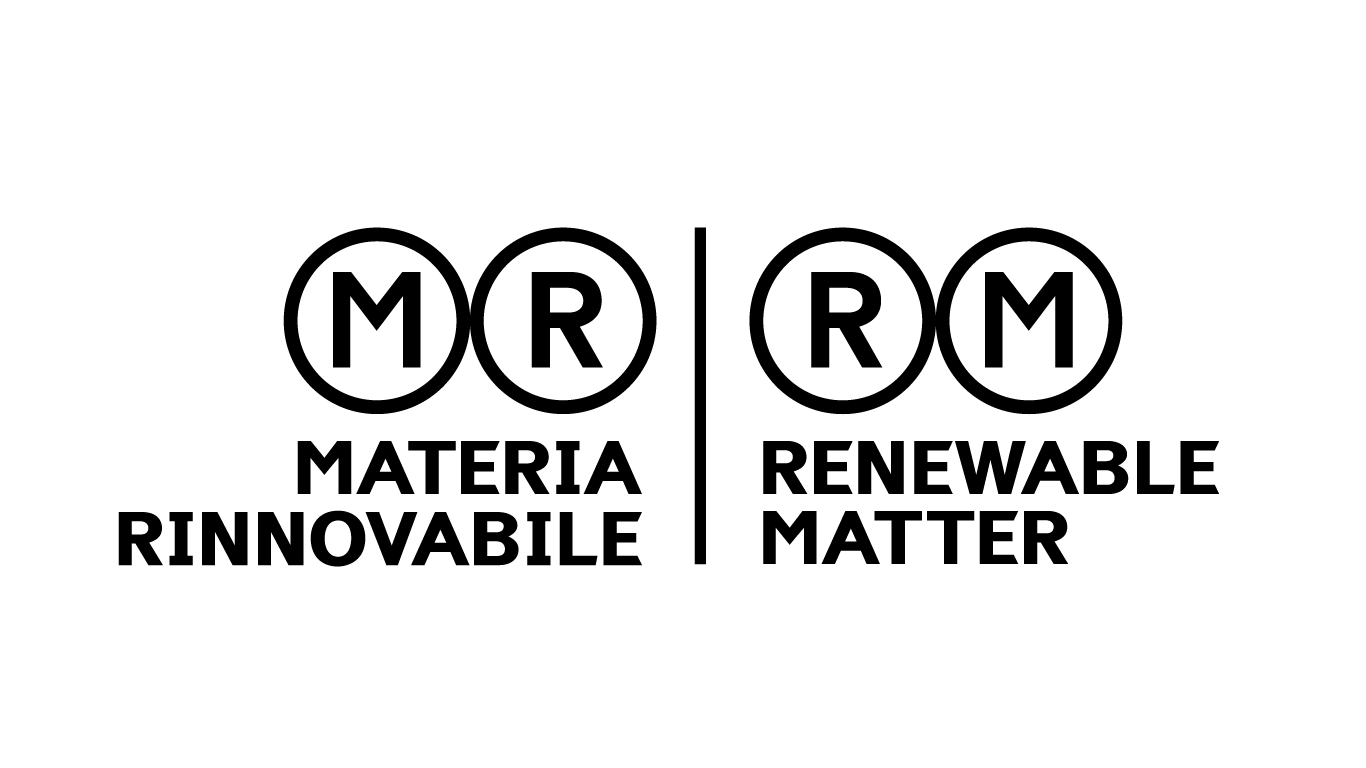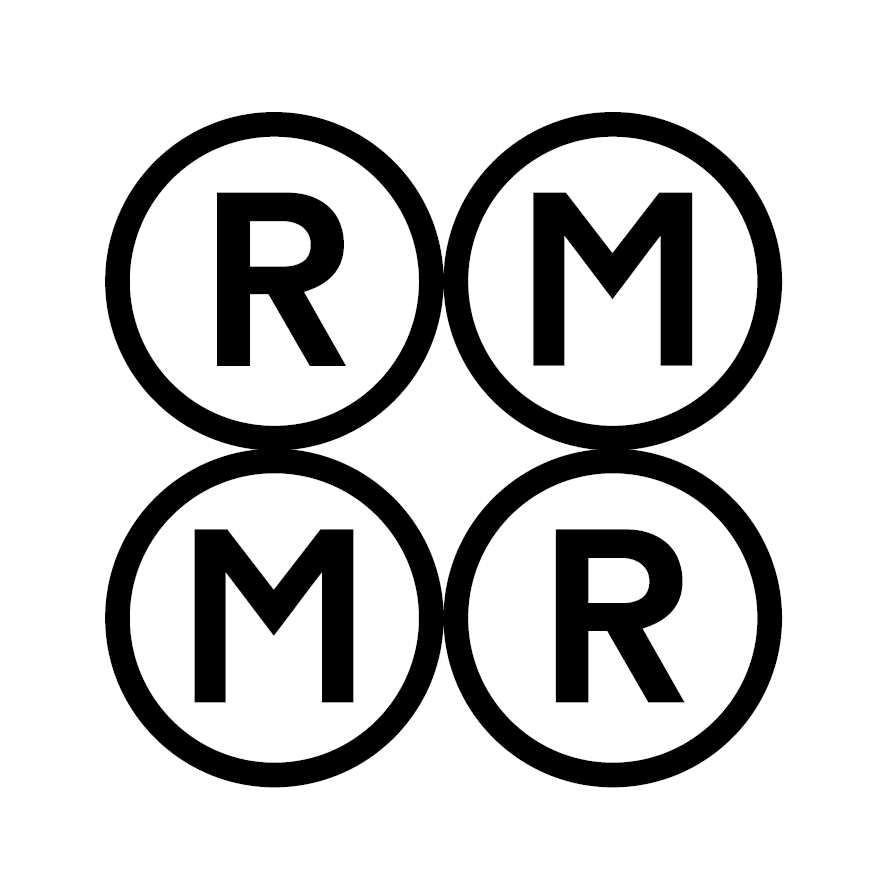Bioeconomia: è un settore che in Europa attualmente vale 2.000 miliardi di euro e 22 milioni di posti di lavoro. Eppure la parola resta spesso confinata in un ambito tecnico, quasi fosse una curiosità accademica, un luogo marginale della produzione. Addirittura non ci si intende sulla sua definizione. Un ritardo culturale che rischia di costare caro soprattutto a un paese come l’Italia che conta punte di eccellenza in questo campo. Come superarlo? Lo abbiamo chiesto a Fabio Fava, docente di biotecnologia industriale e ambientale all’Università Alma Mater di Bologna e rappresentate italiano per la bioeconomia presso i comitati di programma Horizon 2020 della Commissione europea.
“Effettivamente Ocse ed Europa danno due interpretazioni leggermente diverse del termine bioeconomia”, risponde Fava. “Io scommetterei su quella europea perché l’Europa è quella che sta investendo di più a sostegno della ricerca e dell’innovazione e ha una visione più ampia del tema: pensa alla bioeconomia come a un insieme di strategie per la valorizzazione delle risorse biologiche necessarie a produrre materie prime da cui estrarre alimenti, composti chimici, combustibili. Insomma non un semplice segmento di mercato, ma un modo per reimpostare il sistema generale della produzione tenendo presenti la questione ambientale e i limiti delle risorse”.
Capita che impostazioni teoriche molto avanzate siano formidabili sulla carta ma zoppicanti nella pratica. La bioeconomia è una buona teoria o una realtà funzionante?
“Le rispondo con un esempio. Sette o otto anni fa le bioraffinerie non esistevano: oggi in Europa ce ne sono 37 e potrebbero crescere sensibilmente, con l’Italia che in questo campo gioca un ruolo di punta. E le bioraffinerie rappresentano solo uno dei pilastri della bioeconomia, un settore recente e in rapida crescita, in cui ricerca e innovazione hanno un ottimo andamento”.
È un percorso che per svilupparsi ha richiesto un certo numero di anni.
“Direi che per l’Europa l’orizzonte di maggior impegno è quello che va dal settimo programma quadro alla prospettiva 2020. Ed è importante il fatto che in questo periodo si è registrato un salto di qualità con l’inserimento nel pacchetto della questione mare: tutto il capitolo marino, dal tema della difesa delle coste alla produzione di risorse biologiche, oggi rientra nel campo della bioeconomia. Parliamo di microorganismi, alghe, enzimi, ma anche di trasporti e di turismo marittimo che solo in Italia vale 40 miliardi di dollari l’anno”.
Non rischia di risultare dispersiva un’interpretazione così ampia del tema bioeconomia?
“Al contrario io la trovo aggregante. Si tratta di rimettere in linea temi e problematiche che, presi isolatamente, possono avere un valore limitato ma, integrati in una strategia complessiva, costituiscono un assieme di prima grandezza che finisce per riconfigurare l’economia proiettandola avanti nel tempo”.
È un modo di definire la sostenibilità: la capacità di durare nel tempo richiede il rispetto dei tempi di rigenerazione delle risorse naturali. Ma proprio per questo non è difficile tenere assieme tutte le esigenze? Mantenere la competitività produttiva e diminuire l’impatto della produzione sui vari ecosistemi connessi?
“Certo che è complesso. Ma non è che l’impatto di un altro tipo di produzione sia più leggero. È piuttosto vero il contrario: con l’impostazione della bioeconomia i problemi vengono alla luce ed è possibile trovare soluzioni migliorative. L’Unione europea sta investendo molto in ricerca e innovazione non solo per rafforzare i singoli settori, ma per integrarli in filiere di valore nuove e inserite sul territorio”.
Facciamo qualche esempio.
“Prendiamo l’industria alimentare. In Italia ha un fatturato di 132 miliardi di euro l’anno, ha perso qualcosa all’inizio di questa lunga crisi ma ora sta ricominciando a guadagnare terreno. In Europa vale mille miliardi di euro, cioè la metà di tutta la bioeconomia e costituisce il primo settore manifatturiero (in Italia è al secondo posto, poco dopo la meccanica). È un buon risultato?”.
Sembrerebbe di sì.
“E io dico che potrebbe andare meglio. Perché i sottoprodotti, cioè gli scarti, facilmente diventano rifiuti: uno spreco assurdo. Il 30% della materia trattata non è trasformato in alimenti e viene valorizzato solo parzialmente: molto finisce in discarica. In Italia abbiamo circa 12 milioni di tonnellate di scarti del circuito agroindustriale di cui le aziende sostanzialmente non sanno che fare. Anzi, sia se vengono riutilizzate come mangimi sia se finiscono in discarica devono pagare perché qualcuno li porti via”.
Invece cosa si potrebbe farne: biogas?
“Il biogas è un’opzione trendy e rappresenta una possibilità. Ma è molto più interessante pensare di farne anzitutto composti chimici e materiali biobased e poi, con ciò che rimane, biogas, che vale molto meno sul mercato. Cioè pensare all’integrazione tra questo circuito e le bioraffinerie, i luoghi industriali in cui si producono merci a cascata, così come si fa con la raffinazione del petrolio. In questo caso si usano le risorse a disposizione, cioè gli scarti di altre lavorazioni, per realizzare composti chimici di alto pregio e materie prime. Poi, solo alla fine del processo, si utilizzano i residui per la produzione di biogas”.
Il meccanismo potrebbe espandersi con vantaggi ambientali consistenti. Ma un limite può essere la quantità di materiali a disposizione per alimentare il circuito virtuoso. E anche la qualità di questi rifiuti, visto che un buon livello di omogeneità rende più facile organizzare il ciclo produttivo.
“Per questo in primo luogo bisogna cercare di censire e organizzare l’assieme dei materiali di scarto a disposizione. Del sistema alimentare agroindustriale ho già detto. Un altro caso interessate è la foresta: in Italia la superficie boscata sta crescendo e occupa 10,5 milioni di ettari, circa un terzo del paese. In teoria quindi c’è molta disponibilità di legno, ma questa potenzialità è utilizzata in minima parte: il risultato è che importiamo per sostenere l’industria nazionale del legno invece di usare i beni che abbiamo a disposizione in casa. Per avere qualche punto di riferimento numerico, si può pensare che dalle foreste ricaviamo mezzo miliardo di euro di fatturato e 200.000 occupati, contro un sistema di lavorazione del legno che, sempre a livello nazionale, vale 28 miliardi e 410.000 posti di lavoro”.
Evidentemente c’è un problema di rapporto tra il valore – basso – attribuito alla manutenzione del bosco e il costo – più
alto – della manodopera. Se non si riescono a fare entrare nel computo del valore bosco i benefici che vengono dalla riqualificazione del territorio, dalla tutela del dissesto idrogeologico, dal turismo, i conti non tornano.
“A quei benefici, alle volte difficili da quantificare, io aggiungo un elemento molto concreto come quello delle risorse biologiche che si possono ottenere dal sistema forestale e che possono alimentare la bioeconomia. Anche perché in Italia disponiamo di brevetti che consentono
– parliamo di biocarburanti di seconda generazione – di partire non dagli amidi ma dalla cellulosa. È sempre un problema di sinergie, cioè di comprensione delle possibilità di integrazione tra le varie filiere produttive”.
Se riuscissimo a sfruttare al massimo gli scarti organici del settore agroindustriale, del sistema forestale e del ciclo di rifiuti urbani avremmo abbastanza materia prima per alimentare una rete avanzata di bioraffinerie?
“È un calcolo difficile da fare. Direi che c’è una massa potenziale di oltre 30 milioni di tonnellate di materiale organico ogni anno. È una bella quantità ma anche gli obiettivi sono importanti e inoltre è difficile immaginare un recupero totale. È anche vero che, mentre alcuni sottoprodotti come quelli che vengono dall’industria alimentare garantiscono un flusso costante e omogeneo, praticamente pronto per alimentare una bioraffineria, in altri casi, come i rifiuti urbani, la qualità è più incerta e comunque si tratta di matrici molto eterogenee. Tutto ciò suggerisce di integrare il sistema con una quota di materiali dedicati”.
Qui si apre un capitolo delicato: le coltivazione per finalità no food. È un tema su cui sta crescendo l’opposizione.
“Se non vogliamo fare un discorso ideologico bisogna valutare le situazioni caso per caso: è difficile paragonare i problemi di un’area povera dell’Africa o del Sudamerica con una regione ricca dell’Europa. Prendiamo i numeri dell’Italia. Noi abbiamo una superficie agricola che continua a contrarsi e che ha perso, se conteggiamo i terreni abbandonati o non coltivati, un milione e mezzo di ettari negli ultimi anni. Parliamo di una bella superficie. E di una superficie che non è utilizzata per produrre alimenti. Francamente non vedo il problema se in queste aree all’abbandono si sostituisce un’ipotesi di reddito legato a un sistema produttivo avanzato dedicato alla produzione di biomassa per bioraffineria. Qui non esiste una competizione tra due utilizzi del suolo: c’è una potenziale offerta di lavoro, a basso impatto ambientale, al posto della disoccupazione”.
Anche sull’impatto ambientale c’è discussione: se i prodotti delle coltivazioni vengono da lontano o se nel ciclo produttivo è stata spesa molta energia, il bilancio diventa discutibile.
“Non c’è dubbio. Ma su questi punti l’Europa ha dato indicazioni precise per la valutazione dell’impatto per esempio in termini di effetto serra. Nel modello avanzato di bioraffinerie parliamo di materie prime e prodotti che vengono realizzati in ambito locale e nel rispetto dei territori: l’idea di integrazione non funziona se io coltivo in Sicilia e poi mando il prodotto in Francia”.
Ma se gli scenari di sviluppo della bioeconomia sono così ricchi di possibilità di fatturato e di occupazione perché è tanto difficile trasformali in realtà? Cosa frena lo sviluppo?
“Le cause del ritardo sono da ascrivere a due principali fattori. Primo: una carenza di informazione (e di formazione) sulla bioeconomia e sulle sue reali potenzialità da parte dei governi, soprattutto di quelli dell’Est e del Sud dell’Unione europea. Secondo: poche informazioni tecniche puntuali sulle potenzialità e opportunità offerte dai singoli pilastri produttivi, dall’agrofood alle bioraffinerie, e insufficiente relazione con il territorio (anche nei paesi dell’Europa occidentale e settentrionale)”.
Le difficoltà nell’accettazione degli impianti da parte delle popolazioni interessate hanno un peso rilevante?
“Assolutamente sì. E su questo fronte torniamo al problema della comunicazione, in questo caso di comunicazione sbagliata: si arriva a parlare di ‘bombe biologiche’ in presenza di impianti a tecnologia del tutto sicura. Il problema è che molti non sanno cos’è una bioraffineria e si trovano impreparati di fronte ad allarmi privi di fondamento. In parte è una responsabilità anche nostra, di noi accademici che spesso pensiamo solo alla pubblicazione delle nostre ricerche su riviste di prestigio che ovviamente sono lette da esperti. C’è bisogno di rompere questa barriera e aprire a una comunicazione a tutto campo, senza riserve”.
Insomma, secondo lei ci sono buone notizie da comunicare che non vengono comunicate.
“Vengono comunicate poco, magari in occasione dell’apertura di un impianto importante, come la bioraffineria di Porto Torres, in Sardegna, con le coltivazioni dedicate di cardo: tra l’altro andare in quei luoghi è stata per me una scoperta paesaggistica straordinaria, con i campi coperti dai fiori violetti del cardo: uno spettacolo. Ecco, ci sarebbe bisogno di un racconto più dettagliato, di un flusso di notizie che permetta di capire quali passi avanti si stanno facendo e quali prospettive si aprono”.
Abbiamo parlato dell’Italia e dell’Europa, ma qual è lo scenario globale? Quali sono i competitor più forti?
“L’America, intesa come continente, produce molto e ha una grande tradizione in materia, basta pensare al Brasile che ha cominciato a produrre bioetanolo in tempi lontanissimi.
E anche la Cina ha grandissime potenzialità – abbondanza di materie prime, terreni comprati in Africa – ma sta inseguendo mercati tradizionali. L’Europa invece è partita solo da 10 anni ma con un’impostazione molto innovativa basata sull’implementazione di bioraffinerie multi-prodotto, che fanno composti chimici, materiali e combustibili: una scelta in grado di garantire maggiore sostenibilità ambientale ed economica rispetto alle bioraffinerie monoprodotto tradizionali. Soprattutto per il grande impulso che a partire dal 2007 ha dato l’avvio del settimo programma quadro. Noi non puntiamo a fare solo biocombustibile: lo ricaviamo nelle bioraffinerie ‘a cascata’ integrate, alla fine di un processo che crea prodotti ad alto valore aggiunto”.
Quanto ha investito l’Europa?
“Molto. Siamo partiti con oltre 200 milioni di euro investiti sul settimo programma quadro e altrettanti messi in campo dagli stati membri prevalentemente del Nordovest. Inoltre è stato recentemente previsto un pacchetto di 3,78 miliardi di euro per sostenere specificamente la ricerca e l’innovazione nel settore della biobased industry nel periodo 2014-2020: è la Public Private Partnership Biobased Industry sostenuta da oltre 100 partner europei del settore pubblico e privato. Oltre i due terzi di questi fondi, 2,7 miliardi di euro, viene dall’industria. Anche l’industria dunque ha fatto e sta facendo la sua parte ed è significativo il fatto che le imprese abbiano trovato un accordo per partecipare in maniera congiunta a un programma così ambizioso sulle bioraffinerie”.
Quale prospettiva si apre per i prossimi anni?
“Si prevede che al 2020 il mercato dei prodotti delle bioraffinerie varrà più di 500 miliardi di euro a livello mondiale, con l’Europa che dovrebbe aggiudicarsi il 40% della torta. Determinante sarà la capacità di ricerca e di innovazione in tutti i settori coinvolti: penso anche a quelli che non vengono in mente immediatamente. Per esempio all’evoluzione delle macchine agricole: dovranno essere progettate e modellate sulle nuove necessità per far abbassare i costi delle materie prime e consentire la raccolta dei residui agricoli da valorizzare nelle bioraffinerie”.
Un’altra opportunità per l’Italia: siamo molto ben piazzati nel campo della produzione di macchine agricole.
“E dovremo continuare ad affinare le tecniche: si va verso macchine agricole gestite con i gps. Ancora una volta la chiave vincente è la sinergia. In questa partita abbiamo ottime carte da giocare: non ci resta che farlo”.
Immagine: © Symbiot / Shutterstock