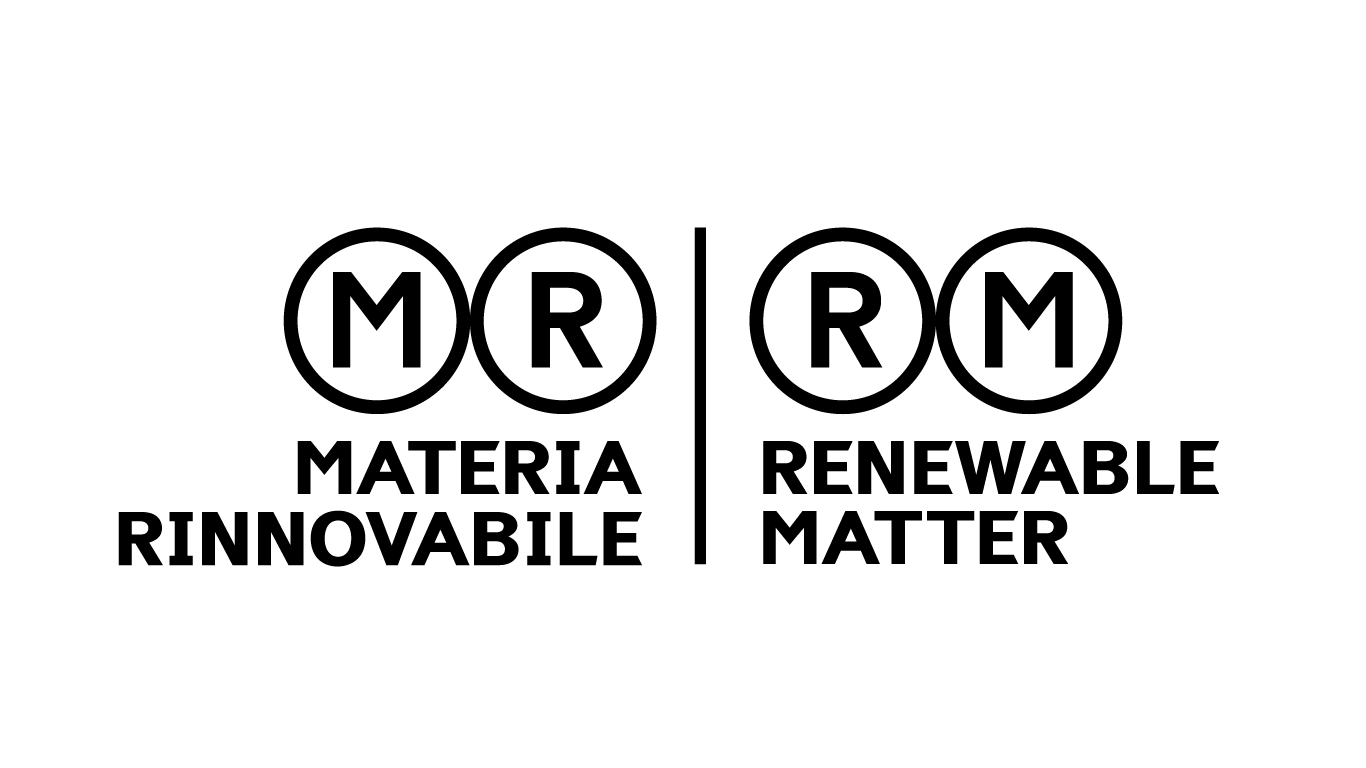Oltre che un paese di grandi stilisti e di couture, da sempre l’Italia è la patria di artigiani e imprese in grado di realizzare le idee e le visioni delle più prestigiose maison della moda, con un’attenzione maniacale alla qualità dei materiali e alla durabilità di tessuti, pelli e lane. Tuttavia, questo settore non ha saputo anticipare la transizione ecologica (ma anche culturale), ed è oggi alle prese con una trasformazione epocale. I rischi sono concreti: i maître à penser del sistema moda rischiano di essere sorpassati da nuove e giovanissime leve che pensano e disegnano vestiti in maniera circolare, mentre il mondo della produzione di tessuti, filati, pelli e accessori deve trasformare velocemente i processi produttivi.
Ne abbiamo discusso con Sergio Tamborini, Ad di Ratti e nuovo presidente di Sistema Moda Italia, una delle più grandi organizzazioni di industriali del tessile e della moda del mondo occidentale. La Federazione rappresenta un settore che, con poco meno di 400.000 addetti e poco meno di 50.000 aziende, costituisce una componente fondamentale del tessuto economico e manifatturiero italiano.

Quali sono le tendenze che vedete a livello globale come Sistema Moda Italia?
È in corso una progressiva presa di coscienza del problema della scarsità delle materie prime e dell’impatto che il settore moda ha su ambiente e risorse. Quella del tessile è una filiera complessa da trasformare, in quanto occupa circa un lavoratore su sei nel mondo. Una forza occupazionale enorme. Il problema principale riguarda il fenomeno del fast fashion, che negli ultimi anni ha raggiunto una velocità di diffusione e una schizofrenia preoccupanti. La quantità di capi prodotti è infatti fuori misura rispetto alla popolazione mondiale: in un anno produciamo 180 miliardi di capi di abbigliamento per 7 miliardi di abitanti. Siamo in un mondo in cui è più facile e meno costoso comprare un capo nuovo piuttosto che aggiustarne uno vecchio.
È necessario un ripensamento sulla durata del prodotto, dal punto di vista non solo estetico ma anche funzionale. Quello che oggi si respira non è ancora un cambio totale di struttura, ma un cambio di mentalità. Da questo punto di vista, ci sono i primi segnali in direzione di un uso circolare delle risorse, attraverso la creazione di norme come l’Epr, la responsabilità estesa al produttore, che permette l’attivazione di filiere alternative a quelle che utilizzano le sole materie prime per la produzione.
In Italia quali sono le iniziative che vanno in questa direzione?
Un passo avanti è stato fatto attraverso un decreto legislativo del settembre 2020, decreto che ha previsto la creazione di consorzi basati sulla responsabilità estesa del produttore. L’entrata in vigore del decreto era prevista nel gennaio 2022, nonostante non ci siano ancora le condizioni per attuare la transizione. È ragionevole pensare che l’Epr tessile entrerà in gioco a fine del 2022, se non durante il 2023. È auspicabile che i consorzi vengano gestiti dai produttori stessi e non dai raccoglitori di rifiuti. Ed è altresì importante che al loro interno venga applicata una logica di circolarità: in primis io produttore cerco di non produrre rifiuti, secondo riuso i prodotti, terzo li riciclo e quarto li avvio a termovalorizzazione. L’ultima tappa, naturalmente, è quella che li vede finire in discarica.
Quali saranno le aziende che beneficeranno di più dell’Epr?
È difficile determinare ora quali saranno le aziende che se ne avvantaggeranno di più. La logica dovrebbe portare alla nascita di un certo numero di consorzi obbligatori e all’impegno da parte del produttore di pagare un contributo su quanto immesso nel mercato. Tale contributo verrà versato in base al peso dei prodotti, ma anche in relazione alle tipologie (diverso è estrarre materia prima seconda da un maglioncino, piuttosto che da un cappotto). Predisponendo impianti di raccolta e cernita dei prodotti e l’attivazione di filiere di riciclo, si avrebbe poi del materiale da riportare alla sua verginità. Questo può avvenire non necessariamente in modo verticale, all’interno della filiera del tessile, ma anche andando a immettere i materiali recuperati in altre filiere. Per esempio, prodotti la cui materia prima ha un basso valore di origine, come il cotone o il poliestere, possono essere reimmessi in filiere alternative, miscelati con altri elementi. Al contrario, seta, lana e cachemire, che hanno valori unitari molto più alti, conviene mantenerli all’interno della filiera stessa. Così nasce un’economia completamente diversa e insieme si crea la necessità di fare ricerca in direzioni molto più ramificate, tra cui l’ingegnerizzazione del prodotto.
Quali settori dovranno essere inclusi e quali invece è meglio che rimangano fuori?
Come Sistema Moda Italia sponsorizziamo un modello per cui le aziende che immettono i prodotti nel mercato sono tenute a pagare un contributo. Entro fine gennaio prevediamo di attivare un consorzio trasparente, il cui obiettivo è quello di associare produttori che già possono gestire il recycling del prodotto al loro interno. Promuoveremo attività di prevenzione dei rifiuti, come facciamo nella nostra azienda, Ratti, con il riciclo delle giacche a vento. Questo è un progetto di reimpermeabilizzazione, che prevede l’eliminazione dei Pfc dal trattamento, riportando la giacca in verginità dopo un certo lasso di tempo e quindi evitandone la dispersione dei materiali nell’ambiente. In pratica, cercheremo di favorire il meccanismo per cui il consorzio si occupa del riciclo del prodotto e sviluppa attività di ricerca e innovazione, mentre le aziende che immettono sul mercato pagano per attivare la raccolta e la ricerca stessa. Per quanto riguarda la raccolta, cercheremo di coinvolgere i commercianti e i negozi di retail, mentre abbiamo già certezza di una collaborazione con Federdistribuzione. Sicuramente sarà di primaria importanza la raccolta differenziata, che passa sì attraverso i punti vendita, ma che vuole estendersi anche attraverso una ripresa dei cosiddetti cassonetti gialli nelle piazzole comunali.
Quali sono le tendenze in atto nel settore dei materiali innovativi, come i biomateriali o il ritorno della canapa?
Vorrei chiarire il fatto che sostenibilità e riciclo non sono sinonimi, ma sono anzi concetti che non sempre possono essere associati. Il riciclo può comportare l’utilizzo di energia a livelli tali per cui, in realtà, non è per nulla sostenibile. Per esempio, per ritrasformare delle maglie di poliestere di qualsiasi colore in un ammasso bianco è necessario utilizzare elevate quantità di acqua ad alte temperature e immettere prodotti chimici molto invasivi nel processo. Per poi ritingere questo ammasso viene impiegato il doppio del tempo e del colorante. Sulla sostenibilità di questo processo, quindi, c’è da discutere. Questa tendenza dovrebbe lasciare spazio a standard di misurazione, che a oggi sono ancora in via di definizione, ma che vorrebbero arrivare a delineare l’impronta ambientale del prodotto, ovvero la Pef, Product Environmental Footprint.
Qui entra in gioco un conflitto di interessi tra produttori di fibre sintetiche e produttori da fibre naturali. Aziende come Nike, H&M, Adidas fanno emergere come nota positiva la tracciabilità dei materiali per la realizzazione di capi sintetici: si sa da dove arriva il barile di petrolio, come viene lavorato, quanto carburante è necessario per il trasporto e cosi via. Ciò che potrebbe non venire considerato, però, è che nylon e poliestere rilasciano microplastiche nell’ambiente anche una volta finito il processo di produzione. Un chilo di lana proveniente da una pecora allevata in una fattoria dell’Australia o della Patagonia ha invece un’impronta ecologica molto più complessa da definire, seppur meno invasiva. Nonostante le difficoltà nella creazione degli indicatori, la Pef è uno strumento importante. Bisogna prendere atto che non sarà perfetta e che andrà modificata, ma è sicuramente un primo passo per attuare un reale cambio di sistema.
Qual è la percezione del consumatore europeo nei confronti della moda sostenibile?
Oggi si possono dividere i consumatori in due grandi blocchi: un consumatore di nuovo approccio, attento ai fenomeni riguardanti la sostenibilità dei prodotti, e un consumatore di vecchia generazione, meno preparato e meno interessato al tema. Naturalmente questa differenziazione è anche una questione culturale. Oggi siamo indotti a comprare un capo nuovo piuttosto che ripararlo, perché costa meno e perché il mercato si basa proprio sul consumo della novità riproposta a frequenze ravvicinate. Ma sono più che altro gli over 40 a essere stati abituati a ragionare in questo modo, per cui il possesso del capo nuovo rappresenta uno status, come la macchina. Mentre credo che tra i giovani si stia diffondendo una filosofia diversa, fondata sul riutilizzare i vestiti usati o farli durare più a lungo. E mi sembra stia iniziando lentamente a prendere piede anche l’abitudine a noleggiare i capi, cosa che fino poca fa si faceva solo con lo smoking o con gli scarponi da sci.
Un’ultima domanda: per quanto riguarda la sostenibilità si sta iniziando a farne anche un discorso di stile. Per esempio le ricerche sul New Bauhaus europeo puntano a capire come ci dovremo vestire in un mondo dove si va più in bicicletta, dove si tiene la casa più fresca per emettere meno e dove si passa più tempo all’aria aperta. Gli stilisti italiani stanno iniziando a fare una riflessione per cogliere il cambio culturale del momento?
Sicuramente oggi stanno cambiando profondamente i canoni del vestire e dell’eleganza. Il Covid, da questo punto di vista, è stato un grande acceleratore verso un cambio di paradigma e verso un modo più confortevole nel vestire. La divisa tipica dell’uomo occidentale – abito, camicia, cravatta, cintura e scarpe di cuoio – sta lasciando il posto a capi più comodi e agevoli. Acquisito poi un certo livello di comfort, è difficile tornare indietro. Oggi dovremo iniziare a pensare a riappesantire, irrobustire alcuni elementi del vestiario, perché ci muoveremo più a piedi, con i mezzi pubblici e con la bicicletta o comunque staremo più all’aria aperta. Da questo punto di vista la manutenzione del capo diventerà un elemento importante, al quale tutta la filiera dovrà adeguarsi. La transizione ci porterà a eliminare determinati prodotti, a ridurre delle nicchie molto parcellizzate e ad abituarci a consumi completamente diversi.
Immagine: Raden Prasetya (Unsplash)
Scarica e leggi il numero 39 di Materia Rinnovabile sulla moda circolare