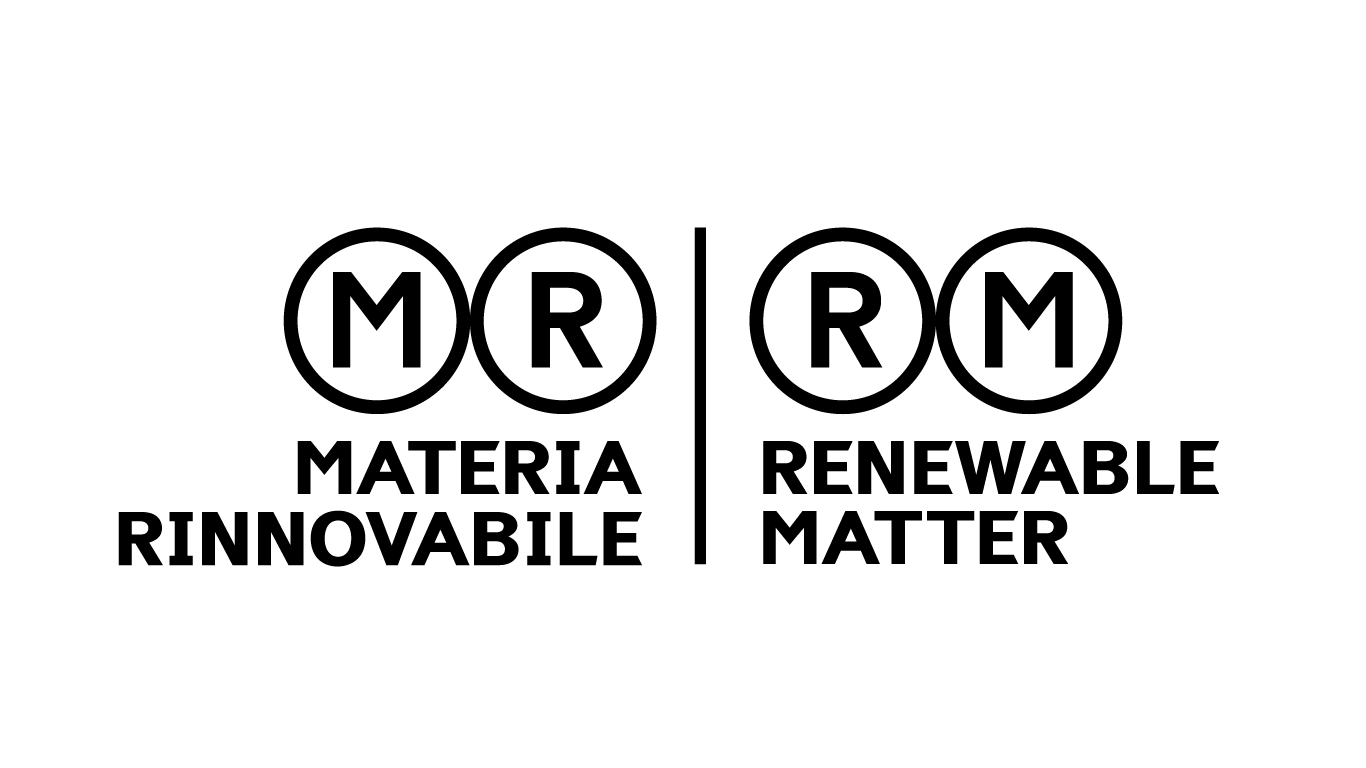Serve a tutto, lo si trova dappertutto: detergenti, cosmetici, saponi, biscotti, merendine, cibi pronti, Nutella, gelati. Parliamo dell’olio di palma, uno degli alimenti più versatili e utilizzati al mondo, ma anche uno dei più discussi.
Perché la palma e le sue bacche dove matura l’olio – una pianta originaria dell’Africa, ma trapiantata a scopo commerciale nel Sudest asiatico ormai oltre cento anni fa – prospera alle latitudini tropicali, è relativamente facile da coltivare in una piantagione industriale, e cresce vigorosa sui terreni “liberati” dall’uomo dalla foresta umida tropicale, che è uno dei principali serbatoi di biodiversità del pianeta. Il risultato è che nel giro di pochi anni sono state cancellate centinaia di migliaia di ettari di foresta primaria. Come raccontano le cronache di questi giorni, ancora oggi i terreni vengono “liberati” principalmente appiccando degli incendi incontrollati. Da gennaio si sono contati oltre 100.000 incendi, concentrati nelle foreste delle isole di Borneo e Sumatra: le immagini satellitari mostrano da settimane una miriade di fuochi, che per molto tempo si è allungata ricoprendo di un fastidioso fumo Singapore, la Malesia e il sud della Thailandia. Il disastro è acuito dal fatto che quelle foreste sorgono su depositi di torba, che bruciando rilascia CO2, e che sono difficilissimi da spegnere. Un disastro anche sanitario: si parla di problemi respiratori seri per almeno mezzo milione di persone; e un gravissimo disastro ambientale, considerando le emissioni di CO2 e la devastante distruzione di biodiversità.
Insomma, l’olio di palma va condannato tout-court come una delle principali calamità generate dalla cupidigia umana? Il discorso è un po’ più complicato: come accade per tutti i problemi complessi, a volte non è facile trovare le soluzioni semplici e nette. Sempre che esistano.
Questa fondamentalmente è la tesi di Rspo, la Roundtable on Sustainable Palm Oil, la “Tavola rotonda sull’olio di palma sostenibile”, un’associazione volontaria costituita nel 2004 per cercare di dar vita a una produzione di olio di palma meno distruttiva. L’idea è quella di coinvolgere tutti gli attori della filiera globale dell’olio (dai coltivatori ai raffinatori, dall’industria manifatturiera ai distributori, dalle banche ai consumatori alle Ong) per stabilire degli standard di sostenibilità della produzione. Chi rispetta i criteri e le politiche stabilite da Rspo, può legittimamente utilizzarne la certificazione. Finora l’associazione ha certificato oltre 12,5 milioni di tonnellate di olio di palma, circa il 20% della produzione mondiale. L’obiettivo è quello di aumentare decisamente questa percentuale, per esempio raggiungendo quota 100% di olio di palma sostenibile per le importazioni sul mercato europeo. Perché come spiegano i portavoce di Rspo, “l’unica alternativa all’olio di palma è l’olio di palma sostenibile”.
Ma non tutti, come vedremo, la pensano allo stesso modo. Molte associazioni ambientaliste già in linea di principio definiscono la stessa idea di “olio di palma sostenibile” un ossimoro (ovvero una contraddizione in termini, un’impossibilità filosofica). Altri criticano con maggiore o minore radicalità alcune delle procedure e delle politiche attuate da Rspo, auspicandone una riforma. Altri ancora, infine, hanno costituito un’associazione alternativa di certificazione dell’olio di palma sostenibile, basata su criteri più rigidi.
Resta il fatto che la filiera industriale dell’olio di palma esiste, dà lavoro e reddito a 3,5 milioni di persone soltanto in Indonesia e Malesia. E – volente o nolente – rappresenta per l’economia di questi due paesi un fattore fondamentale impossibile da cancellare con un tratto di penna senza creare sconquassi di ogni tipo.
Senza considerare poi che esiste una gigantesca domanda mondiale per quest’olio, una domanda che a breve termine dovrebbe essere comunque soddisfatta, magari da altri paesi che si troverebbero a subire le stesse conseguenze ambientali. E sempre che cancellare la palma non si riveli un rimedio peggiore del male: la palma da olio, infatti, ha una resa altissima rispetto a ogni tipo di olio vegetale. Un ettaro di terreni coltivati a palma produce quasi 3,6 tonnellate di olio, vale a dire dieci volte più dell’olio di soia o dell’olio d’oliva, e cinque volte rispetto all’olio da colza. In altri termini, per produrre l’olio utilizzato dall’industria rinunciando alla palma e usando altre tipologie di piante produttrici, ci vorrebbero molti più terreni, molta più chimica, molta più energia, molta più deforestazione, spiega Stefano Savi, direttore Global Outreach and Engagement di Rspo.
Ricapitoliamo intanto il perché del successo davvero impressionante dell’olio di palma negli ultimi decenni. Come ha fatto quello di palma a diventare l’olio vegetale più utilizzato al mondo? La prima ragione, abbiamo già detto, è rappresentata dal costo e la resa, più vantaggiosi rispetto alle alternative vegetali. La seconda invece è di tipo sanitario-alimentare: in passato le varie industrie adoperavano i cosiddetti grassi idrogenati (un esempio è la margarina) che vengono prodotti con un processo chimico a partire da alcuni oli, e che sono facilmente conservabili per lunghi periodi e poco costosi. Il problema è che tali grassi idrogenati contengono acidi grassi trans, nocivi per la salute, e a partire dal 2005-2006 sono stati bocciati sempre più dai consumatori, e poi anche dai governi dei paesi dell’Unione europea e degli Usa. L’olio di palma, invece, non presenta questi rischi, anche se come tutti i grassi saturi il suo uso non controllato ha conseguenze negative. La terza ragione poi è di tipo industriale. “L’olio di palma – spiega Savi – è quasi solido a temperatura ambiente, e quindi può essere usato per preparazioni in cui non possono essere utilizzati oli come quello di oliva o di semi, per esempio per i biscotti o le paste spalmabili”.
Certamente Rspo non nega che la diffusione delle coltivazioni di olio di palma si sono accompagnate a pesanti processi di deforestazione, come testimonia il recente haze di fumi di incendio che, pur allontanatosi da Singapore e Kuala Lumpur, continua a essere preoccupante. “Certo dipende in parte dalle stagioni – spiega Savi – la stagione secca favorisce gli incendi. Comunque la pratica del cosiddetto slash and burn (taglia e brucia, ndr) purtroppo è diffusa da sempre in molte zone del pianeta a clima tropicale e in via di sviluppo. Il problema aggiuntivo è che l’Indonesia vede una diffusa presenza di torbiere: la torba è il materiale organico che si deposita per anni nelle zone umide e paludose. È uno strato di terreno altamente infiammabile, che quando brucia produce molto fumo e anidride carbonica, ed è difficilissimo da spegnere”. In realtà sia in Indonesia sia in Malesia è vietato utilizzare queste pratiche per trasformare la foresta in piantagioni industriali, e sulla carta per poterlo fare bisogna avere una speciale concessione da parte del ministero addetto. Ma naturalmente in paesi tanto vasti e poco sviluppati (e, aggiungiamo noi, ad alto tasso di corruzione) è pressoché impossibile controllare e verificare. “Noi di Rspo – prosegue l’esponente dell’associazione – in ogni caso imponiamo che dove c’è una concessione regolare la coltivazione di palma deve comunque mantenere parte delle foreste primarie e di quelle secondarie ad alto valore di conservazione. Le nostre linee guida indicano chiaramente che il fuoco non può essere utilizzato per sviluppare una concessione, e non va usato mai se non in casi estremi, come quando ci sono invasioni di parassiti che minacciano la piantagione. Casi che comunque vanno affrontati con degli incendi controllati, e sempre comunicati a Rspo”. E se si verificano incendi anche nelle piantagioni certificate? “Ovviamente, un meraviglioso sistema di controllo serve a poco se intorno alla concessione infuriano gli incendi, come sta avvenendo ora. In ogni caso quando viene identificato un possibile incendio, Rspo chiede al membro interessato di dirigersi in loco con una fotocamera collegata a un Gps per verificare l’effettiva situazione sul campo”, è la risposta di Savi. Vero è che a parte i casi in cui c’è un’effettiva verifica in loco, normalmente Rspo si limita a utilizzare immagini satellitari – peraltro le più aggiornate risalgono al dicembre del 2013, visto che i governi di Indonesia e Malesia non rendono disponibili per monitoraggio pubblico quelle più recenti – incrociate con delle banche dati geolocalizzate. “Il grosso del nostro lavoro di controllo si fa via satellite e non con una presenza fisica – chiarisce Savi – poi i membri devono mandare dei report che successivamente possono essere controllati sul territorio da noi o da personale delle organizzazioni esterne presenti sul territorio che aderiscono a Rspo, come le Ong”.

Dunque, a volte sembra quasi che il lavoro di Rspo sia simile al tentativo di svuotare l’oceano con un secchiello, anche se Savi sostiene che ci sono stati progressi importanti, e che esaminando le immagini satellitari degli hotspot degli incendi, negli ultimi mesi le performance delle piantagioni certificate sono molto superiori rispetto a quelle non certificate. Quel che è certo è che Rspo è un’associazione di tipo volontario: “l’unica penalità che possiamo dare a un membro che non collabora e non rispetta i nostri vincoli è quella di espellerlo dall’organizzazione”. Una punizione che però non soddisfa appieno la direzione di Rspo, che preferisce altri metodi. “Da una parte l’allontanamento di chi non rispetta gli standard va bene per tutelare la nostra immagine e la nostra credibilità, ma non è la soluzione giusta per riuscire a trasformare in senso sostenibile il mercato, che è la nostra vision come organizzazione. Noi vogliamo influenzare i membri ad abbandonare le pratiche sbagliate. Per questo, finché vediamo che c’è una genuina volontà di voler cambiare le cose, cerchiamo di essere comprensivi con i nostri membri”.
Un atteggiamento moderato che non ha convinto tutti. Per esempio Greenpeace, che ha accusato apertamente Rspo di limitarsi a “certificare la distruzione” delle foreste, e che insieme ad altre associazioni, ad alcuni produttori e utilizzatori industriali ha contribuito a fondare un altro organismo di certificazione, la Palm Oil Innovation Group (Poig), con standard più rigidi. I critici affermano che Rspo non si oppone alla conversione delle foreste; che non si interessa delle emissioni di gas serra connesse alle piantagioni di palma; che fa poco per prevenire gli incendi di boschi e torbiere; che è troppo tollerante nei confronti di palesi violazioni dei propri standard. E soprattutto che attraverso il sistema dei cosiddetti certificati “Greenpalm” permette a chi utilizza olio di palma “sporco” di apparire come un produttore o un utilizzatore di olio “sostenibile”. La maggioranza della produzione globale di olio di palma “sostenibile” (il 72% nel 2012) in realtà è “Greenpalm”. Ovvero scambiata sulla base di certificati – che teoricamente sarebbero legati a un’effettiva quantità di olio prodotto in modo “sostenibile” – che gli utilizzatori finali possono acquistare liberamente su di un mercato a un modesto costo aggiuntivo. Il risultato è che un’industria dolciaria per esempio può rifornirsi tranquillamente di olio “sporco”, pagare un extraprezzo per acquistare i certificati, e dichiarare che invece utilizza un olio “Greenpalm”, che si intende come “pulito”.
“Attenzione – replica Stefano Savi – è vero che il certificato Greenpalm è virtuale, ma è anche vero che ogni certificato è legato a una tonnellata di olio di palma sostenibile veramente prodotta. Il caso più tipico è quello di un piccolo coltivatore, che non ha accesso fisico a un mulino certificato che gli possa comprare la produzione e assegnare un certificato Rspo. In questo caso l’unica opzione che ha è mettere sul mercato la sua produzione come non certificata, e parallelamente vendere online un Greenpalm per ogni tonnellata di olio di palma che ha prodotto nella sua piantagione certificata. I retailer, la distribuzione o le industrie possono a quel punto acquistare un Greenpalm, e associarlo a una tonnellata di olio di palma non certificato che viene utilizzato in uno dei passaggi della filiera. Certamente non si può dire che quel prodotto contiene olio di palma sostenibile, ma comunque in giro c’è una corrispondente quantità di olio sostenibile”. E i consumatori, non rischiano di essere ingannati, immaginando di acquistare un bene che è solo “indirettamente” sostenibile? “Rspo – è la risposta – ha stabilito regole molto chiare: sulla scatola dei vari prodotti, a seconda dei vari passaggi, si può scrivere che si è utilizzato olio sostenibile Rspo, oppure che acquistando quel prodotto si sta supportando la produzione di olio sostenibile”.
Ma si è in grado di affermare che non sono mai avvenuti episodi di certificazioni superficialmente concesse a produzioni “sporche”? “La certificazione è controllata, dopodiché come tutti i sistemi anche quello Rspo può avere delle pecche. Ma se si pensa che ci sia qualcosa che non va è possibile fare ricorso a un complaint panel al quale presentare le prove, e che giudica pubblicamente, diffondendo sul sito tutte le informazioni”. Più in generale, comunque Rspo non chiude la porta alle critiche. “Qualunque movimento che si impegni per un olio di palma sostenibile è ben accetto – afferma Savi – noi pensiamo che per ottenere un cambiamento effettivo, non di nicchia, occorre un coinvolgimento inclusivo di tutti i protagonisti della filiera, quelli migliori come quelli meno efficienti. Tuttavia ci siamo resi conto che ci sono effettivamente alcuni produttori che per le condizioni in cui operano, o perché riescono a esprimere delle pratiche migliori, vogliono effettivamente dimostrare di essere in grado di saper fare qualcosa di più. Quest’anno dunque il Board of Governors di Rspo presenterà un’iniziativa chiamata ‘Rspo Next’, linee guida volontarie che rispondono a queste nuove esigenze sullo stop alla deforestazione, sugli incendi, e su alcune misure di carattere sociale”.
Infine, un altro interrogativo delicato. Si riuscirà, e come, a fermare il meccanismo economico che rende conveniente la deforestazione selvaggia pur di avere un olio a prezzo più basso di quello “sostenibile”? La realtà è che oggi c’è una domanda per l’olio sostenibile e più caro – visto che comunque i coltivatori vanno economicamente incentivati, e rimborsati dei maggiori costi inevitabili per la certificazione – ma in certi mercati continua a prevalere il prezzo basso. L’Europa, per esempio, è un mercato ottimo per l’olio Rspo: per il 2020 si punta a raggiungere una quota del 100% di olio certificato, e i segnali dell’industria, dei consumatori e dei governi sono positivi. Paesi come Cina, India e la stessa Indonesia invece sono ancora parecchio indietro. Molto dipenderà dall’evoluzione green dell’opinione pubblica dei paesi emergenti. Sarebbe importante che nell’ambito delle intese globali su clima e ambiente si riescano a trovare forme di valorizzazione del capitale naturale dei paesi tropicali, che li incentivi a tenere in piedi le foreste e non ad abbatterle.
Roundtable on Sustainable Palm Oil Rspo www.rspo.org/about
Palm Oil Innovation Group (Poig), poig.org/