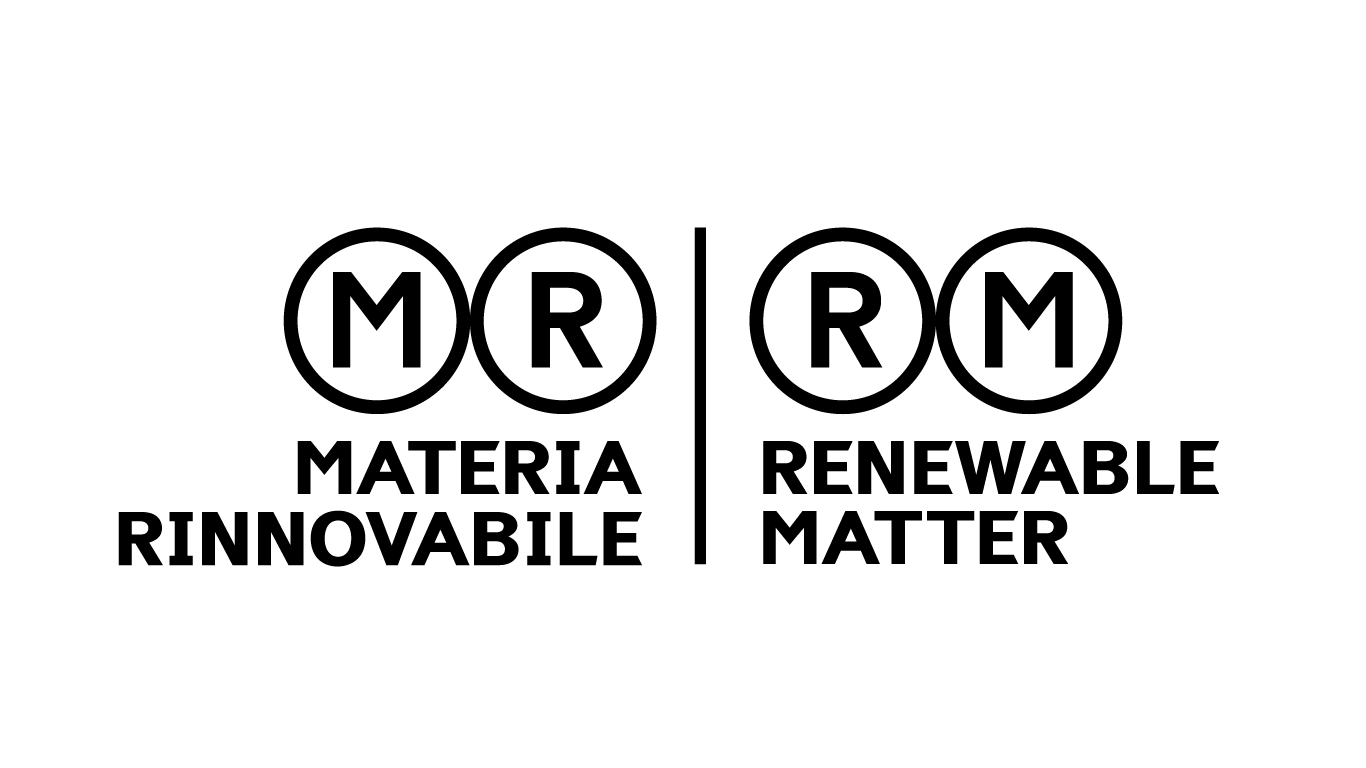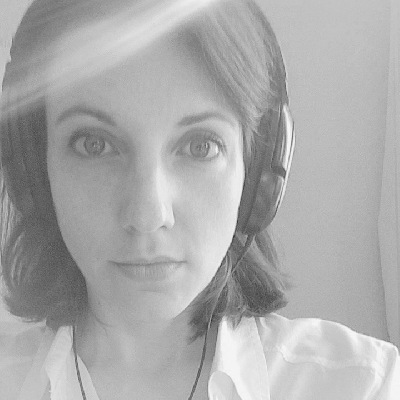Il futuro del lavoro è la flessibilità. Il consumo collaborativo salverà il mondo. Internet è la rivoluzione democratica. Queste e altre affermazioni entusiastiche hanno contraddistinto l’economia degli ultimi dieci anni, segnati dalla crisi economica mondiale e dal diffondersi capillare della rete come piattaforma per domanda e offerta. Dall’uscita di What’s mine is yours di R. Botsman e R. Rogers nel 2010, si è assistito al proliferare di tentativi di fare della condivisione e della flessibilità lavorativa un nuovo dogma: se alcuni esempi dimostrano la possibilità di creare valore in una forma meno rigida e più sostenibile da molteplici punti di vista (come Blablacar), nella maggioranza delle esperienze l’impatto con la realtà è stato traumatico e controverso da un punto di vista etico. A distanza di anni dall’introduzione di queste nuove forme di business, è possibile osservare non solo lo sviluppo dei servizi, bensì anche l’impatto che questi modelli hanno avuto nella creazione di posti di lavoro.
A livello teorico la sharing economy nella sua essenza non dovrebbe contemplare un vero e proprio impatto sul numero degli occupati se si considera che il principio originale è la valorizzazione di oggetti o energie non utilizzate o sottoutilizzate che si rendano in un ambito di volontarismo o quasi gratuità. Queste attività non potrebbero generare introiti che superino le spese, poiché si tratta di condivisione di costi. Diviene così impossibile definire il numero di persone in qualche modo occupate nella sharing economy “pura”.
Tuttavia sotto il cappello della condivisione si sono annoverate esperienze che da sharing sono diventate business paralleli, spesso non regolamentati, creando di fatto “lavoretti a cottimo” intermediati da un sistema informatico, che valuta performance e detta tariffari. Il ridesharing, Airbnb, i centri di assistenza online: esperienze che oggi sono annoverate sotto il concetto di gig economy – lavoretti intermediati da software, saltuari, fatti per integrare il proprio reddito, senza contratto, somministrati su richiesta solo quando viene richiesto o quando si può – sono invece più misurabili e rivelano il lato oscuro di questo nuovo mercato del lavoro.
Antonio Aloisi, Max Weber Postdoctoral Fellow allo European University Institute di Firenze e Teaching Fellow di European Social Law presso l’Università Bocconi di Milano, ha analizzato a lungo la gig economy. “Quelli che oggi vengono visti come ‘lati oscuri’ delle nuove economie sono dovuti a un tradimento della promessa iniziale, cioè del paradigma di condivisione e di consumo collaborativo, di rimessa in circolo di energie sottoutilizzate. L’approccio, forse un po’ ingenuo, della sharing economy ha lasciato spazio a modalità tipicamente capitalistiche che hanno preso piede poiché adottano i dettami dell’economia di mercato. Inoltre si è sostanziato un sistema che irrigidisce le forme di comando, di controllo, a fronte di una liquefazione delle responsabilità tipiche della figura del datore di lavoro.”
Di quali numeri si parla? “Numerosi centri di ricerca – prosegue Aloisi – stanno provando a misurare il numero degli occupati in questi ambiti, ma con enormi difficoltà. È infatti complicatissimo, sia dal punto di vista della raccolta dei dati e poi di analisi, sia perché per formulare le domande spesso si ha difficoltà a classificare e qualificare un certo tipo di prestazione. Inoltre accade che il lavoratore che risponde alle domande non sia neppure consapevole di poter essere annoverato tra i lavoratori della gig economy, perché magari sta continuando un lavoro che faceva in passato che oggi è mediato da un’infrastruttura digitale, senza che ciò abbia influito sulla percezione dell’occupato stesso.”
Ciò su cui tutti concordano è il consolidamento a livello mondiale della gig economy. In Italia di recente sono stati pubblicati due rapporti, il primo della Fondazione Rodolfo Debenedetti secondo cui in Italia gli occupati nella gig economy sarebbero tra i 700.000 e il milione. Il Rapporto annuale dell’Inps, l’ente di previdenza italiano, pubblicato a luglio 2018, indica invece che si possono annoverare tra i lavoratori autonomi circa il 22% della forza lavoro, a fronte di una quota Ue corrispondente al 14,5% (benché non complessivamente riconducibili alla gig economy). L’Inps ammette che vi è “estrema difficoltà nell’identificare i lavoratori appartenenti a questa categoria”, poiché le modalità di utilizzo delle piattaforme possono essere più o meno occasionali, correlate a una o a più piattaforme, vincolate a forme contrattuali blande e, in ogni caso, molto diverse da quelle tradizionali del lavoro. In particolare ciò che emerge è la comparsa in tutti i settori economici delle caratteristiche paradigmatiche della gig economy cioè il controllo, la frammentazione delle task, il pagamento a consegna o a progetto.
Nel Regno Unito gli zero hour contract (contratti con nessun obbligo di fornire ore di lavoro su base regolare da parte del datore, così come nessun obbligo nell’accettazione di eventuali proposte da parte del lavoratore) sono stati stimati per il 2017 pari al 2,7% degli occupati, secondo i dati dell’indagine delle forze lavoro. Negli Stati Uniti le analisi di Lawrence Katz e Alan Krueger mostrano come dal 2005 al 2015 la proporzione di lavoratori autonomi inquadrati in queste nuove tipologie alternative sia cresciuta del 50%. Altri dati europei emergono dallo studio condotto dall’Università dello Hertfordshire, “Working in the European gig economy”. Il numero di persone che nel 2017 hanno dichiarato di aver lavorato attraverso una piattaforma ammontano a circa il 19% in Austria, il 18% in Svizzera, il 12% in Germania, il 10% in Svezia, il 9% nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Ursula Huws, Professor of Labour and Globalisation e curatrice del report, ha confermato la difficoltà nel distinguere i lavoratori della gig economy dagli altri autonomi, indicando tuttavia “una sostanziale ‘piattaformazione’ del mercato del lavoro europeo, in cui il lavoro per le piattaforme online rappresenta parte di un ampio spettro di lavori casuali e a chiamata che si diffondono tra diversi settori e mansioni in una complessa mescolanza di vecchio e nuovo.”
Da parte di chi effettua questi studi risulta necessaria una regolamentazione per meglio identificare e tutelare queste sfuggenti forme lavorative. I tentativi di regolamentazione esistono e tuttavia data la natura stessa del fenomeno rischiano di rivelarsi infruttuosi, poiché esso continua a evolversi o a reagire rapidamente al tentativo di inquadramento da parte del regolatore. Sia in Europa sia in Usa, il dibattito è stato concentrato inizialmente sulla questione della concorrenza: è il caso di Uber, che ha portato a veri e propri scontri con le cooperative tradizionali di taxi. Su questo aspetto l’Europa ha cercato di regolamentare il boom dell’impresa americana con una sentenza della Corte europea di Giustizia dello scorso dicembre la quale ha stabilito che “il servizio offerto da Uber è di trasporto e non di incontro di domanda e offerta di servizi”. Si tratta di uno dei maggiori esempi di quel “tradimento della promessa della sharing economy” di cui racconta Aloisi, in cui il vantaggio competitivo deriva dal mancato rispetto delle regole che invece gli altri competitor che operano nello stesso settore devono ottemperare.
In Francia si è provato a normare la gig economy con la legge del 2016 (Contrat de travail à durée déterminée) la quale postula una sorta di responsabilità sociale delle piattaforme che devono assicurare alcuni diritti – come un’assicurazione contro gli infortuni, dei corsi di formazione e aggiornamento e altri diritti sindacali. Permane però la questione relativa al tipo di inquadramento: sono autonomi o subordinati? La legge è nebulosa su questo punto, ma stabilisce che chi presta lavoro attraverso queste piattaforme ha diritto a usufruire dei diritti menzionati. Regno Unito e Paesi Bassi hanno attivato commissioni di studio, l’Australia ci sta lavorando attraverso i sindacati, ma per il resto non esistono ulteriori esperienze normative. La Commissione europea, allarmata dalle possibili conseguenze sociali, ha inaugurato un tavolo di lavoro su questi temi, cambiando di prospettiva e passando dall’attenzione al mercato digitale a rafforzare il pilastro europeo dei diritti sociali. In questo contesto sono state pubblicate due comunicazioni, una sulle piattaforme digitali in generale e l’altra sull’ “economia collaborativa” – questa l’espressione che usa Bruxelles – in cui si chiariscono diversi punti, dal lavoro, alla concorrenza, alle transazioni, che, pur non essendo strumenti vincolanti, mostrano gli sforzi del legislatore europeo. È stata quindi prodotta una risoluzione del Parlamento e proprio negli ultimi mesi il focus si è spostato sui lavoratori “non standard” e si è tentato di aggiornare la direttiva sulle condizioni di lavoro (“sulle modalità di lavoro prevedibili e trasparenti”), provando inoltre a investire in una sorta di allargamento delle tutele sociali, in particolare del welfare.
Ma quali sono i settori che maggiormente vengono coinvolti dalla gig economy? Aloisi spiega che “l’economia collaborativa è data dalla somma dei due mondi, quello fisico, reale e quello digitale. In ogni caso si parla di lavoro concreto, poiché se anche lo scambio dei servizi avviene online, alle spalle vi sono sempre di persone fisiche che svolgono il servizio”. Tra i settori principali si annoverano i servizi alla persona, dal giardinaggio al baby sitting, dalla consegna dei pacchi a domicilio alla manutenzione, dalle riparazioni all’assistenza agli anziani.
“Lavori molto tradizionali che hanno semplicemente iniziato ad adottare il canale digitale come veicolo per la promozione e lo scambio dei propri servizi.” L’altro mondo è invece quello dei servizi online, spesso definiti lavori cognitivi – benché di cognitivo spesso ci sia ben poco, perché si riducono spesso ad attività molto routinarie che dall’esterno sembrano eseguite in automatico dal software in uso mentre in realtà necessitano di persone che le eseguano. Uno studio del Ceps sulla piattaforma di design per architetti CoContest (ora GoPillar) ha indicato come su scala globale, almeno per quanto riguarda i creativi di fascia alta, le piattaforme per l’offerta di servizi possano ancora oggi garantire dei risultati positivi, per esempio espandendo il raggio d’azione dei professionisti.
Destino ben peggiore sul “cognitariato” (precariato di chi svolge un lavoro di tipo intellettuale, ndr): gli impiegati della digital economy che si trovano sempre più sfruttati, a condizioni contrattuali inesistenti, spesso basati su performance. Molte di queste attività sono delocalizzate nell’Africa Subsahariana o in Asia, dove si trovano le cosiddette “click farm”, vere e proprie fabbriche, spesso in condizioni di lavoro pessime, in cui vengono gestiti un numero svariato di account da un esercito di lavoratori virtuali, controllati in maniera dispotica, tanto da venire definiti da Kristy Milland nel suo “Slave to the keyboard: the broken promises of the gig economy”, “schiavi digitali”.
Se otto anni fa i venti dell’innovazione digitale nel mercato del lavoro promettevano di combattere la crisi attraverso una rivoluzione collaborativa e flessibile, oggi invece il testo di riferimento diventa quello di Jeremias Prassl, Deputy Director of the Institute of European and Comparative Law, Humans as a service. Se i datori di lavoro attraverso le piattaforme possono selezionare i lavoratori per brevissimi periodi di tempo e senza particolari responsabilità, come fossero product-as-a-service, per lavoratori la gig economy rende la mancanza di protezioni sociali ed economiche sempre più urgenti. Rendendo infine il lavoratore a fine-vita il peggior rifiuto del pianeta: lo scarto umano.
K. Milland, “Slave to the keyboard”, www.researchgate.net/publication/317202178/download