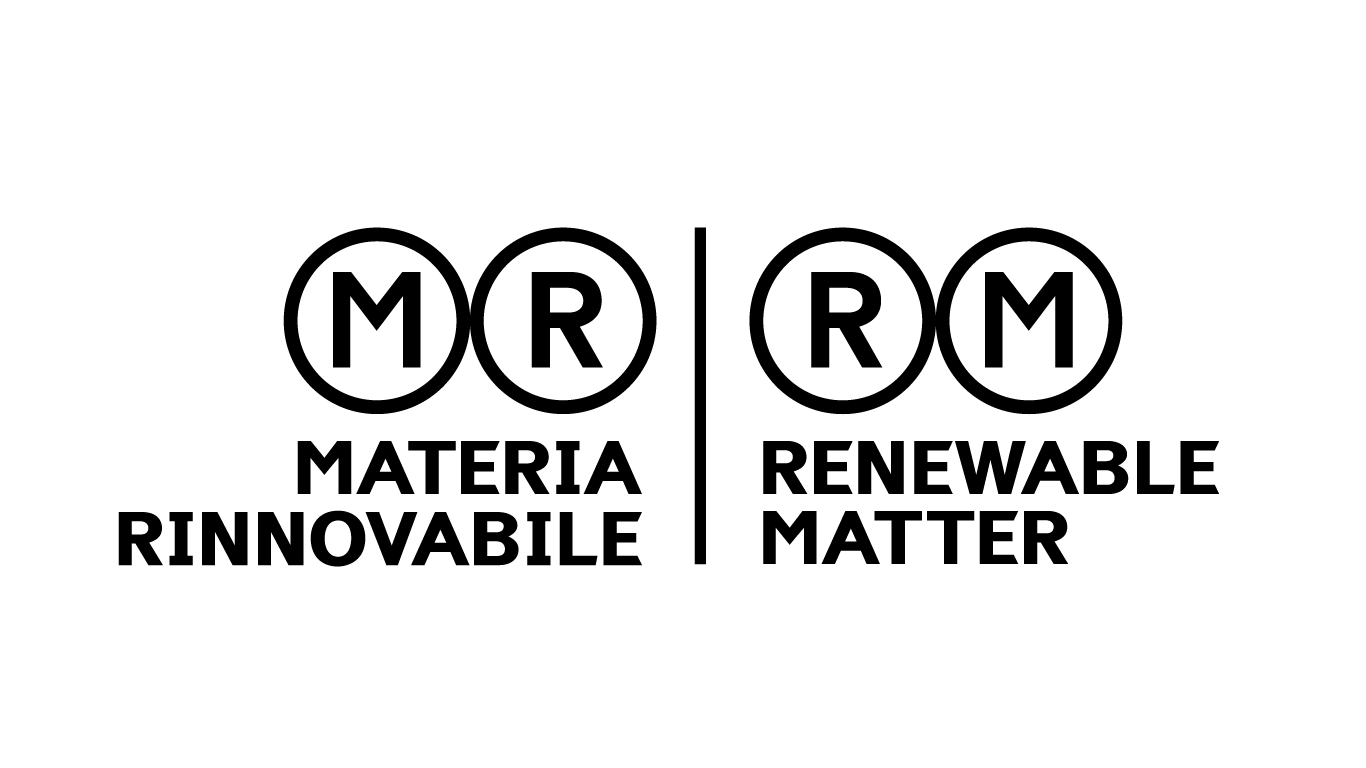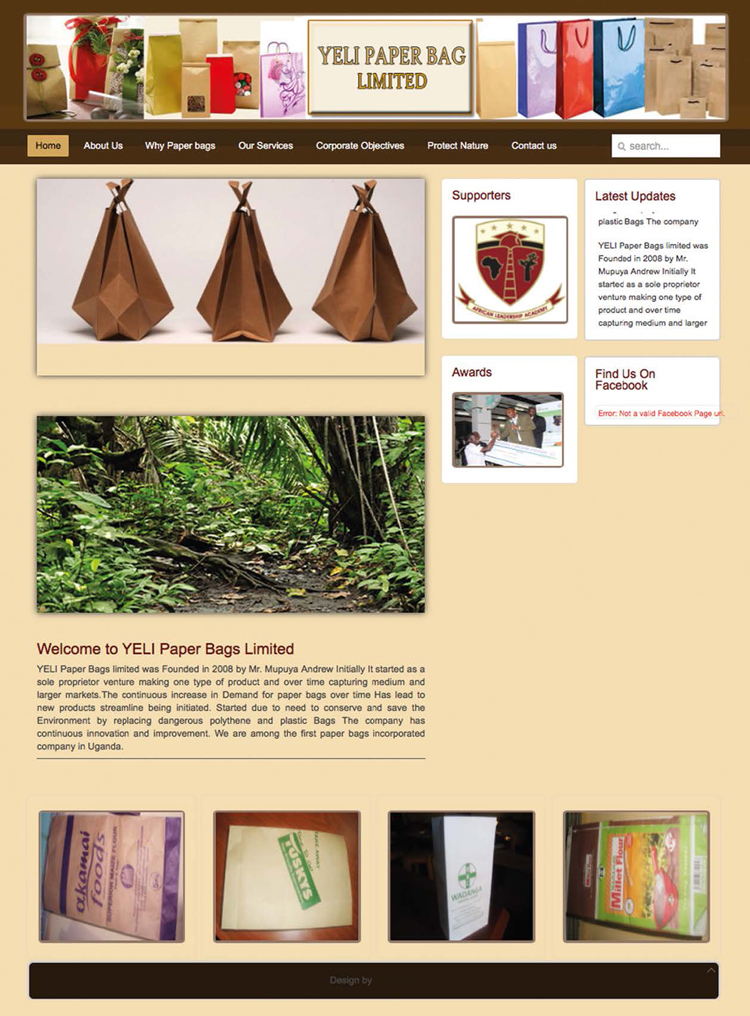Noi europei siamo abituati a pensare di essere sempre all’avanguardia nella difesa dell’ambiente. Possiamo mostrare al mondo come si protegge la natura e si riduce lo spreco di risorse. E soprattutto possiamo insegnare quel che sappiamo fare, tanto per cominciare, alle inconsapevoli e arretrate popolazioni dei paesi meno sviluppati. Bene, se fate parte dei troppi che la pensano così, forse è il caso di abbandonare tali pregiudizi e convinzioni che – semplicemente – non hanno fondamento. Un esempio su tutti: la questione dei sacchetti di plastica, su cui gli evoluti europei hanno molto da imparare da quanto è stato fatto in Africa, errori compresi.
Gli shopper sono un oggetto comune, praticissimo, ma che si è talmente diffuso da rappresentare una minaccia per l’ambiente e per noi umani: possono durare per secoli, sono un pericolo per gli animali e la natura, generano grandi flussi di emissioni di gas serra ed è difficile smaltirli. In Italia ce ne siamo accorti, tanto è vero che dal 2011 siamo uno dei pochissimi paesi europei che ha messo al bando i sacchetti di plastica non biodegradabili (anche se il traffico dei sacchetti illegali continua, purtroppo). Altre nazioni europee hanno scelto invece la strada della penalizzazione economica, introducendo tasse o imposte addizionali. Il risultato è che le buste di plastica continuano a essere largamente utilizzate e dunque a creare problemi.
Molto più coraggio, invece, hanno avuto in Africa: qui ben ventisette paesi sono ricorsi a veri e propri divieti – totali o parziali – delle buste di plastica, oltre che a forme di tassazione e penalizzazioni varie. Lo stato con la normativa forse più rigida ed efficacemente applicata è il Ruanda. Viceversa in altri paesi i divieti vengono aggirati o non rispettati, come in Mauritania o in Sudafrica. Ma gli esempi virtuosi non mancano: cominciano a nascere imprese – piccole e grandi – impegnate nella produzione di sacchetti biodegradabili o derivati da materiali non inquinanti, e inizia a ridursi l’utilizzo di quelli illegali.
Quanto siano dannose le buste di plastica, forse, non c’è neanche bisogno di spiegarlo. Pratiche, leggere, igieniche, poco costose, resistenti e riutilizzabili, ma al tempo stesso difficilissime da distruggere. Perché i sacchetti di plastica tradizionali sono fatti di polietilene ad alta densità (Hdpe), una sostanza che non si biodegrada e che se conservata in un ambiente anaerobico (per esempio in fondo a una discarica) può durare anche per mille anni. E così ce le ritroviamo in mare, nelle orrende “isole di immondizia” fatte soprattutto di plastica che galleggiano nei nostri oceani. Passando per i rami della catena alimentare, le buste e gli altri materiali plastici non solo avvelenano la fauna marina e gli uccelli, ma anche noi umani. Tutti gli additivi tossici che contiene uno shopper – sostanze antifiamma, antimicrobici e altro ancora – vengono infatti rilasciati nell’ambiente. Secondo il Wwf, ogni anno, almeno centomila tra balene, foche e tartarughe muoiono per aver incontrato sulla loro strada dei sacchi di plastica. Sulla terraferma i sacchetti fanno strage di pecore che li mangiano scambiandoli per fiori, tra gli arbusti o sugli alberi; in Mauritania – per esempio – sono responsabili del 70% delle morti degli animali lasciati al pascolo. Non solo: le buste di plastica creano grandi problemi alle infrastrutture, a cominciare dai canali, dai sistemi di smaltimento delle acque e dalle fogne, spesso del tutto intasate da questi oggetti quasi indistruttibili. Un problema ancor più serio nei paesi in via di sviluppo, dove i sistemi fognari sono meno moderni ed efficienti, e dove le acque stagnanti possono creare seri problemi sanitari per la presenza di insetti e parassiti.
Va da sé che quando parliamo di Africa non avrebbe senso attendersi né il senso civico dei cittadini, né tantomeno l’efficienza amministrativa delle varie istituzioni tipici – per esempio – di un paese scandinavo. I cittadini di questi paesi molto spesso hanno redditi così bassi da non poter sostenere né le imposte disincentivanti, né l’acquisto di sacchi alternativi e non inquinanti che costano molto ma molto di più. E non aiuta certo il fatto che in questi paesi normalmente i commercianti al dettaglio vendano ai consumatori le merci sfuse e in piccole quantità, inevitabilmente ricorrendo ai pratici sacchetti di plastica. Come non si può dimenticare che il cosiddetto “settore informale” – ovvero lo scambio e il commercio di beni e servizi sommerso o al nero, per definizione grande consumatore di plastica e lontano dai controlli delle autorità – in questi paesi rappresenta oltre l’80% dell’economia. Ancora, si comprende bene che in molti casi le autorità di controllo dispongano di mezzi modesti e abbiano ben altre gatte da pelare e priorità.
Infine, ricordiamo che a complicare ancor di più questa “guerra” in molti paesi africani c’è l’abitudine di vendere acqua (teoricamente) potabile in sacchetti di plastica, ovviamente per l’assenza di acquedotti e di fontane in grado di distribuire acqua trattata in modo corretto. Un problema serissimo per la salute pubblica, visto che a parte la possibile contaminazione dell’acqua – in molti casi appunto non potabile e fonte di malattie di ogni tipo – il polietilene sottile delle buste esposto al sole si deteriora presto rilasciando nel liquido contenuto particelle di materiale.
Il punto della situazione
Una premessa obbligata, questa, per poter dare una valutazione corretta dell’efficacia – a volte notevole, a volte invece molto modesta – delle politiche contro gli shopper di plastica.
Come detto, il primo paese africano a muoversi contro i sacchetti di plastica è stato il Ruanda, che già nel 2004 ha introdotto una prima misura disincentivante per arrivare alla loro totale messa al bando nel 2008 (introducendo però anche incentivi fiscali per incoraggiare le imprese a riciclare). A seguire l’Eritrea che li ha vietati nel 2005 e il Kenya che, dopo una prima messa al bando del 2007 sostanzialmente fallita, nel 2011 ha avviato un piano meno ambizioso e più limitato. Datato 2006 è il divieto su scala nazionale emanato dal Tanzania: la vendita o l’importazione di shopper sottili può costare l’equivalente di 2.000 dollari di ammenda e sei mesi di prigione. In Botswana nel 2007 è arrivata un’imposta che è stata riversata sui consumatori dai dettaglianti, con la ovvia conseguente riduzione dell’utilizzo. In Sudafrica è in vigore una politica simile a quella dell’Uganda: le buste di plastica più leggere – che localmente erano state chiamate i “fiori nazionali” per quanto erano diffuse e onnipresenti nei campi – sono state vietate, mentre quelle di spessore maggiore sono state tassate. A distanza di anni però il bilancio non è positivo. Pochi rispettano il divieto di usare le buste leggere; la tassa di sei centesimi di rand non è mai stata – come promesso – destinata all’attività di riciclaggio e recupero della plastica, e complessivamente la legge è riuscita solo a ridurre di circa un terzo (da 12 a 8 miliardi ogni anno) il numero delle buste di plastica utilizzate nel paese. Nell’aprile del 2015 anche il Senegal ha approvato all’unanimità una legge che proibisce la produzione, l’importazione, il possesso e l’utilizzo di shopper di plastica; lo stesso ha fatto il piccolo stato del Gambia, sempre in Africa occidentale. Altri paesi che hanno varato misure per limitare l’uso degli shopper sono la Guinea-Bissau, il Mali (dal 2013), il Gabon (dal 2010), l’Etiopia (dal novembre del 2011) e il Malawi. In Mali i deputati hanno votato all’unanimità una legge che dall’aprile del 2013 vieta produzione e commercializzazione di tutte le plastiche non biodegradabili. Per concludere con il Marocco che dal luglio 2016 ha messo al bando la produzione, l’importazione, la vendita e l’uso di buste di plastica (chiamate mika), a parte quelle utilizzate in agricoltura, nell’industria e per la raccolta dei rifiuti.
E le proteste non sono mancate in alcuni casi. È successo in Costa d’Avorio, dove è stato vietato l’utilizzo della plastica per commercializzare acqua “potabile”. Specie nella capitale, Abidjan, questo divieto ha messo in ginocchio molte piccole imprese che imbustano e vendono acqua di dubbia provenienza e pessima qualità, con conseguenti manifestazioni di piazza conclusesi con duri scontri tra polizia e manifestanti. In Mauritania dal gennaio 2013 è stato vietato l’utilizzo, la produzione e l’importazione di buste di plastica: sulla carta, chi produce sacchetti in questo grande e spopolato paese saheliano può subire una pena fino a un anno di prigione o pagare multe fino a 2.500 euro (un vero e proprio patrimonio). Anche qui però, secondo le cronache locali, finora la popolazione pur mostrandosi favorevole alla nuova norma di fatto l’ha aggirata: spesso non ci sono reali alternative all’utilizzo della buste di plastica, comunemente chiamate zazous. Secondo alcune stime ogni cittadino mauritano utilizza sette zazous al giorno, un quantitativo che sembra essersi leggermente ridotto, ma la sostituzione con buste di carta o di altro materiale non è andata realmente avanti. Per constatarlo basta fare due passi per le vie di Nouakchott, la capitale: i sacchetti sono onnipresenti, sia per terra sia utilizzati per la raccolta dei rifiuti.
Nel 2007 l’Uganda ha varato una legge che vieta la vendita delle buste di plastica più sottili, quelle di spessore inferiore ai 30 micron. Secondo molti osservatori, però, in realtà il divieto non viene rispettato, e il calo nell’utilizzo degli shopper di plastica – qui chiamati kaveera – è stato molto limitato. Il bando, scattato dal 2010, è oggettivamente rimasto soltanto teorico, e agli imprenditori del settore è stato promesso di essere coinvolti nell’attività di recupero e riciclaggio dei sacchetti teoricamente illegali. Successivamente, di fronte al sostanziale fallimento del programma è scattato un giro di vite contro i produttori di kaveera: 20 fabbriche hanno dovuto chiudere i battenti, e periodicamente l’agenzia ambientale, la Nema, effettua raid e sequestri di sacchetti illegali che sembrano provenire dal vicino Kenya. Secondo i dati della stessa agenzia ambientale, ogni anno quasi 39.000 tonnellate di buste si disperdono nell’ambiente finendo nei campi e anche nel letame animale che spesso viene utilizzato come combustibile nelle zone più povere. Il governo spende 10 milioni di scellini ugandesi (2,5 milioni di euro circa) per liberare le fognature della capitale Kampala dai sacchetti. Con qualche fatica, comunque, in Uganda stanno emergendo giovani imprenditori che hanno colto l’opportunità del bando delle buste di plastica per avviare una propria impresa. È il caso di Andrew Mupuya, oggi soltanto 24enne, che vendendo 70 chili di bottiglie di plastica vuote che aveva raccolto e facendosi prestare l’equivalente di tre dollari dal suo insegnante ha messo insieme i 14 dollari Usa necessari a far partire una “fabbrica” di buste di carta, di cui aveva appreso la tecnica di fabbricazione guardando un video su YouTube. Oggi la sua azienda, chiamata Yeli, impiega 20 persone e produce 20.000 buste di carta ogni settimana per i ristoranti e supermercati della capitale.
|
|
|
Andrew Mupuya |
In Ruanda un problema serio è quello del contrabbando. Qui i sacchetti illegali provengono dalla Repubblica Democratica del Congo, che pur avendo dal 2012 vietato commercializzazione, importazione e utilizzo di shopper di plastica ne consente la produzione su autorizzazione del ministero dell’Industria. A svolgere il mestiere del trafficante sono delle donne – coracora, vengono chiamate – che nascondono da 50 a 100 buste sotto i vestiti sfidando le perquisizioni e le multe salate: fino a 300.000 franchi ruandesi (431 dollari) per chi le vende, fino a 100.000 (143 dollari) per chi le usa. A volte, chi viene beccato dalle guardie di frontiera prende anche un bel po’ di botte. Aggirare la legge in fondo non è difficile, ma anche visivamente la differenza salta agli occhi: dalla parte congolese della frontiera, verso la città di Goma, la strada e i campi sono costellate di plastica strappata, dalla parte ruandese, verso la città di Gisenyi, non c’è quasi traccia di plastica per terra e nei campi.
In Camerun un consumatore che chiede un sacchetto di plastica deve pagare una tassa di 100 franchi Cfa, ovvero 15 centesimi di euro: una imposta molto alta. Tuttavia, anche in Camerun è relativamente facile aggirare il divieto: per adesso il bando ha sostanzialmente avuto il solo effetto di aver triplicato o quadruplicato il prezzo delle buste illegali di plastica, che in questo caso provengono dalla Nigeria e costano non poco: 5 dollari per un pacco da cento. Il governo tutto sommato si aspettava che i distributori e i commercianti – come del resto è stato fatto a suo tempo in Italia – facessero grandissime scorte di buste finché erano ancora legali, per poi rivenderle a prezzi maggiorati una volta in vigore il divieto. Per adesso solo supermercati, forni e farmacie rispettano davvero la legge offrendo (a pagamento, non certo facendo felici i consumatori) delle buste di carta. Si parla così dell’introduzione di una norma davvero draconiana: una multa dell’equivalente di 30 dollari (in alternativa a qualche settimana in prigione) per chiunque sia sorpreso con una busta di plastica.