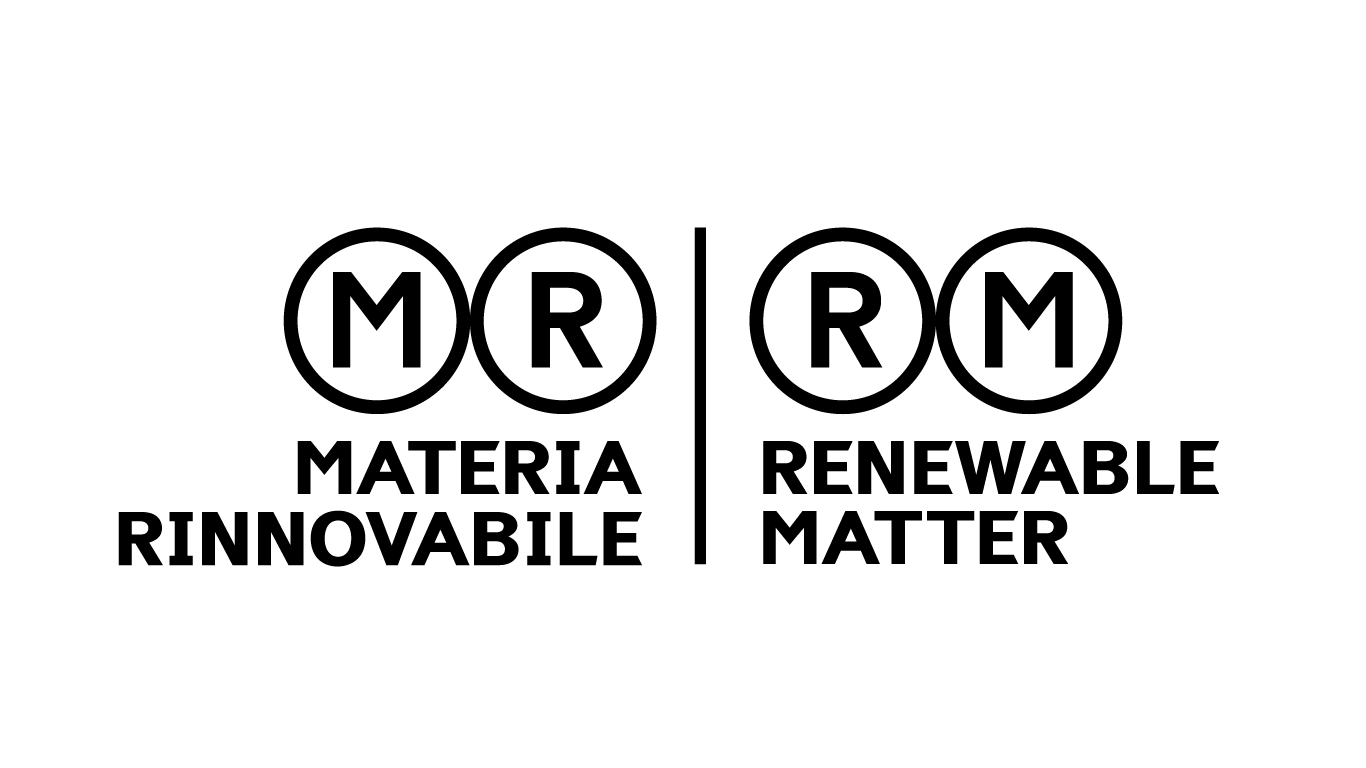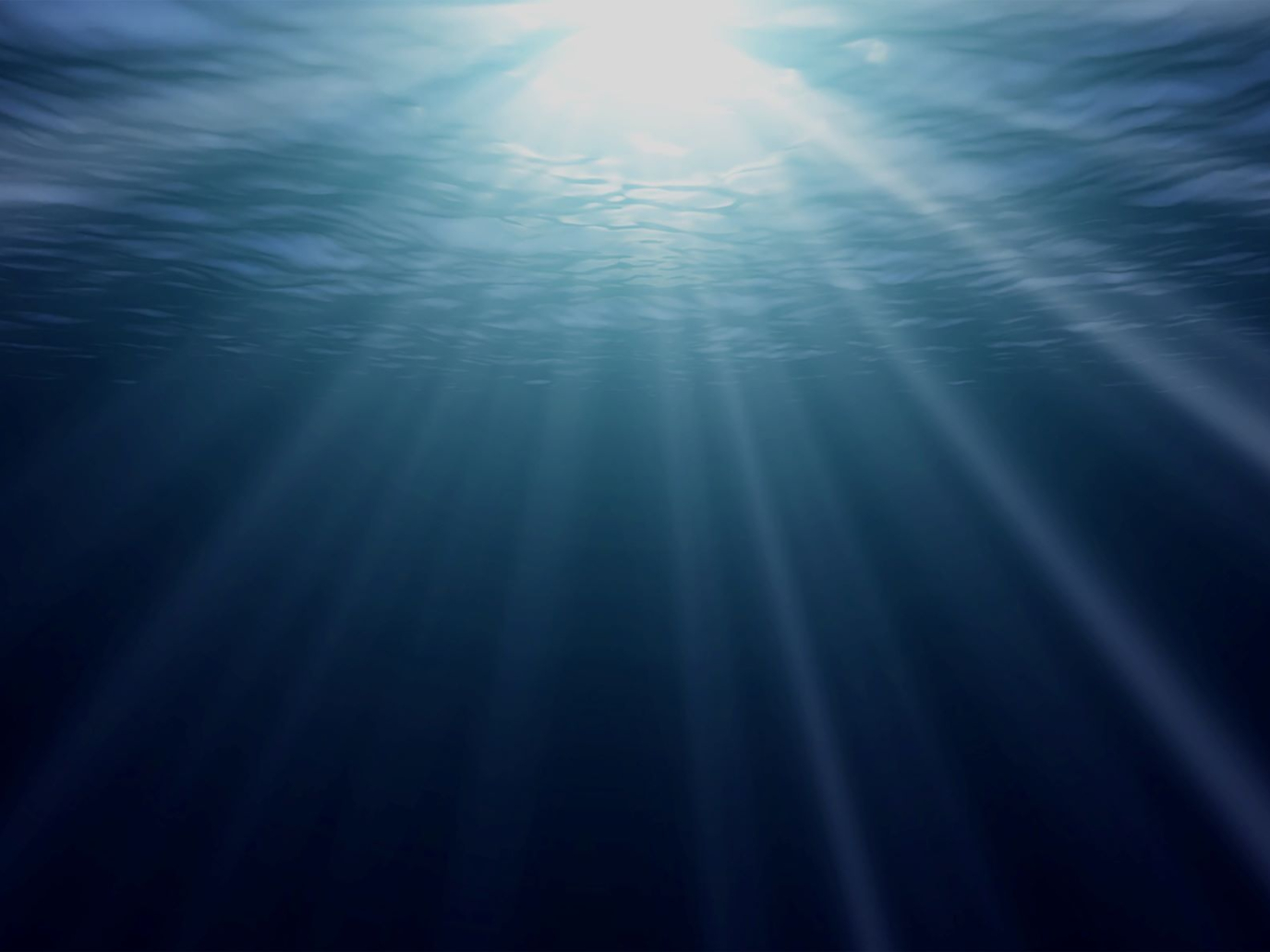La caccia ai metalli critici, più che per qualsiasi altra risorsa nella storia dell’umanità, sta abbattendo limiti e raggiungendo frontiere prima impensabili. Così, se da un lato c’è chi guarda allo spazio, dall’altro si comincia a lavorare per sfruttare l’ultimo avamposto inviolato della Terra: il fondo dell’oceano.
Lo sfruttamento minerario dei fondali abissali, o deep sea mining, è – su più livelli - una questione di tempo. C’è innanzitutto il tempo che non abbiamo più per mitigare la crisi climatica, attuando una transizione energetica che richiede e richiederà quantità esponenzialmente crescenti di materie prime: precisamente quelle che si troverebbero in fondo al mare. Poi c’è la fretta di compagnie minerarie e stati insulari in via di sviluppo, in gara per approfittare di quello che si prospetta come un nuovo eldorado dei metalli critici. Dall’altra parte c’è invece la corsa contro il tempo di scienziati e attivisti per fermare l’assalto agli abissi, e proteggere ecosistemi inesplorati e forme di vita che abbiamo appena cominciato a conoscere. In mezzo ci sono gli organismi di controllo internazionali, pressati per stabilire regolamenti, giurisdizioni e limiti, senza però avere le informazioni necessarie per farlo e un quadro scientifico su rischi e impatti che semplicemente ancora non esiste.
Pronti o no, molto presto si passerà dall’esplorazione all’estrazione: la corsa agli abissi sta per cominciare. Ma quali sono i nodi di quello che è stato definito un vero “dilemma della sostenibilità”?
I metalli in fondo al mare
Scientificamente si definisce “mare profondo” il punto dove la luce non riesce più a filtrare, dai 200 metri in giù: in pratica, il 95% del volume dell’oceano. Considerate le dimensioni e il poco che sappiamo per ora sugli ecosistemi abissali, si potrebbe parlare di un altro pianeta sulla Terra. E come su un altro pianeta, i fondali includono una grande varietà di formazioni geologiche: immense pianure abissali a profondità fra i 3500 e i 6500 metri, vulcani sottomarini, bocche idrotermali e profondissime depressioni come la Fossa delle Marianne.
Nonostante sia stata esplorata solo una piccolissima parte di questa vastità (lo 0,0001%), una cosa l’abbiamo subito notata: il fondo del mare è ricco di preziosi metalli che cominciano a scarseggiare sulla terraferma. Rame, cobalto, nichel, zinco, argento, oro, litio e terre rare, come spiega un lungo articolo di Lisa Levin, Diva Amon e Hannah Lily apparso su Nature (2020), si trovano in diverse formazioni sottomarine: nelle croste delle montagne, particolarmente ricche di cobalto; sotto forma di solfuri polimetallici in corrispondenza delle sorgenti idrotermali; nei noduli polimetallici che ricoprono le pianure abissali.
La domanda a questo punto è: quanti ce ne sono? Le stime del report citato sono da capogiro. Si parla ad esempio, solo per le formazioni montuose della Pacific Prime Crust Zone, di quantità di cobalto da 3,4 a 5 volte superiori rispetto alla totalità delle riserve terrestri. Ma l’area che fa più gola è senza dubbio la Clarion-Clipperton Zone, una faglia che arriva a profondità di 5500 metri e si estende per 4,5 milioni di chilometri quadrati nell’Oceano Pacifico, tra il Messico e le Hawaii. In questo unico spot, i noduli polimetallici contengono fino a 5 volte la quantità di cobalto terrestre, da 1,8 a 3 volte quella di nichel, 1,2 volte quella di manganese e inoltre l’equivalente del 20-30% del rame e del litio terrestri e l’88% dell’argento.
Secondo un white paper commissionato nel 2020 dalla società di deep sea mining The Metals Company (ex DeepGreen), le pepite nere della Clarion-Clipperton Zone potrebbero fornire tutto il nichel, il cobalto, il rame e il manganese necessari per un miliardo di auto elettriche, generando solo il 30% delle emissioni dell’industria mineraria terrestre.
I rischi per gli ecosistemi abissali
Quella che parrebbe una vera manna dal cielo, o meglio dal mare, potrebbe tuttavia avere dei costi molto alti, soprattutto in termini di impatto ambientale.
Il primo e più grande problema è che sappiamo troppo poco degli ecosistemi abissali per poter prevedere cosa succederebbe se li andassimo a disturbare. “I fondali oceanici sono uno dei pochi ecosistemi (relativamente) incontaminati che rimangono sul pianeta, con un mondo di biodiversità ancora in buona parte sconosciuto”, ci spiega Lisa Levin, biologa marina dell’Università di San Diego in California, che oltre ad essere la prima autrice del report sopra citato, collabora con l’Ocean Panel del World Resource Institute. “Quello che sappiamo, tuttavia, è che le specie abissali in genere crescono e si ristabiliscono molto lentamente. Per questo gli impatti di attività estrattive sulla biodiversità sarebbero enormi, potenzialmente irreversibili”.
Per immaginare gli impatti, occorre innanzitutto conoscere le tecnologie che verrebbero adottate per il deep sea mining. Si tratta di macchinari controllati a distanza per percorrere il fondale, scavando (nel caso di minerale presente nella crosta) o dragando lo strato superficiale per raccogliere i noduli polimetallici. Le pepite verrebbero poi letteralmente risucchiate da un lungo tubo idraulico collegato a una nave in superficie, dove verrebbero effettuate le prime operazioni di filtraggio per poi ributtare i residui in mare.
La prima diretta conseguenza di queste operazioni è la rimozione del substrato dove le specie abissali vivono. Per dirla con un’immagine molto chiara del biologo marino Erik Simon-Ledò: “I noduli funzionano come gli alberi in una foresta. Senza alberi, niente scoiattoli”. Ci sono poi altri tipi di impatti, come il cambiamento delle proprietà geochimiche e fisiche dei fondali, la contaminazione delle acque e il rischio di compromettere fondamentali servizi ecosistemici quali il ciclo dei nutrienti e quello del carbonio. Anche l’introduzione di luci, rumori e vibrazioni in un ambiente totalmente buio e silenzioso come il fondo del mare potrebbe avere conseguenze devastanti per la vita. C’è infine la questione dei pennacchi creati dal dragaggio o dalle navi che ributtano in mare i residui: per i delicati organismi abissali ritrovarsi da un momento all’altro ricoperti di polvere significa morte certa.
Negli ultimi anni molti report e studi hanno denunciato i rischi della corsa agli abissi: dal WWF a Greenpeace, dall’UNEP fino all’IUCN (International Union for Conservation of Nature), che nel 2021 ha chiesto una moratoria sul deep sea mining, almeno fino a quando non si sia trovato il modo di assicurare l’effettiva protezione degli ecosistemi marini, adottando il principio di precauzione e quello del “chi inquina paga”.
“La grande maggioranza degli scienziati ritiene che sia prematuro dare il via all’estrazione mineraria sui fondali oceanici – commenta Levin - Non posso dire tuttavia che l’opinione della comunità scientifica sia unanime. Ci sono diversi scienziati marini che al momento stanno collaborando con le compagnie minerarie titolari dei permessi esplorativi, soprattutto nella Clarion-Clipperton Zone, e che hanno aderito alla Deep Ocean Stewardship Initiative. Lavorano nella convinzione che fornendo una base di dati scientifici attendibili si potranno prendere decisioni avvedute. E in effetti hanno finora contribuito molto alla comprensione dell’ecologia di quell’area”.
Raccogliere invece di scavare
Nonostante le richieste di moratoria (firmate anche dai governi di vari Paesi) e gli appelli degli scienziati, sembra tuttavia improbabile che la corsa agli abissi semplicemente si fermi e cambi obiettivo. L’International Seabed Authority (ISA) ha fino ad oggi concesso 31 licenze esplorative che coprono un’area di 1,5 milioni di chilometri quadrati. Fra i contractor, “garantiti” ciascuno da uno Stato o un consorzio di Stati (questa è la regola per ottenere le licenze), ci sono colossi dell’industria, mineraria e non solo, di Stati Uniti, Canada, Europa e Cina. La macchina, insomma, si è messa in moto.
C’è chi allora preferisce adottare un approccio pragmatico. “Il problema è che il dibattito è al momento focalizzato sulla domanda sbagliata, cioè se il deep sea mining debba o no cominciare – dice a Materia Rinnovabile Renee Grogan, co-founder e responsabile della sostenibilità di Impossible Metals - Bisognerebbe invece chiedersi come si dovrà fare”. La giovane società americana si pone appunto un obiettivo che sembra impossibile: sfruttare la cuccagna di metalli critici sul fondo del mare senza danneggiare gli ecosistemi. La chiave sta tutta in un verbo: harvesting invece di mining.
“Stiamo lavorando con un gruppo di scienziati per sviluppare una tecnologia di raccolta selettiva dei noduli polimetallici – spiega Grogan – Per evitare tutti i problemi connessi al dragaggio, utilizziamo dei robot che fluttuano sospesi sopra il fondale, senza toccarlo, e raccolgono i noduli uno ad uno, lasciandone indietro una certa percentuale per garantire la continuità dell’ecosistema. Grazie a sensori e intelligenza artificiale, sono in grado di identificare la presenza degli organismi più grandi sui noduli, lasciandoli al loro posto. Riescono inoltre a creare una buffer zone attorno a organismi particolarmente sensibili, come i coralli, così da non disturbarli”. E non è finita: Impossible Metals ha pensato anche alla fase successiva, cioè l’estrazione del metallo dalla pepita. “Abbiamo sviluppato un processo di bio-estrazione – continua Grogan – In pratica utilizziamo batteri che respirano i metalli e dissolvono la roccia. Non servono agenti chimici, né calore, né alta pressione. E soprattutto in questo modo risolviamo il problema dei tailings, cioè i liquami residui della raffinazione. È un metodo che ha un enorme potenziale anche per l’industria mineraria terrestre”.
Ammettendo che il sistema della raccolta selettiva funzioni e provi di essere davvero sostenibile, non si può però fare a meno di chiedersi: per una compagnia che investe tempo e denaro per non danneggiare gli ecosistemi, quante invece sceglieranno la strada più breve e redditizia? Impedirlo sarà una questione innanzitutto di leggi e regolamenti (faccenda spinosissima, che meriterebbe un altro articolo), si tratterà di implementare metodi di monitoraggio e controllo efficaci e di definire dei limiti invalicabili. Perché il bisogno che ora abbiamo di materie prime per la transizione energetica non può compromettere quella che è la prima fonte di vita del pianeta.
Immagine: Envato Elements
Scarica e leggi il numero 43 di Materia Rinnovabile sui Critical Raw Materials.