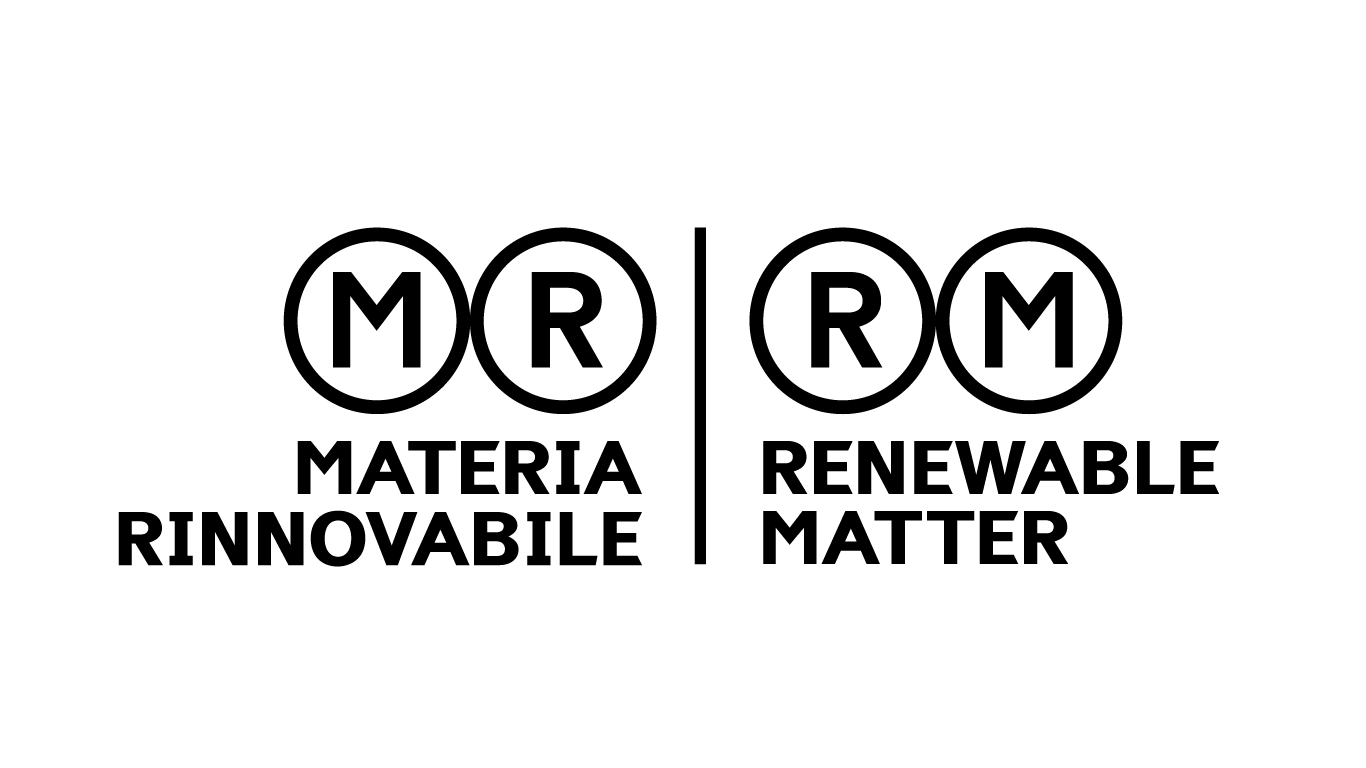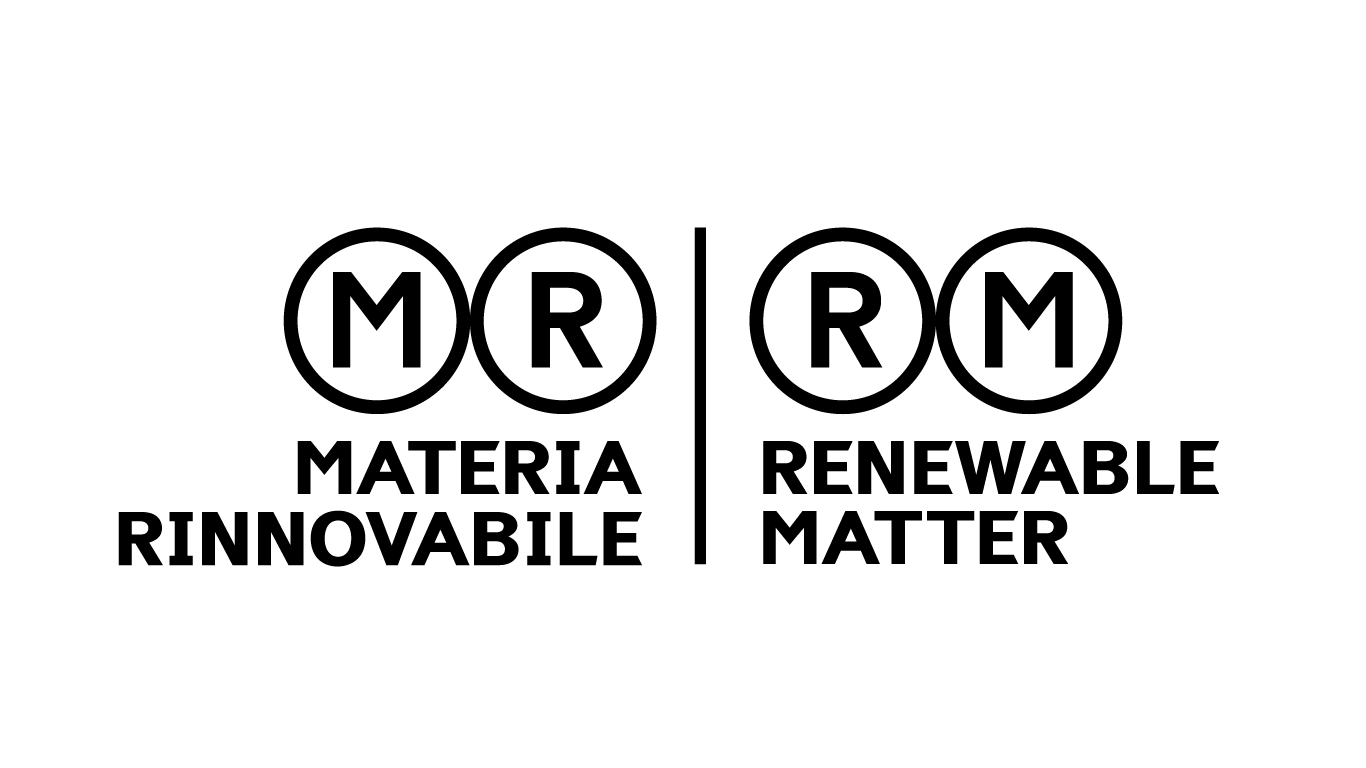L’Italia è una terra fragile, sconvolta sempre più spesso da calamità sismiche che ne modificano il profilo, colpendo uomini e distruggendo borghi, insediamenti, testimonianze artistiche. Soprattutto oggi, dopo il terremoto che si è abbattuto su regioni così dense di storia del centro Italia, causando danni devastanti, anche per effetto di un mancato adeguamento degli edifici pubblici e privati alle norme antisismiche più severe.
I temi sono innanzitutto quello della prevenzione e della ricostruzione sociale, culturale, ambientale degli insediamenti dopo la catastrofe. Le zone colpite non sono diventate solo cumulo di rifiuti, ma sono anche state distrutte nei legami tra le persone, negli affetti, nella socialità, nei rapporti con il territorio stesso.
L’arte si è rivelata uno strumento potente per ridare vita ai paesi prostrati, coinvolgere le persone, far rivivere con spirito nuovo gli ambienti devastati. Un esempio è la ricostruzione di Gibellina. La città siciliana, colpita da un terribile sisma nel 1968, è diventata un cantiere generativo di idee, bellezza e condivisione, capace di dare una nuova identità al luogo annientato e attivare la partecipazione dei cittadini, attraverso una monumentale opera di land art di Alberto Burri, un sistema di arte diffusa con opere di Schifano, Melotti, Pomodoro, nuovi edifici di Gregotti, Purini e Quaroni, il festival teatrale delle Orestiadi.
Proprio questo festival, durante la direzione artistica di Emilio Isgrò, ambientò le rappresentazioni teatrali utilizzando come quinte le rovine della città vecchia distrutta dal terremoto (che qualche anno dopo saranno coperte come un sudario proprio dal Grande Cretto di Burri). Gli abitanti della città, tornando sui luoghi della loro vecchia vita ormai in frantumi, assistettero a quegli spettacoli, e questa narrazione diede loro la forza di ricominciare.
Questo processo rigenerativo è stato analizzato dalla filosofa Serenella Iovino, nel suo recente Ecocriticism and Italy. Ecology, Resistance and Liberation (Bloomsbury). Il libro ripercorre la storia di alcuni territori italiani (Napoli, Venezia, la Sicilia, la Campania e l’Abruzzo del terremoto, il Piemonte) attraverso i corpi e gli oggetti naturali e artificiali che li compongono, e che fanno emergere una lettura originale dell’ambiente e della cultura del paese.

La copertina del suo volume è dedicata all’opera che Alberto Burri installò nella città di Gibellina (in Sicilia), completamente rasa al suolo dal sisma del 1968. Si tratta di un gigantesco Cretto (la terra spaccata) di cemento bianco. Perché quella foto è così simbolica?
“Il Cretto di Burri è il più grande monumento che sia stato dedicato a un sisma. La sua estensione copre interamente l’antica città di Gibellina vecchia, completamente distrutta dal terremoto che si abbatté sulla Valle del Belice, in quel freddissimo gennaio del 1968. La storia del Cretto è esemplare per molti aspetti. La sua creazione, circondata da non poche polemiche, è il frutto della volontà di un sindaco, Ludovico Corrao, che non volle rassegnarsi alla scomparsa del suo paese. E così, nel silenzio della collina abbandonata, ricoperta da una colata di cemento bianco che ne segue il tracciato urbano, il Cretto cattura l’ultimo grido di Gibellina vecchia, e ci racconta di un luogo che cerca di continuare a esistere come paesaggio, nonostante la distruzione. Nel suo minimalismo – paradossale e necessario, viste le dimensioni dell’opera – il Cretto è il simbolo della ferita aperta dal sisma nel corpo di quei luoghi. Ma è anche il simbolo della voglia di convertire le ferite in segni, trasformandole così in racconti, necessari per andare avanti. Certo, non è semplice raccontare queste storie, specialmente quando ci sono ferite ancora aperte davanti ai nostri occhi, come nei terremoti del 2016. E tuttavia se non si passa dal dolore al racconto, qualsiasi via per la ricostruzione, dei territori così come dell’immaginario dei luoghi, è preclusa.”
Quali furono le conseguenze urbanistiche e sociali della catastrofe?
“Furono apocalittiche. L’apocalisse, in questo caso, è quella di cui parlava Ernesto De Martino nel suo libro La fine del mondo: ossia, la perdita dell’’orizzonte di operabilità mondana’ di persone che vedono i propri luoghi scomparire. E con essi il loro passato, i loro riferimenti materiali, emotivi, narrativi. Molte città del Belice furono cancellate, e nella ricostruzione alcune furono spostate di molti chilometri rispetto ai luoghi originali, creando una frattura cognitiva e affettiva negli abitanti. Come in tutti i sismi, inoltre, la distruzione del terremoto fu spesso amplificata da opere di ricostruzione non adeguate, il più delle volte accompagnate da speculazioni. Nel caso del Belice, un grave errore fu la mancanza di un legame tra urbanistica e sviluppo economico. Alla ricostruzione dei centri abitati, infatti, si privilegiò la costruzione di infrastrutture, per esempio grandi autostrade, sovradimensionate per quei territori, ma sicuramente più redditizie per chi voleva arricchirsi. Nonostante ciò, in quest’apocalisse ci sono stati anche forti fermenti sociali. Mi riferisco alla potenza aggregativa di Danilo Dolci e di Lorenzo Barbera, già attivi negli anni prima del sisma per la rivendicazione del diritto dei contadini contro lo strapotere del latifondo e della grande proprietà terriera, oltreché della mafia. C’è stato un momento in cui la presenza delle loro organizzazioni, il Centro Studi per la Piena Occupazione di Dolci e il Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione di Barbera, ha creato una grande spinta di solidarietà. Lo racconta molto bene Carola Susani nel libro autobiografico L’infanzia è un terremoto, in cui è narrata la storia di una famiglia che, dal nord, si trasferisce nella baraccopoli di Partanna per sostenere il lavoro di Dolci. Nonostante tutte le contraddizioni della ricostruzione, quelle esperienze di solidarietà sono state importanti per la sopravvivenza sociale e storica di quei luoghi. Se lo sviluppo è stato lasciato ai margini dallo stato centrale, queste esperienze rivivono oggi nello sforzo della società locale di farsi carico di uno sviluppo più partecipativo.”

Grazie a una mobilitazione senza precedenti di artisti e intellettuali (da Sciascia, a Beuys, a Cage), Gibellina si è trasformata negli anni in una città museo di arte moderna e in un laboratorio di opere d’arte e architettura, diffuso su tutto il suo territorio. Perché lo definisce un percorso di ricostruzione, insieme di memoria e di progetto?
“Un terremoto è sempre un momento di profonda rottura. Viene cancellato l’orizzonte di senso di una vita, e con esso si perdono abitudini, luoghi, paesaggi. Il caso di Gibellina è eloquente: Gibellina Nuova, infatti, è sorta a diversi chilometri di distanza dall’antica città, con cui, a parte il nome, non condivide più quasi nulla. Ricorda un po’ la Maurilia de Le Città Invisibili di Italo Calvino. Qui, come in quel racconto, sembra di essere di fronte a città diverse che ‘si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza essersi conosciute, incomunicabili tra loro’. Gibellina Nuova però è un caso a sé stante, perché ha provato a rinascere nel segno dell’arte, e l’unica arte possibile era quella contemporanea. La sfida di Corrao sta nella convinzione che l’unico modo per far ripartire il racconto di Gibellina fosse dotarla di un altro linguaggio. Un’impresa difficile, senza dubbio; e infatti, per rendersi conto dell’ambivalenza di questa operazione, basta leggere le parole di Vincenzo Consolo, che descrive Gibellina Nuova come ‘la fiera del vuoto’, ‘la città metafisica’. E tuttavia il pensiero di Corrao e degli artisti che lo hanno seguito era che vivere in una città d’arte potesse essere fonte di energia identitaria, specialmente per i giovani di Gibellina. E anche il Cretto, negli anni, è diventato parte concreta di quest’identità evolutiva della città. Non è sempre semplice adattarsi ai cambi di linguaggio che passano per il paesaggio, specialmente se è un paesaggio domestico come quello di una città di provincia. La sfida ancora aperta, ed è una sfida per lo Stato italiano, è non trasformare Gibellina Nuova in un luogo di archeologia del presente, abbandonandola al proprio destino. Le città d’arte hanno bisogno di uno Stato che si accorga di loro prima che si disintegrino. Ci vogliono fondi e vera attenzione politica per queste realtà così singolari e significative. Il rischio che corre Gibellina è quello di disfarsi prima di essere diventata parte integrante del tessuto dell’Italia contemporanea, e in questo caso la causa non sarebbe un altro terremoto, ma semplicemente l’indifferenza.”
 |
|
Foto: Giorgio Redaelli
|
Con quali strumenti la rinascita di un territorio colpito da un cataclisma naturale può trasformarsi oggi in un esperimento di riorganizzazione della vita sociale e culturale di una comunità?
“I recenti terremoti in Italia centrale hanno sottoposto gli abitanti di quei luoghi a prove severissime. Aldilà delle vittime umane, una perdita altrettanto irrecuperabile è quella del patrimonio, che segna una continuità nel tempo delle voci che si susseguono sui territori. Le storie dei sismi passati insegnano che ci sono più modi per vivere le apocalissi. C’è quello del Belice, che ha ricostruito molti siti altrove e diversamente. C’è quello del Friuli, che ha privilegiato il metodo ‘dov’era, com’era’. E poi ci sono gli scempi dell’Irpinia, e le scandalose rovine dell’Aquila, ancora lì dopo quasi otto anni.
Non è facile rinascere, per una comunità e per un territorio. Ma perché questo sia possibile, è necessario essere disposti a trasformare le ferite in racconto. Ciò può significare un cambiamento, spesso doloroso, del linguaggio con cui si descrive la propria realtà. Occorre salvare tutto ciò che è possibile salvare, ma anche sapere progettare il mutamento, se questo è una scelta evolutiva e una strategia di sopravvivenza.”