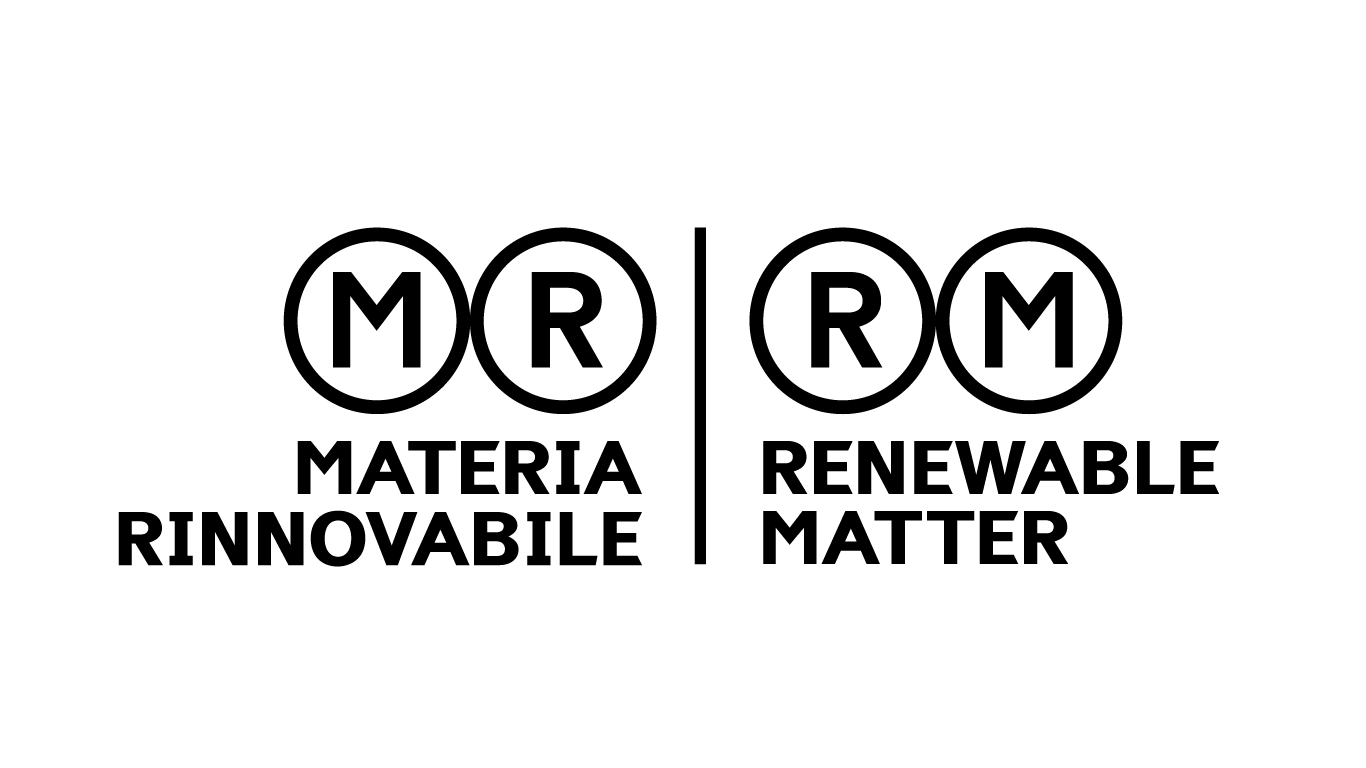Non solo vintage. I modelli di business second hand guadagnano sempre più quote nel mercato della moda, con conseguenze positive sull’impronta ecologica. Ogni giorno, però, parte di ciò che l’Occidente decide di non indossare parte con un biglietto di sola andata in direzione Africa. Bene per l’ambiente, ma non per l’economia locale.
Resale, rental, repair e remaking sono quattro modelli di business dal potenziale inespresso. Lo conferma la Ellen MacArthur Foundation nel report Circular business models: redefining growth for a thriving fashion industry (2021). Secondo le stime, la quota del second hand nel mercato globale della moda potrebbe infatti passare dal 3,5% di oggi al 23% entro la fine del decennio. L’opportunità, dal valore di 700 miliardi di dollari, garantirebbe una riduzione di 340 milioni di tonnellate di CO2 equivalente: per capirci, è più di quanto emettano annualmente nazioni come Francia o Thailandia. E non sarebbe l’unico vantaggio. Anche la biodiversità ringrazierebbe. Armadi con più abiti usati equivalgono a meno terreni per produrre materie prime, a una riduzione del consumo di acqua e a un minor inquinamento legato al trattamento delle fibre vergini.
I vestiti dell’uomo bianco morto
Moneta e ambiente si incrociano così ad angolo retto, come trama e ordito. Tuttavia, sul telaio degli impatti del mercato della moda si intrecciano anche meridiani e paralleli. Può infatti sembrare strano, ma non in tutto il mondo si chiamano “vestiti di seconda mano”.
In Ghana, per esempio, esiste un’espressione che dimostra l’estraneità dell’idea di eccesso dalla cultura di quel paese: obroni wa wu, letteralmente, “i vestiti dell’uomo bianco morto”. Sono una parte dei nostri rifiuti, sono gli indumenti che il Nord dismette, raccoglie, smista, imballa e spedisce verso i paesi in via di sviluppo. Sono così tanti da ingenerare, in chi li riceve, la sensazione che solo chi è morto potrebbe rinunciare a così tanta abbondanza di materia. È un pensiero che può nascere spontaneo in luoghi come Kantamanto, quartiere di Accra, capitale del Ghana. Laggiù, tutte le settimane, in quello che è considerato il più grande mercato di abiti usati dell’Africa Occidentale, un microcosmo di cinquemila venditori viene rifornito da milioni di capi provenienti da Stati Uniti, Europa, Cina. Obroni wa wu: i vestiti che l’uomo bianco seleziona, il cosiddetto tropical mix. Arrivano in balle da cinquanta chili l’una. Ogni volta che vengono scaricate dai container, nel mercato, si rinnova un lutto senza dress code.
In Africa i rivenditori comprano infatti a scatola chiusa. Ogni balla diventa un’eredità da accettare senza beneficio di inventario. Dentro ci potrebbe essere di tutto. Il suo contenuto, pagato anche un centinaio di dollari, potrebbe valerne migliaia oppure zero. E non senza conseguenze. “Il vestiario di seconda mano è parte di noi. Io mi vesto con abiti usati fin da quanto ero bambina”, racconta a Materia Rinnovabile Akuvi Adjabs, attivista e giornalista ghanese. “Fino a cinque anni fa andare a fare shopping a Kantamanto era piacevole e si facevano buoni affari. Oggi non c’è niente da comprare. Quasi tutti i capi sono in cattive condizioni, sbiaditi, non lavati e a volte del tutto inutilizzabili. La ragione è semplice: la maggior parte di quei vestiti è fast fashion, non sono fatti per durare. I grandi produttori del Nord globale dovrebbero partire da qui per valutare le loro strategie di responsabilità sociale d’impresa. Solo il 10% di ciò che arriva può essere rivenduto. E l’upcycling è possibile solo con il denim, il tessuto di jeans.” Tutto il resto, l’inservibile, torna a essere rifiuto. Senza organizzazione e infrastrutture per il riciclo lo smaltimento avviene in discarica o, peggio, lungo le banchine della Korle Lagoon, dove il mucchio più grande è alto quasi venti metri.
Gli impatti della moda di seconda mano sull’economia africana
Ogni anno, secondo la Divisione di statistica delle Nazioni Unite, milioni di tonnellate di abiti usati raggiungono il continente africano. Kenya, Congo, Nigeria. Dal 2019 Ruanda, Uganda e Tanzania hanno provato a bloccarne l’importazione.
Le torri di vestiti inutilizzati, come quella di Accra, ogni giorno aumentano in numero e dimensioni. Ai loro piedi, però, continua a esserci un esercito di lavoratori. Solo a Kantamanto la forza lavoro è composta da 30.000 persone. La maggior parte sono portatrici, le kayayei. Queste donne, spesso minorenni e con figli al seguito, lasciano le aree rurali in cerca di fortuna. Trasportano da un rivenditore all’altro, a volte per chilometri e per pochi dollari al giorno, balle intere di vestiti usati. Lo sfruttamento va di pari passo con gli infortuni. È chiaro che, a questo condizioni, quello del second hand è un mercato che non giova all’economia locale.
“A Berlino, durante la mia prima fashion week, mi venne chiesto perché volessi fare la stilista. Risposi che la mia missione è aiutare la comunità. Credo però che pochi abbiamo colto il senso della mia risposta”, racconta alla nostra rivista Mehmuna Schumann, fashion designer originaria del Malawi e fondatrice del marchio Afrofashion. “Più saranno i vestiti usati e meno ci sarà bisogno di persone che li producano. Se l’Africa continuerà a importare non si svilupperà mai una cultura industriale. La mia carriera ebbe inizio proprio facendo upcycling di abiti usati, che ibridavo con il cotone dei pagne e dei chitenje prodotti localmente. Questo garantiva una certa sicurezza economica alle famiglie che impiegavo.” Per Mehmuna, fare slow fashion significa creare valore sui territori e promuoverli. I suoi esempi non si fermano al Malawi. “Dopo la nascita della mia bambina, essendo lei affetta da albinismo e quindi a rischio persecuzione, ci siamo trasferiti per dieci anni in Mali. Ho iniziato a utilizzare lo straordinario cotone coltivato e filato in alcuni villaggi. Tutto il processo, non solo il profitto, andava a vantaggio della comunità. Siamo lontani dal poter competere con le industrie occidentali. Anche qui dove vivo ora, in Tunisia, le infrastrutture esistenti, ci sono anche stabilimenti italiani, alimentano produzioni delocalizzate. Le piccole produzioni locali sparse per il continente vanno messe in contatto. Solo in questo modo si può avviare, in futuro, una filiera tracciabile, autentica e sostenibile che non faccia affidamento solo sulle importazioni.”
Immagine: Belle Maluf (Unsplash)
Scarica e leggi il numero 39 di Materia Rinnovabile sulla moda circolare