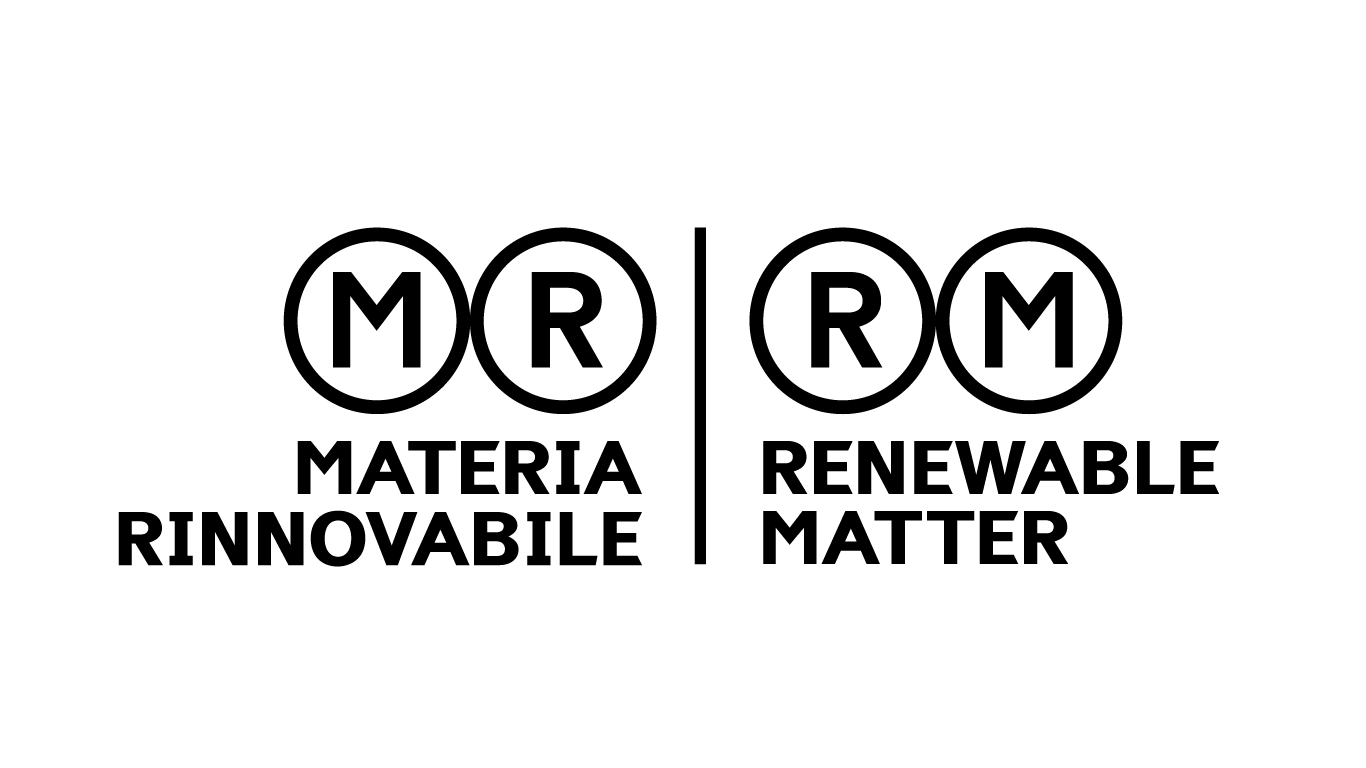C’è un altro debito pubblico che ci portiamo sulle spalle. Non meno insidioso e non meno pesante di quello delle finanze. Ed è un debito che oltretutto è assolutamente fuori controllo. Cresce di anno in anno, in buona parte perché non ne abbiamo la consapevolezza o ne sottovalutiamo largamente la portata, e quindi perseveriamo in comportamenti che determinano e aggravano la sua permanenza.
Questo debito pubblico nascosto ai più è il debito ecologico, la cui stima è resa possibile dall’introduzione, fatta all’inizio degli anni ’90 da Mathis Wackernagel e William Rees, dell’Ecological Footprint Accounting (Efa): uno strumento per misurare il bilancio ecologico delle nostre nazioni e dell’intero pianeta. Impronta ecologica e biocapacità sono le due componenti di un bilancio ecologico. Il meccanismo è semplice. L’impronta ecologica di un paese è determinata dal livello medio dei consumi, da quanto questi consumi pesano in termini di risorse naturali e servizi e dalla popolazione. In altre parole, l’impronta ecologica è un indicatore di pressione antropica.
Di contro, la biocapacità di un paese è il risultato di due fattori: la superficie di terre e acque biologicamente produttive e il loro livello di produttività biologica. Non basta infatti disporre di un vasto territorio o di molte coste per avere garanzia di alta biocapacità. Devono essere in buone condizioni e biologicamente produttivi: è evidente che un ettaro di foresta o di terreno agricolo a medie latitudini pesa più di un ettaro di savana o di steppa. E che una grande area desertica ha una bassissima biocapacità. In ogni caso, il combinato disposto di impronta ecologica e biocapacità è inesorabile. Se il consumo di risorse naturali di un paese è più grande della capacità dei suoi sistemi di fornirle, si crea una situazione di deficit ecologico, non diversamente da quanto accade per un deficit finanziario di bilancio quando le spese sono superiori alle entrate.
Gli studi di Wackernagel e Rees ci dicono che un paese può cadere in deficit ecologico per tre ragioni: uso eccessivo delle sue risorse, importazione di risorse rinnovabili che non produce in maniera sufficiente, sbilanciamento dell’impronta di carbonio. Solo se l’impronta ecologica è più bassa della capacità dei suoi ecosistemi di rigenerare le risorse e i servizi naturali il paese non va in “riserva”. Altrimenti va in rosso. Ed è questo il caso di buona parte del nostro pianeta. In particolare delle aree più popolate, quelle che si trovano in ecosistemi sensibili o che hanno una società ad alta intensità energetica.
È il caso del Mediterraneo che – come rivela uno studio di Alessandro Galli, Martin Halle e Nicole Grunewald del Global Footprint Network di Ginevra – mostra una preoccupante tendenza a uno strutturale deficit ecologico. “Le nostre conclusioni – osservano gli autori – sono che la regione mediterranea usa attualmente due volte e mezzo più risorse naturali e servizi ecologici di quanto i suoi ecosistemi possano produrre. Quando il consumo eccede la disponibilità dei sistemi naturali locali, la sola risposta possibile laddove non si intenda ridurre i consumi è rivolgersi all’estero per soddisfare la domanda. Ed è precisamente quello che da tempo avviene nell’area mediterranea”.
La pressione antropica è molto alta. Nei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum dal 1961 al 2010 la domanda pro capite di risorse e servizi è cresciuta del 24%. Nello stesso periodo l’impronta ecologica delle attività produttive è cresciuta del 54% e la popolazione è salita del 102%: un vero boom, soprattutto nei paesi della “sponda sud”. Questo ha prodotto un aumento dell’impronta ecologica dell’intera regione di oltre il 211%.

Certo, non tutti gli indicatori sono negativi. Grazie a miglioramenti nelle pratiche agricole anche la biocapacità netta è cresciuta, ma solo del 59%. La crescita della popolazione ha però vanificato questo progresso, perché la biocapacità pro capite è scesa del 21% dal 1961 al 2010. Produciamo di più dai nostri sistemi naturali, ma ancora non abbastanza per sostenerci solo su di essi. Molti potrebbero obiettare che un aumento della biocapacità non sempre è stato un buon affare nel lungo periodo, perché spesso per ottenerla sono stati portati in produzione terreni non adatti o marginali o sono state attuate pratiche agricole che hanno stressato i terreni. E questo significa che quel (poco) che sembra buono nel breve termine non è detto che lo sia nel lungo, e non porti poi a un declino della produttività. Ma anche a prescindere da questo e prendendo per positivo l’aumento di biocapacità, il piatto mediterraneo piange assai.
“La regione mediterranea – scrivono gli autori – era già in una situazione di deficit nel 1961 e adesso il deficit è molto cresciuto. La biocapacità della regione oggi fornisce al massimo la metà delle risorse naturali e dei servizi che vengono consumati. E questo significa che è necessario importare il resto, innanzitutto da Usa, Cina e paesi europei non mediterranei”. Dei 24 paesi contenuti nel lavoro di Galli, Halle e Grunewald i cinque paesi che contribuiscono di più al deficit ecologico regionale sono la Francia, l’Italia, la Spagna, la Turchia e l’Egitto: assieme totalizzano il 73% della domanda. Nonostante un marcato effetto della crisi economica, ben visibile nel confronto tra il 2007 e il 2009, la pressione resta sostenuta, e peraltro la crisi e il crollo del Pil che ne è derivato non sono certo una soluzione strutturale al problema. Quando il ciclo economico si invertirà, la pressione tornerà a crescere se non si attueranno politiche diverse.
Nel 2010 tutti e 24 i paesi della regione mediterranea erano in una situazione di deficit ecologico. Quelli con la più alta impronta ecologica sono la Francia (4,7) seguita da Slovenia (4,6), Italia e Portogallo (4,5), Grecia e Malta (4,4) e Cipro (4,2). Sull’altro lato della scala, quella dei virtuosi, ci sono Palestina, Marocco, Siria, Algeria e Montenegro: come si vede, sono tutti paesi meno sviluppati, che consumano meno non perché hanno scelto cosi ma perché non possono permettersi troppo consumismo.
L’altra matrice è la biocapacità. I paesi meglio posizionati sotto questo profilo sono Francia, Croazia, Montenegro, Slovenia e Bosnia Erzegovina, mentre quelli con una bassa biocapacità sono Palestina, Israele, Giordania, Cipro e Libano: qui, assieme ad altri fattori, a pesare a sfavore dei meno produttivi è la carenza di acqua delle sponde sud ed est del Mediterraneo. Anche i virtuosi hanno però poco da festeggiare. Occorre infatti notare che dal 1961 al 2010 la capacità degli ecosistemi di soddisfare la domanda è scesa su base pro capite in tutti e 24 i paesi e copre la domanda in percentuali che vanno dall’84% in Croazia, al 64% in Francia, al 58% in Turchia, al 35% in Spagna, al 32% in Grecia, al 22% in Italia fino a meno del 10% a Cipro, Israele e Libano. La dipendenza dalle importazione di risorse è passata così dal 21% del 1961 a circa il 50% attuale. Se in Turchia è del 29%, in Marocco è del 32%, in Albania del 33%, in Croazia del 35%, in Francia del 39%, in Spagna del 53%, in Grecia del 60%, in Italia del 72% e balza all’85% in Libano, all’88% in Israele e al 90% a Malta. E non è solo un problema strettamente ecologico. Questa situazione espone i paesi mediterranei, e specialmente quelli che devono ricorrere a massicce importazioni, alla volatilità dei mercati e alla dinamica dei prezzi, specie delle materie prime, che è passata negli ultimi dieci anni da un trend in declino a un marcato aumento. Dal 2000 al 2008 l’indice World Bank delle commodity è triplicato in termini reali per cibo, prodotti agricoli, metalli e minerali. Chi ha un deficit ecologico maggiore, è più esposto.
La necessità di ridurre l’impronta ecologica è quindi al tempo stesso una necessità ambientale ed economica. La salute dell’ambiente e il corretto bilanciamento nell’uso delle risorse evitano la perdita di un patrimonio che dovremmo consegnare alle generazioni future, ma al tempo stesso sono una garanzia per evitare shock sui prezzi e per non essere esposti a crisi geopolitiche determinate dalla troppa dipendenza dall’estero per beni che sono concentrati – si pensi a quelli energetici ma anche a certi minerali – in alcuni paesi. Il prezzo per un uso disinvolto delle risorse è quindi duplice. È ambientalmente sbagliato ma anche economicamente avventato e nel lungo termine insostenibile. Gli economisti dovrebbero considerarlo: anche per quanto riguarda le risorse naturali, non ci sono pasti gratis.
Alessandro Galli, Martin Halle e Nicole Grunewald, “Physical limits to resource access and utilisation and their economic implications in Mediterranean economies”, Environmental Science & Policy, v. 51, agosto 2015; doi:10.1016/j. envsci.2015.04.002
Immagine in alto: Particolare tratto da William Faden, Composite Mediterranean, 1785