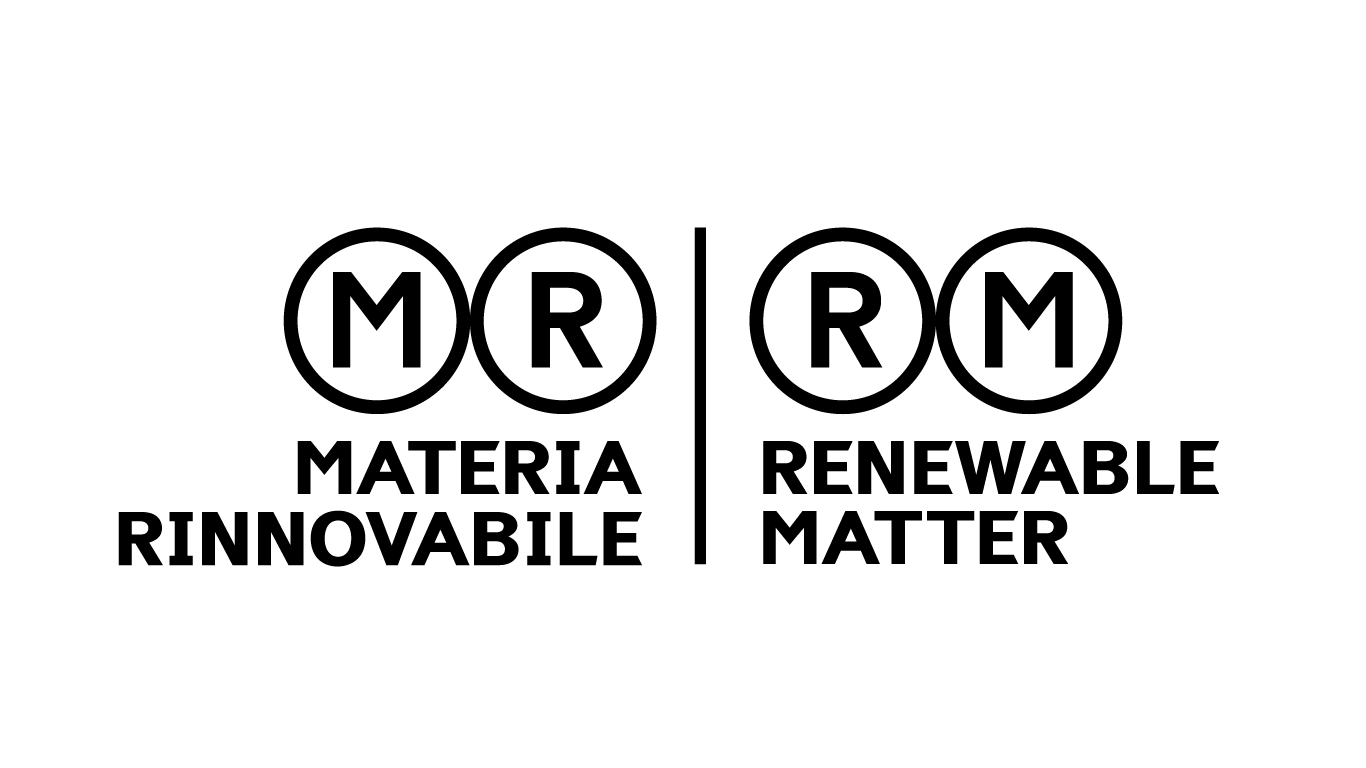L’Italia delle città ricche di storia, della variegata tradizione enogastronomica, dei paesaggi suggestivi; l’Italia della moda e del design; l’Italia della mafia, delle politica burina, dell’abusivismo edilizio. L’Italia è certamente celebre per svariate cose e, tra le tante, è conosciuta anche per essere il Paese dei borghi. Dai piccoli centri medievali marchigiani, con le alte torri e gli imponenti bastioni, a quelli liguri a picco sul mare e sferzati dal vento. Dagli agglomerati trentini in legno e pietra, arroccati sulle montagne e dal sapore un po’ austriaco, agli abbaglianti villaggi pugliesi dalle chiese barocche e il profumo di mandorle. Ricchi di storia e di natura, i piccoli centri vengono spesso “estetizzati”, dipinti come perle di grande fascino e intimo splendore. Ma a uno sguardo più attento, dietro questo idillico scenario, si nascondono le crepe di una realtà più scomoda e complessa.
Borghi: quali borghi?
Il MIBact definisce “Borghi” i comuni italiani con al massimo 5000 abitanti caratterizzati da un prezioso patrimonio culturale, le cui conservazione e valorizzazione sono fattori di grande importanza per il sistema Paese. Ma in Italia convivono borghi e borghi. Da una parte si trovano infatti quelli più brandizzati, i “più belli”, che sono riusciti ad emergere turisticamente ed economicamente, valorizzando il grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni di cui sono portatori. Dall’altra – e per la maggior parte - ci sono quei paesi invisibili (così come li definisce l’antropologa Anna Rizzo nell’omonimo libro), quei luoghi difficili da vivere, da cui molti fuggono e alcuni, faticosamente, ritornano.
Visibili o no, i borghi spesso ricadono nelle cosiddette aree interne, quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta e di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), ma potenzialmente ricche di risorse ambientali e culturali. Sono quasi 4000 i comuni italiani che si trovano in queste aree, che coprono il 58,8% della superficie nazionale e sono abitate da circa 13,4 milioni di persone, il 22,7% della popolazione residente in Italia nel 2021. Questi comuni sono differenziati come intermedi, periferici e ultraperiferici a dipendenza se distano rispettivamente più di 28 minuti, 41 o 67 dal polo più vicino. Il “polo” deve presentare almeno una stazione ferroviaria, almeno un ospedale e un’offerta scolastica secondaria articolata.
Le criticità del vivere nelle aree interne
I paesi situati nelle terre dell’osso (anche così sono chiamate le aree interne) ormai da anni devono far fronte all’abbandono, all’invecchiamento della popolazione, alla carenza di occupazione, alla mancanza di infrastrutture e di servizi. Strade tortuose e poco manutenute rendono gli spostamenti interminabili; autobus centellinati viaggiano soltanto a orari scolastici e scompaiono nei fine settimana. I già piccoli negozi di generi alimentari chiudono perché i proprietari vengono a mancare o se ne vanno. L’offerta formativa è ridotta all’osso, garantendo – e non sempre - la presenza sui territori delle sole scuole primarie: per le medie e le superiori bisogna percorrere lunghe distanze, con mezzi, molto spesso, inefficienti. L’ambulanza ci impiega dai 45 minuti in su per arrivare e l’ambulatorio medico ha la muffa alle pareti e le ragnatele al soffitto. La diminuzione della popolazione ha infatti sancito anche l’abbandono dei presidi sanitari. La connessione internet è intermittente, alcune volte scadente, inasprendo quel digital divide che penalizza fortemente i giovani. I grandi assenti sono anche gli spazi di confronto e aggregazione: quegli spazi che riattivano le comunità e riaccendano il piacere delle relazioni. Un quadro non certo felice, in cui non tutti, ma molti dei borghi italiani rientrano. Schiacciati da un ventaglio di criticità che sono diventate ormai sistemiche e strutturali.
Il tentativo di contrasto allo spopolamento nella Strategia nazionale per le Aree Interne
Di fronte al trend di abbandono che da decenni continua e si intensifica progressivamente, si è arrivati nel 2013 a proporre una Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI): una politica che voleva contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico propri di queste zone, mettendo a disposizione delle risorse finanziarie provenienti da fondi europei e nazionali.
“Nel 2014 è stato creato un comitato tecnico nazionale per le aree interne, che aveva la funzione di lavorare a stretto contatto con tutte le aree progetto selezionate dalle strategia”, spiega Giovanni Carrosio, professore di sociologia ambientale e territoriale presso l’Università di Trieste. La strategia aveva infatti individuato 72 aree d’intervento, comprendenti 1060 comuni con una popolazione di poco meno di 2 milioni di abitanti. Lo scopo del comitato era quello di instaurare un rapporto collaborativo e dialettico tra Stato e territori, attraverso l’apertura di tavoli di lavoro per far emergere i bisogni specifici delle comunità. “In ogni area, tecnici statali e portatori di interesse locali hanno costruito la propria strategia di sviluppo lungo degli assi principali, intervenendo sullo sviluppo locale e sull'adeguamento dei servizi di mobilità, di salute e di istruzione.” La strategia prevedeva di lavorare sulla riorganizzazione dei servizi: capire se tenere aperti i tanti e piccoli plessi scolastici di queste aree oppure decidere di costruire una scuola di valle, organizzando un sistema di mobilità condivisa per i bambini; ma anche di sviluppare servizi di prossimità inserendo la figura dell’infermiere di comunità e implementare sistemi di mobilità flessibile a chiamata. Risultati? “È troppo presto per dire se la strategia ha invertito i trend di spopolamento delle aree interne, perché per molte azioni si stanno ancora spendendo i finanziamenti messi a disposizione – continua Carrosio – Inoltre sono emerse delle criticità nel momento in cui c’è stato il confronto con le Regioni, che avevano precedentemente redatto i programmi operativi regionali, i cosiddetti POR, in cui erano già stati definiti gli interventi di spesa dei fondi strutturali europei”.
L’azione puntiforme del PNRR
Poi è arrivata la pandemia e a questa strategia si sono affiancati gli investimenti del PNRR, che ha destinato quasi 420 milioni di euro a 21 borghi a rischio di abbandono e altri 363 milioni di euro a 289 comuni al di sotto dei 5000 abitanti. Sono stati 310 i borghi beneficiati, a fronte dei 1800 che hanno fatto richiesta.
A titolo esemplificativo, tra i vincitori c’è stato Elva, nella provincia di Cuneo: 83 abitanti, 1600 metri sopra il livello del mare, più di 60 km dalla prima stazione del treno e dal primo ospedale. Qui si è puntato a riattivare un’ampia offerta formativa focalizzata sull’ambito montano: in progetto ci sono un centro studi di Apicultura e una Scuola di pastorizia; una "Scuola di ri-abitare le Alpi" del Politecnico di Torino, un osservatorio astronomico e un centro Saperi tradizionali delle produzioni alpine, quest’ultimo in partenariato con l'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo. I lavori sono iniziati, ma, come per molti altri progetti, i problemi di avanzamento sono i soliti che si riscontrano sul suolo italiano: la complessità burocratiche delle procedure e la mancanza di risorse umane per gestire e progettare gli interventi.
Quale futuro per le aree interne?
Nel 2021 si è aperto poi il nuovo ciclo della SNAI, che ha visto l’ammissione di 43 nuove aree interne. Le risorse sono quindi sul tavolo e i lavori sono partiti, anche se con le solite lentezze e complessità. E soprattutto con la solita mancanza di ascolto e di dialogo tra le istituzioni.
Le domande sorgono quindi spontanee: l’azione politica è adeguata? Nel caso del bando Borghi del PNRR si è agito attraverso azioni puntiformi: sono stati individuati, tra migliaia di comuni, un numero esiguo di poli attrattori, da rendere “velocemente” cantierabili, senza agire veramente sulle carenze strutturali di questi territori “svantaggiati”. “Per le aree interne bisognerebbe invece ragionare in termini di lungo periodo e quindi lo Stato dovrebbe provare a fare degli investimenti anche rischiosi, come se fosse un’impresa – commenta Carrosio – Lo stato dovrebbe fare un investimento sociale ad esempio costruendo un asilo nido anche se non ci sono i numeri né delle soglie di economicità. Dovrebbe provare a tenerlo aperto e vedere se, grazie alla presenza del servizio, c’è un ritorno della popolazione. In Italia esistono già casi vincenti in cui questo schema ha funzionato e ha riattivato delle comunità”.
La strategia sta quindi facendo il suo corso, ma per ora non si può ancora prevedere quale sarà il destino delle aree interne: se continuerà il trend di spopolamento e fuga verso le città e i suburbi o se si accenderà una scintilla, che rivitalizzi i luoghi lasciati ai margini. Certo c’è ancora molto lavoro da fare per dare risposta ai bisogni di territori attraversati da profonde mancanze. La politica pubblica dovrà essere capace di incidere su questi territori, di costruire processi inclusivi e partecipativi, che facciano divampare quella scintilla in un fuoco vivificatore.
Immagine: San Piero Patti, Messina (ph Dean Milenkovic, Unsplash)